 |
|
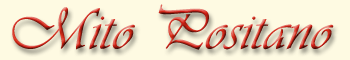 |
|
L'ARTE A POSITANO
|
|
|
|
La MODA |
ETRUSCHI
LE FONTI
Riportiamo brevemente un profilo degli studiosi antichi
che ci hanno tramandato la storia del popolo etrusco. Ricordiamo che la cultura
etrusca ebbe un forte “scontro” con quella romana. A tale proposito si tenga
presente che alcuni storici si sono schierati apertamente a favore della cultura
romana (cioè quella vincitrice), altri contro. Per tale ragione, le notizie
storiche sugli Etruschi che ci sono pervenute nel corso dei secoli sono state in
alcuni casi trionfalistice e leggendarie, in altri scarne e deludenti.
Dionisio di Alicarnasso
Retore e storico greco vissuto fra il 60
a. C. e la fine del I sec. a. C., soggiornò per molti anni a Roma, dove tenne
una scuola. Oltre ad opere di retorica, scrisse un'importante opera storica:
Antichità romane, composta in 20 libri, dei quali possediamo i primi 10, mentre
il libro XI ci è giunto lacunoso. Il lavoro arrivava fino all'inizio della prima
guerra punica, partendo dalle fasi più antiche della preistoria e della storia
romana.
Diodoro Siculo
Vissuto tra il I sec. a. C. ed il I
d.C., lo storico Diodoro Siculo, il cui nome significa "dono di Dio", nacque ad
Agira e visse a Roma in età Cesarea ed Augustea. Considerato dai greci "padre
della storia" insieme ad Erodoto, Diodoro volle e seppe esprimere la sua cultura
di lingua greca tanto da essere spesso chiamato "storico greco". Viaggiò molto
per i tre continenti conosciuti per approfondire i suoi studi. Tornato a Roma,
utilizzò le sue nuove conoscenze per scrivere una colossale storia universale,
dal titolo "Biblioteca" in quaranta volumi, dei quali restano soltanto quindici
volumi. La sua opera, tradotta in diverse lingue, tratta dalla tecnica egizia
della mummificazione alla scienza urbanistica mesopotamica, dal periodo
precedente la guerra di Troia alle conquiste di Giulio Cesare in Gallia. Alla
sua fonte hanno attinto Marco Polo, che lo cita ne "Il Milione", Salzano, Holm e
Di Berenger. Innegabili sono i meriti della sua opera che ci ha tramandato
avvenimenti mai raccontati e che altrimenti sarebbero andati perduti. Plinio il
Vecchio lodò il contenuto della sua opera scrivendo pure che Diodoro non
favoleggiò, ma trasse i fatti reali dalla somma delle tradizioni locali e, dove
non era possibile per assenza di documenti, da accurate deduzioni.
Dione Cassio
Dione Cassio, ovvero Dio Cassius Cocceianus (ca.
150-235), storico e politico romano, nato a Nicea, in Bitinia; suo nonno materno
fu il filosofo stoico Dione Crisostomo (ca. 40-112). Dione Cassio ebbe incarichi
amministrativi a Roma sotto gli imperatori Commodo, Pertinace, Settimio Severo e
Alessandro Severo; fu due volte console (220 e 229). Dione è meglio conosciuto
come l'autore di una storia di Roma in 80 libri scritta in greco. Ne restano
interi solo 18, ma frammenti di alcuni degli altri libri e successive epitomi di
altri scrittori sono arrivate sino a noi. Le opere di Dione sono tutte di
primaria importanza per la storia degli ultimi anni della repubblica romana ed i
primi anni del'impero.
Eforo
Storico greco nato a Cuma
eolica all'inizio del IV sec. a. C. La sua opera principale fu una storia
universale della Grecia in 29 libri, il trentesimo venne aggiunto dal figlio. La
narrazione partiva dal mitico ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso sino
all'assedio di Perinto ad opera di Filippo II (341/340 a. C.). Il suo lavoro
costituì una fonte importante per Diodoro Siculo e Strabone, venendo utilizzata,
inoltre, da Polieno, Pompeo Trogo e Plutarco.
Erotodo
Storico
greco nato ad Alicarnasso, forse intorno al 484 a. C., e morto non prima del 430
a. C., non si sa se a Thurii, come riporta la breve biografia della Suda, o ad
Atene, dove potrebbe essere ritornato a conclusione dei suoi viaggi nella Grecia
continentale, in Egitto, Fenicia, Mesopotamia, in Magna Grecia L'opera di
Erodoto ci è giunta con il titolo di Historìai (Storie), desunto dalle prime
parole del proemio. Fu probabilmente il filologo Aristarco di Samotracia a
dividerla in nove libri, a ciascuno dei quali, successivamente, venne dato il
nome di una musa. Vi è esposta la storia di Lidi, Persiani, Egiziani, Babilonesi
e Sciti. Gli avvenimenti del racconto principale riguardano gli ottanta anni di
storia che vanno dall'ascesa al trono di Creso e Ciro (560-559 a. C.) alla
battaglia di Micale e all'occupazione di Sesto (479 a. C.). La composizione
dell'opera risulta piuttosto complessa soprattutto per le numerose digressioni
che partendo dal racconto principale arrivano ad occupare più capitoli se non un
intero libro.
Floro L. Anneo (o Giulio)
(secc. I-II d.C.)
Originario dell'Africa, a somiglianza degli oratori greci della "seconda
sofistica", ebbe un'attività di conferenziere itinerante nelle province. Uno dei
temi da lui affrontato era la questione se "Virgilio era oratore o poeta",
problema sul quale ci è stato conservato uno svolgimento redatto in forma di
dialogo.
Finì per stabilire a Roma la sua dimora, durante l'impero di
Adriano, e nella città compose i suoi 2 libri "sulle guerre romane"
(specificamente, il I relativo alle guerre esterne, il II alle guerre civili del
I sec. a.C.), comprende 7 secoli di storia militare romana, dalla fondazione
dell’Urbe ad Augusto. Sotto la vernice del presunto storico, traspare però
l'atteggiamento del rètore: Floro elogia più che raccontare. Questo
conferenziere, sempre in cerca di brillanti amplificazioni, immagina di
paragonare la vita del popolo romano a quella di un essere umano le cui
differenti età si caratterizzano per una crescita, una maturità e una decadenza,
salvo poi concludere, per trarsi d'impaccio, che la dinastia antonina aveva
restituito a Roma la sua giovinezza. Quest'opera "puerile" (anche nella
struttura molto semplice del suo latino) ci è stata conservata sotto il titolo,
davvero improprio, di "Epitoma de Tito Livio" ("Compendio di Tito Livio").
Livio Tito
Scarse le notizie della sua vita. Di lui non si conosce
il cognome. Si sa che nacque a Padova nel 59 a.C. Presto si trasferì a Roma,
dove entrò nelle grazie dell'imperatore Augusto, che gli affidò, a quanto pare,
l'educazione culturale del nipote adottivo Claudio, futuro imperatore. Ebbe una
figlia ed un figlio, Tito, divenuto poi famoso geografo. Di idee conservatrici,
improntò la sua vita e la sua opera ad equilibrio morale e religioso e spirito
patriottico. Il suo essere un convinto pompeiano, e quindi critico nei confronti
di Cesare, non gli impedì di comprendere lo spirito nuovo dei tempi, di ammirare
l'opera riformatrice imperiale e di celebrare la pace augustea e la figura
stessa dell'imperatore. Morì a Padova nel 17 d.C.
Pochi frammenti ci
sono pervenuti dei suoi scritti filosofici e retorici, che noi conosciamo
soprattutto tramite le testimonianze di successivi autori come Quintiliano e
Seneca. Ma il suo capolavoro è rappresentato dalle Storie. Iniziato tra il 27 ed
il 25 a.C., occupò tutta la sua vita.
Originariamente il titolo doveva essere
Ab Urbe condita libri e comprende in 142 libri annalisticamente, anno per anno o
per gruppi di anni, la storia di Roma dalle origini sino al 9 a.C., anno della
morte di Druso Maggiore (figliastro di Augusto), il governatore delle Gallie che
combatté contro le popolazioni germaniche. E' probabile che l'opera dovesse
comprendere, nel disegno originario, 150 libri e concludersi con la morte di
Augusto (14 d.C.). L'autore la pubblicò, man mano che procedeva nella
composizione, per sezioni staccate, raggruppandole in decadi (10 libri) o
pentadi (5 libri), corrispondenti per lo più a determinati cicli di fatti
storici. Dei 142 libri ne avanzano solo 35 : le decadi 1a, 3a, 4a e i primi
cinque libri, lacunosi, della 5a. Degli altri 107 rimangono alcuni frammenti ed
i riassunti che vennero fatti di tutta l'opera, forse ad uso scolastico, ad
eccezione dei libri 136 e 137.
Macrobio Ambrogio
Teodosio
Ambrogio Macrobio Teodosio visse nel V secolo. Egli si
rivela africano da certe particolarità linguistiche e probabilmente fu il
Macrobio proconsole in Africa nel 410. Il più e il meglio della sua erudizione è
raccolto nei sette libri dei Saturnalia, una specie di enciclopedia del sapere
filosofico, centrata sulla figura di Virgilio; inoltre aveva scritto prima due
libri di Commentarii al Somnium Scipionis ciceroniano. L'una e l'altra opera
sono dedicate al figlio Eustachio.
Plinio il Vecchio
Gaio
Plinio Secondo, detto Plinio il Vecchio, nacque a Como nel 23 d. C., fu il più
grande naturalista romano. Morì durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. a
Stabia. La sua fama è legata all'opera monumentale Naturalis Historia in 37
libri, tutti pervenuti fino a noi. Si tratta di una vera e propria enciclopedia
in cui Plinio si propose di compendiare l'intero scibile umano: cosmologia e
geografia fisica; geografia ed etnologia; antropologia e fisiologia; zoologia;
botanica; botanica in relazione al suo impiego in medicina; zoologia in
relazione all'impiego in medicina; metallurgia e mineralogia, con ampie
digressioni sulla storia dell'arte.
Properzio Sesto
(Assisi?
50 ca a.C. – Roma, dopo il 15 a.C.) Nacque da agiata famiglia di rango equestre
che però, dopo la guerra perugina del 41, perse buona parte dei suoi averi.
Morto il padre, fu condotto dalla madre a Roma, dove fu avviato alla carriera
forense. Ma Properzio rivelò precoce attitudine per la poesia: già al 28 a.C.
risale la pubblicazione del suo I libro di elegie, il cosiddetto "monobiblos"
("libro unico"), intitolato dal nome della donna amata (Cynthia), secondo la
tradizione dei poeti alessandrini. Il successo che gli arrise spinse Mecenate ad
ammetterlo nel suo celebre "circolo". Qui, Properzio conobbe i più importanti
poeti dell'epoca: da Virgilio a Ovidio, al quale era solito recitare i propri
"roventi" ("ignes") versi. Difficili, invece, i rapporti con Orazio,
evidentemente a causa dei molto diversi ideali poetici. Tibullo e Properzio
sembrano poi ignorarsi del tutto (gelosia reciproca?).
Uno dei primi amori
cantati dal poeta fu la giovane schiava Licinna, ma forse l'unico avvenimento
davvero importante nella sua vita fu l'incontro con Cinzia. Hostia era il vero
nome della donna, come ci riferisce Apuleio: il nome Cinzia sembra collegarsi
con Apollo e Diana, che nacquero a Delo, sul monte Cinto (si ricordi, a
proposito, anche la Delia di Tibullo). Cinzia, una fascinosissima donna, forse
più grande di Properzio, dagli occhi neri e dai capelli fulvi, colta e mondana,
elegante, amante della danza, della poesia, ma anche di facili avventure d'amore
(e dunque costituzionalmente infedele), dominò incontrastata nell'animo del
poeta, nonostante il tormento continuato di un rapporto reso difficile dalla
stessa eccessiva intensità della passione. Si amarono, talora "nevroticamente",
per quasi cinque anni. Cinzia morì intorno al 20 a.C., ma, dopo la sua
scomparsa, la presenza e il desiderio di lei si fecero ancora più acuti nella
mente del poeta. Dunque, una vera e definitiva "rottura" nel rapporto non ci fu
mai: nonostante le due ultime elegie del III libro, quelle che vorrebbero
segnare il "discidium", la separazione definitiva; nonostante la stessa morte di
lei.
Silio Italico Tiberio Cazio Asconio
(Padova?, 25 ca –
Campania 101 d.C.) Senatore, cortigiano di Nerone, console nel 68, noto durante
i periodi più cupi della tirannide come delatore. Sotto Vespasiano, fu
proconsole d'Asia. Coltivò la poesia nella vecchiaia, ritiratosi a vita privata.
Colpito da un male incurabile, si lasciò morire di fame.
Stabone
La data di nascita di Strabone, con buona probabilità, può essere stabilita
nel 64/63 a.C., nella provincia romana di Amaseia, nel Ponto. Originario di una
nobile famiglia, anticamente legata al re Mitridate, Strabone ebbe a
disposizione un patrimonio notevole che gli diede la possibilità di ricevere
un'ampia istruzione e di dedicarsi, per tutta la vita, ai viaggi e agli studi.
La maggior parte delle notizie biografiche si desumono dalla stessa Geografia.
Al 44 a.C., anno della morte di Cesare, risale il suo primo soggiorno a Roma
(XII 6,2), dove fu allievo del celebre Tirannione, a sua volta originario del
Ponto. Personalità di spicco nella vita culturale romana di quegli anni - tra
l'altro fu il maestro dei figli di Cicerone - Tirannione era un grammatico di
formazione peripatetica e, in particolare, esperto di 'Geografia', come ricorda
lo stesso Cicerone (Lettere ad Attico, II 6). A Roma, Strabone poté ricevere
un'ampia istruzione filosofica caratterizzata dall'eclettismo: oltre a Senarco
di Seleucia, un altro filosofo peripatetico, frequentò anche lo stoico Posidonio
di Apamea, vissuto tra il 135 e il 51 a.C., i cui scritti, amplissimi per numero
e argomenti trattati, e oggi perduti, possono essere considerati come importante
fonte di numerosi autori greci e latini, da Cicerone a Seneca, da Galeno ad
Ateneo, Diogene Laerzio, fino a Simplicio e Stobeo, oltre allo stesso
Strabone.
Tra il 35 a.C. e il 7 d.C., sono documentati sempre nella
Geografia, ulteriori soggiorni a Roma, e altri viaggi nelle provincie e le città
del nascente impero romano. Talora Strabone accompagò anche personalità di rango
della classe dirigente romana: in ogni caso non sembra che abbia mai compiuto
viaggi con la finalità di raccogliere notizie 'autottiche' da inserire nella
propria opera, compilata, essenzialmente, attraverso la consultazione di fonti
scritte; né d'altro canto ricoprì mai direttamente ruoli di rilievo all'interno
dell'amministrazione romana. In breve, nella biografia di Strabone non si
ricordano episodi di grande rilievo, né particolari esperienze: fu una vita da
'studioso', alquanto appartata rispetto ai tumultuosi anni che videro la
trasformazione della 'repubblica' romana nell'assetto imperiale augusteo.
Incerta la data di composizione della Geografia. Sicuramente l'opera fa seguito
ai Commentari Storici in 47 libri oggi perduti - ne restano solo frammenti di
tradizione indiretta - che proseguivano il corso della narrazione di Polibio,
incentrata sul periodo 264-200 a.C. Vari riferimenti e dati interni, in ogni
caso, come per es. alcuni cenni all'impero di Tiberio (14-37 d.C.) e ad eventi
riconducibili al 21 o al 23 d.C. (cfr. XVII 3,7.9.25), inducono a ipotizzare il
periodo compreso tra il 17 e il 23 d.C. per la redazione dell'opera, dunque
verso la fine della lunga vita di Strabone, probabilmente pubblicata solo dopo
la sua morte, avvenuta intorno al 24 d.C.
Svetonio Gaio Tranquillo
(Algeria o Roma, 70 d.C.? – 140? ca d.C.) Della sua vita possediamo
poche notizie, desumibili soprattutto dalle sue stesse opere e da Plinio, che in
una lettera a Traiano ne sottolinea la rettitudine e l'erudizione. Nato da una
ricca famiglia dell'ordine equestre, Svetonio rifiutò tuttavia la carriera di
amministratore o di soldato riservata in genere a quelli del suo rango. Uomo
dedito agli studi, intimo amico di Plinio il Giovane (il quale lo introdusse
nelle simpatie di Traiano, facendogli anche conferire lo ius trium liberiorum,
una sorta di sussidio familiare che in casi eccezionali veniva concesso anche a
scapoli benemeriti), nonché avviato alla carriera retorica e forense, lo storico
consacrò tuttavia tutta la sua vita a ricerche erudite che, per certi aspetti,
richiamano quelle di Varrone: ma la sua attività - come vedremo - si limitò
quasi interamente al genere biografico.
Grazie all'amicizia del prefetto del
pretorio Setticio Claro (anch'egli amico di Plinio, sopravvissuto a
quest'ultimo, e che avrebbe continuato comunque a proteggere il nostro autore),
intorno al 120 Svetonio riuscì ancora a diventare segretario "ad epistulas"
(incaricato cioè della corrispondenza) nei servizi dell'imperatore Adriano. A
quest'alto incarico egli poté essere chiamato dopo aver dato buona prova delle
sue qualità di funzionario amministrativo, prima come sovrintendente di tutte le
biblioteche pubbliche di Roma, poi come "a studiis" (quasi un nostro ministro
della cultura e dell'istruzione). Tutte queste mansioni, e in special modo
l'ultima in ordine di tempo (quella di segretario), gli permisero di accedere
liberamente agli archivi del Palatino, per cui le sue informazioni ci hanno
permesso di ricostruire e di conservare documenti che, senza di lui, sarebbero
andati completamente perduti. Nessun altro storico, infatti, poteva averne
conoscenza.
Dopo il rovescio politico del suo protettore, tuttavia, anche
l'incarico di Svetonio presso la corte non durò molto a lungo. Nel 122, Adriano
lo allontanò con un pretesto, perché, a quanto pare, alcuni dignitari, e lui fra
gli altri, avevano instaurato un'eccessiva familiarità nell'ambiente
dell'imperatrice Sabina. Svetonio, così, trascorse gli ultimi anni della sua
vita immerso negli studi ed attendendo alla pubblicazione delle sue vaste e
numerose opere.
Tacito Publio (o Gaio?) Cornelio
(55 d.C.? ca – 120
ca) Origini nobili. Molto incerti e lacunosi sono i dati biografici di T. (a
partire già dai suoi "tria nomina"): nacque probabilmente nella Gallia Narbonese
(ma forse a Terni, o addirittura nella stessa Roma), da una famiglia ricca e
molto influente, di rango equestre. Studiò a Roma (frequentò probabilmente anche
la scuola di Quintiliano), acquistò ben presto fama come oratore (dovette essere
anche un valentissimo avvocato), e nel 78 sposò la figlia di Gneo Giulio
Agricola, statista e comandante militare.
Iniziò la carriera politica sotto
Vespasiano e la proseguì sotto Tito e Domiziano; ma, come Giovenale, poté
iniziare la carriera letteraria solo dopo la morte dell'ultimo, terribile,
esponente flavio (96 d.C.), sotto il cui principato anche il nostro autore, come
altri intellettuali del resto, non dovette vivere momenti certo tranquilli.
Questore poi nell’81-82 e pretore nell'88, T. fu per qualche anno lontano da
Roma, presumibilmente per un incarico in Gallia o in Germania. Nel 97, sotto
Nerva, fu console (anche se in veste di supplente) e pronunciò un elogio funebre
per Virginio Rufo, il console morto durante l'anno in carica. Abbandonò poi
decisamente oratoria e politica (ebbe solo un governatorato nella provincia
d’Asia, nel 112-113), per dedicarsi totalmente alla ricerca storica. Fu intimo
amico, nella vita e negli studi, di Plinio il Giovane.
Tiberio Claudio
Druso Nerone
(Imperatore di Roma) Tiberio Claudio Druso Nerone era
figlio di Antonia - figlia a sua volta del generale Marcantonio - nipote in
linea paterna di Livia Drusilla - moglie di Augusto - and fratello di Germanico.
Sposò prima Valeria Messalina poi sua nipote Agrippina, madre di Nerone. Nel 41
d.C, dopo la morte di Caligola, diventò imperatore per caso, e di mostrò uno dei
migliori Cesari di Roma.
Fu uno degli ultimi profondi conoscitori della
lingua etrusca e scrisse una monumentale storia di questo popolo - completa di
grammatica (Tyrrenica) - che è andata completamente perduta. Ordinò di costruire
il Porto di Ostia e cominciò il prosciugamento del lago di Fucino, opera che
verrà portata a compimento soltanto nel nostro secolo. Nel 43 d.C. conquistò la
Britannia. La sua ultima moglie, Agrippina, lo uccise nel 54 d.C, con una
porzione di funghi avvelenati per mettere sul trono il figlio Nerone.
Tucidide
Storico nato ad Atene verso il 460 a.C. Molto poco si
conosce della sua vita e le scarse notizie sono per lo più deducibili dalle sue
opere e da biografie molto tarde. Fu stratega nel 424/3 a.C. e, al comando di
una flotta di sette navi, accorse in aiuto di Anfipoli minacciata dai Persiani.
L'insuccesso di questa spedizione costò a Tucidide un lungo esilio durato venti
anni che egli trascorse probabilmente nel Peloponneso e in Tracia. Durante
l'esilio cominciò a scrivere la Storia della guerra del Peloponneso in otto
libri, che poté condurre solo fino al 411 a.C. Tucidide morì verso il 400 a.C.
probabilmente di morte violenta.
Valerio Massimo
(I secolo
d.C. - Età di Tiberio) Non sappiamo quando e dove sia nato questo retore, che
era cliente del console del 14 d.C., Sesto Pompeo, e che Valerio seguì nel 27
quando Sesto fu nominato proconsole in Asia. Nel 32, dopo la caduta del prefetto
di Tiberio, Seiano, completò la sua opera, dedicandola al principe. Valerio
Massimo è autore di una raccolta di aneddoti storici, Factorum et dictorum
memorabilium libri, in 9 libri. L'opera è una raccolta di exempla storici,
diretta alle scuole, divisa per argomenti, al cui interno si ha una
sotto-divisione in exempla stranieri e (quantitativamente di più) romani, che
sono attinti non tanto ai grandi storici greci, quanto a Cicerone, Sallustio e
Livio. I temi sono disparati:
I. Religione; II. Rispetto delle istituzioni;
III. Coraggio, forza, pazienza; IV. Misericordia, sobrietà, amore coniugale,
amicizia; V. Clemenza, riconoscenza, amore filiale; VI. Castità, giustizia; VII.
Fortuna; VIII. Processi e otium; IX. Vizi.
Secondo quello che l'autore
afferma nella prefazione, si tratta di un manuale diretto a chi vuole citare
gesta o sentenze riguardanti un determinato argomento: è dunque un manuale ad
uso dei retori e dei declamatori delle scuole, costruito con uno stile ampolloso
e pretenzioso. Tuttavia Valerio nasconde questa vacuità retorica sotto il
pretesto etico dell'esaltazione della virtù, che ovviamente si rivela in Tiberio
e ha il suo contrario in Seiano, insigne esempio di ingratitudine punita. Ragion
per cui Valerio non può essere definito uno storico, quanto un retore che
testimonia il progressivo sbriciolamento della storiografia in aneddotica e
pettegolezzo, senza più la necessaria comprensione delle causalità degli eventi.
Per il suo carattere moraleggiante, l'opera ebbe molta fortuna nel Medioevo,
circolando anche in due riassunti, quello di Giulio Paride e uno (mutilo) di
Nepoziano, ambedue del IV-V secolo d.C.
Varrone Marco Terenzio
(Reate, oggi Rieti, in Sabina, nel 116 – 27 a.C.) Autore longevo. L'elemento
più significativo della vita di Varrone è sicuramente la sua longevità, che lo
mette in condizione di assistere agli eventi che vanno dal comparire di Mario
sulla scena politica all'ascesa di Augusto. Fra tradizione e modernità. Studiò a
Roma e ad Atene. Difensore della tradizione (secondo, potremmo dire, quasi il
dettato genetico della sua origine sabina), si schierò dalla parte di Pompeo,
ricoprendo la carica di tribuno della plebe e, in seguito, quella di pretore,
senza peraltro proseguire e concludere il suo "cursus honorum". Cesare gli
perdonò e gli affidò addirittura la biblioteca pubblica che intendeva instaurare
in Roma: la scelta proprio di Varrone potrebbe spiegare la valenza politica del
progetto cesariano: il mondo nuovo che dittatore sta realizzando si preoccupa di
mantenere la memoria del passato per trasmetterla ai posteri. Pare, infine, che
Varrone sia stato anche consigliere di Augusto per le questioni religiose.
Vitruvio Pollione
(sec. I a.C.) Identificato con l’ufficiale
cesariano Mamurra, architetto, scrisse il "De architectura" (25-23 a.C.), un
trattato in 10 libri, dedicato ad Augusto e riconducibile alla sua politica
d’abbellimento architettonico di Roma.
L’opera, in parte compilatoria e in
parte originale (7 libri di architettura, 1 di idraulica e 2 di gnomica e
meccanica), per il suo scopo e per il suo contenuto (ricco di elementi di varia
natura, tratti da discipline disparate: aritmetica, geometria, disegno, musica,
prosodia, astronomia, ottica, medicina, giurisprudenza, storia, filosofia), è un
unicum nel suo genere. L’architettura è vista, in senso aristotelico, come
"mimesis" dell’ordine provvidenziale della natura: perciò si richiede
all’architetto una cultura ricca e varia, enciclopedica (quasi quella
dell’oratore ciceroniano), che faccia perno sulla
filosofia.
Etruscologia
La rassegna retrospettiva che qui s'intende
presentare per grandi linee richiama i dati essenziali relativi agli
avvenimenti, alle persone e alle opere che costituiscono la trama del graduale
recupero delle conoscenze sull'Etruria antica e dell'approccio moderno alla sua
comprensione. A tal proposito non sembra difficile individuare e distinguere: 1)
una «preistoria» erudita che va fino al Settecento, 2) un periodo di estese e
positive acquisizioni scientifiche che abbraccia gran parte dell'Ottocento e
infine 3) uno stadio di più estesa ricerca e di più compiuta elaborazione
storico-critica soprattutto nel corso del nostro secolo.
Anche se la memoria
degli antichi Tusci era riaffiorata talvolta non senza qualche punta di orgoglio
nelle cronache toscane del tardo medioevo e nella letteratura umanistica, fu
senza dubbio il generale risveglio d'interesse per i monumenti antichi e per le
scoperte di antichità che portò la cultura del Rinascimento ad un primo incontro
con le testimonianze del mondo etrusco in quanto fenomeno più o meno chiaramente
distinguibile, e progressivamente distinto, nell'ambito della risorgente
classicità. Rinvenimenti sporadici di tombe e di iscrizioni osservati con
crescente curiosità alimentarono tra gli ultimi decenni del XV e i primi del XVI
secolo gli scritti pieni di ricostruzioni fantastiche di Annio da Viterbo e le
opere di altri eruditi come Sigismondo Tizio a Siena. Da Leon Battista Alberti a
Giorgio Vasari si avviò una iniziale teorizzazione dell'architettura e dell'arte
figurativa etrusca (particolarmente importante, a metà del Cinquecento, fu la
scoperta della Chimera d' Arezzo).
Il richiamo dell'Etruria antica si spostò
nel corso del XVI secolo dalla Tuscia papale alla Toscana, e in Toscana trovò il
suo ambiente più propizio non soltanto a livello di interessi culturali, ma
anche per una certa rispondenza al programma politico del principato mediceo,
culminando poi nel Settecento in quel vivacissimo movimento di ricerche (scavi a
Volterra, Cortona, ecc.) e di studi antiquari che prese il nome di etruscheria.
L'entusiasmo dei dotti locali portati a sopravalutare le antiche glorie della
loro patria toscana contribuì a diffondere la conoscenza dei monumenti etruschi
e a favorire la esaltazione, sovente esagerata, degli Etruschi fra gli altri
popoli del mondo antico.
Come il XVI era stato il secolo della riscoperta di
Roma e il XIX sarà il secolo della scoperta della Grecia, così il XVIII può
considerarsi senz'altro il secolo della scoperta dell'Etruria. È pur vero che il
primo tentativo di sintesi sulle conoscenze lasciate dal mondo antico
relativamente all'Etruria risale all'opera De Etruria regali dello scozzese Th.
Dempster, scritta fra il 1616 e il 1619; ma è anche vero che questa fu
pubblicata e valorizzata soltanto nella prima metà del Settecento e che ad essa
fecero eco le opere di F. Buonarroti, di O. H. Passeri, di S. Maffei, di A. F.
Oori, di M. Guarnacci. Sin dal 1726 era stata fondata l'Accademia Etrusca di
Cortona, che divenne il centro principale di questa attività erudita, riflessa
anche nei volumi delle sue Dissertazioni, pubblicati fra il 1735 e il 1795.
Fuori d'Italia va ricordata l'opera del grande antiquario francese A. C. Ph. De
Caylus. Più che per il valore delle congetture e delle conclusioni, sovente
arbitrarie e fantastiche, e per la natura del procedimento critico, la
etruscheria settecentesca va giudicata positivamente per la passione e per la
diligenza delle ricerche e della raccolta del materiale archeologico e dei
monumenti, che talvolta conserva tuttora un certo valore.
L'attività etruscologica del Settecento culmina nella pubblicazione del
Saggio di lingua etrusca e di altre d'Italia di L. Lanzi: una piccola «summa»
delle cognizioni sull'Etruria, non soltanto nel campo della epigrafia e della
lingua, ma anche in quello della storia, dell'archeologia e della storia
dell'arte. Il Lanzi appare già alla soglia di una fase di cognizioni più vaste e
di metodo più sicuro, come è provato da molte sue affermazioni nel campo
epigrafico-linguistico e dalla reazione alle esagerazioni dell'etruscheria, per
esempio nella giusta attribuzione alla Grecia dei vasi dipinti fino allora detti
etruschi, e più generalmente nel concetto di una preminente influenza greca
sullo sviluppo dell'arte etrusca, della quale è tracciata una prima embrionale
ma apprezzabile periodizzazione; nel solco del Lanzi si svilupperà l'attività
degli epigrafisti italiani dell'Ottocento come O. H. Vermiglioli. F. Orioli. M.
A. Migliarini e lo stesso A. Fabretti. Possiamo in sostanza affermare che quello
studioso sia stato per molti aspetti, e soprattutto per la convergente
molteplicità dei suoi interessi, il vero fondatore dell'etruscologia
moderna.
Occorre invece tener presente che una certa sopravvivenza delle idee
settecentesche, non solo per quel che riguarda l'Etruria, ma anche nel senso
dell'esaltazione degli antichi popoli italici con più o meno accentuate
sfumature antiromane (Maffei, Guarnacci, O. Lami, C. O. M. Denina e altri), si
manifesterà ancora negli scritti di archeologi, storici e saggisti della prima
metà del secolo XIX, trasferendosi dall'illuminismo allo spirito romantico e
perfino venandosi di spunti nazionalistici nel quadro del movimento del
Risorgimento italiano. L’espressione più significativa di queste correnti è
rappresentata dall'opera di O. Micali, che, a torto sottovalutata, emerge per
acutezza di osservazioni, capacità di sintesi e apertura ai nuovi orientamenti
delle scienze storiche. Si andavano ormai del resto universalmente diffondendo i
riflessi di un rapido e straordinario progresso delle scoperte e degli
studi.
Il nuovo secolo si era iniziato infatti con una intensissima
esplorazione soprattutto delle necropoli dell'Etruria meridionale e con una
serie di scoperte di valore decisivo a Tarquinia, a Vulci, a Cerveteri, a
Perugia, a Chiusi e in altre località. Alla iniziale attività formativa di
collezioni a Cortona e a Volterra, che aveva caratterizzato il Settecento si
contrappone ora lo sviluppo delle raccolte di materiali etruschi nel Museo
granducale di Firenze, nel Museo Etrusco Gregoriano a Roma, nel Museo
etrusco-romano di Perugia; mentre, come risultato immediato degli scavi, si
formano le ingenti collezioni private di Luciano Bonaparte, principe di Canino,
e del banchiere O. P. Campana, destinate ad emigrare in gran parte fuori
d'Italia e a costituire i nuclei delle collezioni etrusche del Museo del Louvre
a Parigi, del Museo Britannico a Londra e di molti altri grandi musei
europei.
Nel frattempo, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX, si era
determinato quel grandioso processo di rinnovamento degli studi sulle antichità
classiche in generale che, iniziato da J. J. Winckel-Mann e continuato da E. Q.
Visconti, C. Fea, L. Canina, E. Gerhard, K. Q. Moller, accoglieva nuovi impulsi
dal contatto diretto del mondo occidentale con i monumenti originali della
Grecia e non di rado investiva direttamente, per l'interesse personale di alcuni
dei suoi protagonisti, anche il mondo etrusco. Nello stesso periodo la
linguistica generale comparata usciva con F. Schlegel e F. Bopp dalle nebbie
dell'erudizione prescientifica e si concretava nella definizione e nella
dimostrazione dell'unità linguistica indoeuropea.
In seguito a questi
avvenimenti e nell'ambito di questi generali sviluppi degli studi la conoscenza
delle antichità etrusche passa decisamente dalla fase settecentesca a quella
ottocentesca del metodo storico, archeologico e filologico. Un primo fattore
essenziale di progresso è costituito dalla fondazione dell'Instituto di
Corrispondenza Archeologica, nato a Roma nel 1829 per iniziativa del Oerhard e
di un gruppo di studiosi e di amatori nordici, i cosiddetti «Iperborei»: per
diversi decenni le ricerche e le scoperte d'Etruria saranno illustrate nel
Bullettino, negli Annali e nei Monumenti dell'Instituto. Lo studio della
topografia e dei monumenti si afferma attraverso una serie di indagini e di
pubblicazioni di viaggiatori, di archeologi e di architetti, come W. Gell, il
Canina (Antica Etruria marittima, 1846- 1851), O. Dennis (The Cities and
Cemeteries of Etruria, London, 1848, con successive edizioni fino al 1883).
Particolarmente famoso è stato, per la diffusione delle cognizioni sull'Etruria
nel mondo della cultura in generale, il libro del Dennis.
Si continuano
intanto a pubblicare raccolte sistematiche di monumenti, opere d'arte ed oggetti
di scavo e cataloghi come quello del Museo Etrusco Gregoriano. Ma si iniziano
anche raccolte specializzate per singole classi di oggetti, veri e propri
«corpora»: di vasi specchi, poi urne. Non mancano relazioni di scavi talvolta
anche accurati, nella misura in cui le operazioni di ricerca sul terreno ancora
spesso concepite e condotte come recupero selettivo di materiali, se non
addirittura come rapina, tendono a finalità più decisamente conoscitive sotto il
controllo degli studiosi. L 'interesse per le opere figurate va perdendo il
carattere di curiosità soprattutto rivolta alle speculazioni mitologiche, care
agli eruditi del Settecento; ma resta ancora prevalentemente confinato nello
studio dei soggetti e alla derivazione e al confronto delle immagini, cioè
all'iconografia. Il confronto con l'arte greca porta di regola ad un giudizio
negativo nei riguardi della produzione etrusca considerata in gran parte un
artigianato d'imitazione: tale posizione sarà teorizzata in modo esplicito nel
primo tentativo di sintesi sull'arte degli antichi Etruschi che appare soltanto
verso la fine del secolo con l'opera di Martha, L 'art etrusque (Paris,
1889).
Il periodo del quale ci occupiamo è particolarmente fecondo nel campo
degli studi epigrafici. L'attività degli studiosi italiani, epigoni del Lanzi,
ai quali abbiamo già fatto cenno, culmina nella pubblicazione del monumentale
Corpus lnscriptionum ltalicarum, con un Glossarium ltalicum, del Fabretti
(1867). Nell'ultimo trentennio del secolo gli studi sulla lingua etrusca
prendono un deciso orientamento critico. Si distinguono in essi, tra gli altri,
W. Corssen, W. Deecke, C. Pauli, S. Bugge, O. Herbig, E. Lattes: le questioni
dominanti sono quelle dei metodi di interpretazione e della appartenenza o meno
dell'etrusco al gruppo delle lingue indoeuropee.
In questo stesso
momento s'imposta anche il problema dell' origine degli Etruschi, non più
soltanto sulla base delle fonti letterarie antiche e delle congetture
linguistiche, ma anche in rapporto alle nuove scoperte sulle fasi primitive
della civiltà dell'Eruria e dell'Emilia (nel 1856 venivano in luce le prime
tombe a cremazione di Villanova presso Bologna) e agli sviluppi generali delle
conoscenze sulla preistoria italiana: partecipano a queste ricerche e a questi
dibattiti, tra gli altri, W. Helbig, I. Undset, L. Pigorini, E. Brizio. Occorre
infine ricordare un'opera complessiva che ebbe, ed ha tuttora. fondamentale
importanza come quadro di cognizioni complessive essenzialmente fondate sulla
raccolta, la rielaborazione e l'interpretazione dei dati della tradizione
greco-romana sul mondo etrusco: cioè il libro di K. Q. Moller, Die Etrusker
(1828).
Il terzo e più avanzato periodo della storia degli studi
etruscologici ha come premessa l'intensificarsi di ricerche archeologiche
sistematiche e controllate che si manifesta già a partire dagli ultimi decenni
del XIX secolo soprattutto per l'intervento di organi responsabili ufficiali
dopo l'unità italiana. Si scava nelle necropoli di Tarquinia, di Vetulonia, di
Narce, di Bologna; si arricchiscono e si consolidano le conoscenze sulle fasi
più antiche dell'Etruria, cioè il villanoviano, che appare ora diffuso, oltre
che in Emilia, anche nei territori etruschi tirrenici, e l'orientalizzante; si
rivela il singolare abitato a pianta regolare di Marzabotto; si esplorano i
resti dei templii di Marzabotto, di Falerii, di Orvieto con le loro decorazioni
architettoniche. Via via nel corso del secolo attuale fino agli ultimi decenni
si intraprenderanno nuove regolari indagini nei centri maggiori, a Caere, Veio,
Tarquinia, Populonia, Roselle, e altrove; infine nelle località litoranee e
portuali di Spina sull' Adriatico e di Pyrgi e Graviscae sul Tirreno, e in
centri minori arcaici dell'interno come Acquarossa presso Ferento nel Viterbese
e Poggio Civitate presso Murlo in provincia di Siena, per non citare che le
imprese più significative, in parte ancora in corso: ovunque con risultati che
hanno profondamente cambiato, se non addirittura rivoluzionato, il quadro delle
nozioni ottocentesche sulla civiltà etrusca. Naturalmente anche in questo
settore, come generalmente nell'archeologia moderna operante sul terreno, gli
scavi sono condotti con sempre maggiore scrupolo di controlli scientifici tali
da offrire il maggior numero possibile di osservazioni e di dati, dai
rilevamenti stratigrafici ai più avanzati e raffinati metodi tecnologici
(fotografia aerea, prospezioni chimiche, fisiche, elettromagnetiche del
sottosuolo ecc.). Hanno concorso e concorrono a queste attività, oltre gli
uffici statali cioè le Soprintendenze archeologiche dell'Etruria Meridionale,
della Toscana, dell'Umbria, dell'Emilia, anche istituti scientifici italiani e
missioni straniere. Si aggiungano alle scoperte nel territorio etrusco quelle
non meno importanti, e collateralmente rivelatrici, del Lazio, della Campania,
dell'Umbria, del Piceno, dell'ltalia settentrionale. L 'indagine non è chiusa in
se stessa e il mondo che viene in luce appare sempre più significativamente
inquadrato ed interpretabile nella visione dello sviluppo della civiltà antica
in generale, così per quanto riguarda l'ltalia come per i suoi rapporti con le
aree circostanti, con la Grecia e con l'Oriente.
Nascono ora, anche come
conseguenza dei nuovi scavi, i grandi musei pubblici italiani con prevalente
impronta di collezioni etruscologiche, a Firenze, a Roma (il Museo Nazionale di
Villa Giulia), a Tarquinia, a Chiusi, a Perugia, a Bologna, poi a Ferrara (Museo
di Spina), e le importanti raccolte locali di Orvieto, Fiesole, Arezzo, Siena,
Grosseto, Marzabotto, ecc., affiancandosi all'incremento di vecchi musei come il
Gregoriano Etrusco del Vaticano o il museo dell' Accademia Etrusca di Cortona;
mentre specialmente tra la fine del secolo passato e il principio del nostro
secolo si sono considerevolmente arricchiti di materiali etruschi i musei
stranieri d'Europa e d' America.
È proseguita intanto la pubblicazione di
repertori generali o di singole classi di monumenti: per il materiale della fase
più antica della civiltà etrusca la raccolta di tavole a disegno de La
civilisation primitive en Italie (1896-1904) di O. Montelius; per la pittura i
fascicoli dei Monumenti della pittura antica in Italia riguardanti le tombe
etrusche di Tarquinia e di Chiusi (dal 1937); per le terrecotte architettoniche
la raccolta di A. Andren, Architectural Terracottasfrom Etrusco-ltalic Temples
(1939-1940); per i sarcofagi il «corpus» di R. Herbig, Die Ungeretruskischen
Steinsarkophage (1952); per la ceramica dipinta l'opera di D. Beazley, Etruscan
Vase-Painting (1947). Parallelamente allo sviluppo delle esplorazioni la
descrizione dei luoghi e la considerazione topografica delle città e del
territorio, nel solco già aperto dal Canina e dal Dennis, vengono assumendo in
questo periodo caratteri più decisamente critici: possiamo citare in proposito
la parte dedicata all'Etruria nella ltalische Landeskunde (1883-1902) di H.
Nissen e, più specificamente ed estesamente, la Topografia storica dell'Etruria
in quattro volumi (1915-1920) di A. Solari. Ma caratteristica soprattutto è la
tendenza ad affrontare monograficamente lo studio di singoli centri considerati
in tutti i loro diversi aspetti archeologici e storici: ciò che è stato fatto
per Bologna (A. Orenier, P. Ducati), Chiusi (R. Bianchi Bandinelli), Cortona (A.
Neppi Modona), Populonia (A. Minto), Sovana (Bianchi Bandinelli), Vulci (F.
Messerschmidt), Tarquinia (M. Pallottino), Capua (Heurgon), e così via. Molte
delle opere generali sugli Etruschi pubblicate negli ultimi decenni danno del
resto largo spazio alla trattazione descrittiva delle città
etrusche.
All'indagine topografica si ricollegano i problemi di storia
dell'architettura, con particolare riguardo alle origini, alle caratteristiche e
allo sviluppo del tempio etrusco e della sua decorazione, e sia pure in misura
minore agli edifici civili e alla casa; nonchè gli studi di urbanistica greca e
italica che hanno investito largamente anche il mondo etrusco (F. Castagnoli, O.
A. Mansuelli, R. Martin). L'approfondimento critico dei fenomeni dell'arte
figurativa trova a sua volta un duplice incentivo da un lato nelle nuove
scoperte, specialmente quella dell' Apollo di Veio avvenuta nel 1916; da un
altro lato nelle generali tendenze «esterne» della critica contemporanea verso
il superamento del classicismo e dell'accademismo e verso la comprensione e
rivalutazione delle culture artistiche estranee alla classicità, incluse quelle
provinciali e tardo-antiche (A. Riegl): donde partì una più o meno esplosiva
affermazione dell'originalità e della positività dell' «arte etrusca» o dell'
«arte italica» rispetto all'arte greca; ciò che è stato poi in parte
ridimensionato o riportato sul piano di più rigorose valutazioni storiche. Non
può trascurarsi la segnalazione di grosse raccolte illustrative generali,
tuttora utili anche se ormai prive di aggiornamento, come la Storia dell'arte
etrusca di Ducati (1927).
I progressi dei rinvenimenti e degli studi nel
campo della preistoria e della protostoria dell'Etruria e dell'ltalia in genere
hanno portato soprattutto, nel corso del secolo attuale, a basilari tentativi di
sistemazione cronologica, sia in senso relativo come individuazione di
successione delle fasi culturali dell'età del bronzo e dell'età del ferro, sia
in senso assoluto come ricerca di date sulla base dei confronti con materiali
d'importazione o d'imitazione di oggetti delle più o meno bene inquadrate
civiltà del Mediterraneo orientale, da ultimo anche con l'ausilio dei nuovi
metodi scientifici di datazione, segnatamente dei computi con il radiocarbonio
(da O. Montelius, O. Karo, A N. Aberg, A . Akerstrom, O. Von Merhart, H.
Moller-Karpe, R. Peroni, oltre chi scrive e molti altri). Ovviamente le novità
archeologiche continuamente insorgenti non solo in Etruria, ma anche nel resto
dell'area italiana e in tutto il Mediterraneo hanno concorso a dare più precisi
connotati e termini via via meno rigidi alla polemica sulle origini etrusche
iniziata nell'Ottocento ed ora affrontata in specifiche opere monografiche (L.
Pareti, F. Schachermeyr, Ducati, Pallottino, F. Altheim, H. Hencken).
Il
compito degli storici, oltre che sul problema delle origini, sembra concentrarsi
con accresciuta attenzione su quello delle istituzioni politiche, amministrative
e religiose delle città etrusche, anche in rapporto con gli analoghi fatti e
sviluppi di Roma e del mondo italico. Non sono mancate indagini sulle forme
della vita, sui costumi, sull'economia e sull'organizzazione sociale, quale
emerge anche dall'analisi dell'abbondantissimo materiale onomastico offerto
dalle iscrizioni funerarie. Si aggiungano vecchi e nuovi interessi portati
specificamente sul tema della religione, della divinazione, dei culti. Infine
gli studi epigrafici e linguistici hanno trovato nuovo alimento nella
individuazione e nella scoperta di testi di fondamentale importanza (alla fine
del XIX secolo il manoscritto su tela di Zagabria e la tegola di Capua, i più
lunghi tra quelli finora conosciuti; recentemente le lamine d'oro di Pyrgi con
una «bilingue» etrusco-fenicia) e nel generale incessante incremento del
materiale, la cui pubblicazione sistematica, in sostituzione delle precedenti
raccolte. Per tutto il corso del nostro secolo si sono moltiplicate, con
risultati rilevantissimi e talvolta determinanti, le indagini epigrafiche,
interpretative, grammaticali, ad opera di una lunga schiera di studiosi.
Un
momento di particolare importanza per l'etruscologia fu quello degli anni tra il
1920 e il 1930 quando, anche a seguito delle scoperte archeologiche cui si è
fatto cenno, segnatamente di Veio, si accese improvvisamente nel mondo degli
studi e della cultura un vivacissimo interesse per l'arte e per la civiltà
dell'Etruria antica e, ciò che più conta, si manifestò una simultaneità e
convergenza senza precedenti nell'affrontare e discutere i problemi più
scottanti, non soltanto dell'arte, ma anche dell'origine, della lingua, della
religione e della società etrusca. Firenze diventa il centro principale di
questo movimento al quale partecipano studiosi italiani e stranieri; si
susseguono un Convegno Nazionale (1926) e il I Congresso Internazionale Etrusco
(1928); nasce il Comitato Permanente per l'Etruria (1927) e poco dopo (1932)
sarà fondato l'Istituto di Studi Etruschi ed Italici, massimo organo promotore e
coordinatore degli studi etruscologici anche a livello internazionale; dal 1927
si pubblica la serie dei volumi annuali della rivista Studi Etruschi.
La
suggestione del mondo etrusco non manca di riflettersi negli stessi anni sulla
cultura e sulla letteratura europea. Successivamente, e soprattutto dopo la
seconda guerra mondiale, le prospettive di attività, di cooperazione e di
organizzazione del lavoro così clamorosamente aperte hanno avuto ulteriori
verifiche ed ampliamenti con un ritmo che si è accelerato negli ultimi tempi:
oltre l'intensificarsi dei contributi individuali, vi hanno concorso gli
incontri scientifici, specialmente i convegni periodici promossi dall'Istituto
di studi Etruschi ed Italici; le rassegne documentarie a partire dalla grande
mostra «Arte e civiltà degli Etruschi» presentata in varie città d'Europa nel
1955 e 1956; gli scavi con risultati spesso imprevisti, le analisi tecnologiche
e i restauri di vecchi e nuovi materiali; lo sviluppo di insegnamenti specifici
di etruscologia nelle Università italiane; le iniziative fiorite, oltre che a
Firenze, a Roma intorno alla cattedra etruscologica dell' Ateneo romano, al
Centro di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'archeologia
etrusco-italica e ad altre istituzioni italiane e straniere; infine il formarsi
di tradizioni di studi etruscologici anche all'estero, specialmente in Francia,
in Belgio, in Olanda, in Germania, in Svezia.
Alla informazione e alla
divulgazione concorre il diffondersi di opere generali sulla civiltà degli
Etruschi, che, dopo il pressochè unico esempio ottocentesco del citato Moller e
Deecke, accompagna il risveglio degli studi etruscologici con i libri del Ducati
(L'Etruria antica, 1927), di B. Nogara (Gli Etruschi e la loro civiltà, 1933),
di M. Renaro (lnitiation à l'etruscologie, 1941) e la prima edizione del
presente volume (1942), cui seguiranno pubblicazioni di sintesi e d'impostazione
sempre più numerose soprattutto negli ultimi anni (tra le più note quelle di R.
Bloch, O. W. Von Vacano, L. Banti, E. Richaroson, H. H. Scullaro), nonchè
miscellanee (Historia, VI, 1957: Tyrrhenica, 1957; Etudes etrusco-italiques,
1963). Questa letteratura rispecchia panoramicamente non soltanto il progresso
delle conoscenze, ma anche l'aprirsi di nuove prospettive di metodo e
d'interpretazione storica, delle quali si dirà più avanti.
Introduzione
Il fondatore della questione etrusca è Dionisio D’Alicarnasso, storico greco
di età augustea, che dedica cinque capitoli (26-30) del primo libro delle sue
Antichità romane all'esame di questo argomento, confutando - con i mezzi critici
a sua disposizione - le teorie che identificavano gli Etruschi con i Pelasgi o i
Lidi e dichiarandosi favorevole all'ipotesi che fossero un popolo «non venuto di
fuori ma autoctono», il cui nome indigeno sarebbe stato Rasenna. Scrive lo
storico: Dopo che i pelasgi ebbero lasciato la regione, le loro città furono
occupate dai popoli che vivevano nelle immediate vicinanze, ma principalmente
dai tirreni, che si impadronirono della maggior parte di esse, e delle
migliori…Sono convinto che i pelasgi fossero un popolo diverso dai tirreni. E
non credo nemmeno che i tirreni fossero coloni lidii, poiché non parlano la
lingua dei primi….Perciò sono probabilmente più vicini al vero coloro che
affermano che la nazione etrusca non proviene da nessun luogo, ma che è invece
originaria del paese.(Dionisio di Alicarnasso (Antichità Romane) I sec.
a.C.)
Prima di lui le opinioni sulle origini etrusche non avevano
avuto, a quanto sembra, carattere di meditata discussione; ma, come la maggior
parte delle notizie antiche sulle origini di popoli e città del mondo greco ed
italico, erano ai confini tra la storia e il mito, giovandosi al più - nel senso
di una giustificazione critica - di accostamenti etimologici ed onomastici. Come
le origini di Roma e dei Latini erano riportate ai Troiani attraverso le
migrazioni di Enea, così per i Tirreni, cioè per gli Etruschi, si era parlato di
una provenienza orientale, dalla Lidia in Asia Minore, attraverso una migrazione
transmarina, guidata da Tirreno figlio di Ati re di Lidia, nel territorio
italico degli Umbri (racconto di Erodoto, l, 94) o di una loro identificazione
con il misterioso popolo nomade dei Pelasgi (Ellanico di Lesbo in Dionisio, I,
28), ovvero anche di una immigrazione di Tirreno con i Pelasgi che avevano già
colonizzato le isole egee di Lemno e di Imbro (Anticlide in Strabone, V, 2, 4);
si aggiungano minori varianti o rielaborazioni di questi racconti su cui non
vale la pena di soffermarci. Scrive Erotodo: Sotto il regno di Atis, figlio di
Manes, tutta la Lidia sarebbe stata afflitta da una grave carestia. Per diciotto
anni vissero in questo modo. Ma il male, lungi dal cessare, si aggravava sempre
più. Allora il re divise il suo popolo in due gruppi: quello estratto a sorte
sarebbe rimasto, l'altro avrebbe cercato fortuna altrove. Alla testa dei
partenti pose suo figlio, chiamato Tirreno. Dopo aver costeggiato molte coste e
aver visitato molti popoli giunsero nel paese degli umbri e vi costruirono varie
città in cui tuttora abitano. Ma mutarono il nome di lidii in un altro, tratto
dal figlio del re che li aveva guidati: prendendo il suo stesso nome si
chiamarono tirreni. (Erodoto (Storie I, 94) V sec. a.C.)
L'origine
lidia degli Etruschi entrò senza difficoltà tra i luoghi comuni della
letteratura classica: Virgilio dice indifferentemente Lidi per Etruschi. Ne
mancava, a detta dello stesso Dionisio d' Alicarnasso, chi sospettasse una loro
origine indigena d'Italia. Ma soltanto Dionisio raccolse le diverse opinioni, le
discusse e cercò di dimostrare la propria - cioè quella dell'autoctonia - sulla
base dell'estrema antichità del popolo etrusco e del suo isolamento culturale e
linguistico tra le varie genti a lui note.
In epoca moderna il problema è
stato ripreso dapprima soltanto sulla base dei testi classici, più tardi anche
con il concorso dei dati archeologici e linguistici. La prima fase della
discussione fu condotta, tra l'inizio del XVIII e la prima metà del XIX secolo,
da N. Freret , B.G. Niebuhr e K.O. Moller, i quali, richiamandosi alla posizione
«critica» di Dionisio d' Alicarnasso, si pronunciarono, sia pure con diversa
accentuazione, contro la tradizione erodotea della provenienza degli Etruschi
dall'Asia Minore (si arrivò perfino ad accostare il nome Rasenna con quello dei
Raeti delle Alpi). Di fatto noi riconosciamo l'esistenza di una civiltà etrusca
-etnicamente definita dalle iscrizioni in lingua etrusca che cominciano ad
apparire nel VII secolo a.C. e durano fino al principio dell'età imperiale
romana - diffusa nell'Etruria propria (Lazio settentrionale e Toscana), in
Campania e nella parte orientale della valle del Po. La fase più antica di
questa civiltà storica (e sicuramente etrusca), caratterizzata da un intenso
afflusso di elementi orientali e detta perciò orientalezzante, si riattacca
immediatamente alla cultura del ferro villanoviana.
Dal punto di vista del
rito funebre si osserva in Etruria un predominio esclusivo dell'inumazione di
età preistorica (con le culture eneolitica e del bronzo); poi l'apparire della
incinerazione con i sepolcreti «protovillanoviani» ed una sua netta prevalenza
nel villanoviano più antico; un riaffermarsi dell'inumazione nell'Etruria
meridionale e marittima durante il villanoviano evoluto e l'orientalizzante;
infine un uso promiscuo dei due riti - con prevalenza dell'inumazione nel sud,
dell'incinerazione nel nord - per tutta la successiva durata della civiltà
etrusca. Giova ricordare che anche in Roma repubblicana i due riti funebri erano
paralleli e legati a tradizioni familiari (ma alla forte prevalenza
dell'incinerazione sul finire della repubblica e nel primo secolo dell'Impero
succederà il generalizzarsi dell'inumazione a partire dal II secolo d.C., senza
che ciò corrisponda a trasformazioni di carattere etnico).
Sulla base dei
dati offerti dalle tradizioni letterarie, dai confronti linguistici e
dall'interpretazione dei fatti archeologici sono state formulate, dall'ultimo
secolo, varie teorie relative alle origini del popolo etrusco. Esse possono
tuttavia riportarsi sostanzialmente a tre sistemi, di cui uno riprende e
sviluppa la tesi tradizionale antica della provenienza degli Etruschi
dall'oriente, l'altro continua la scuola di Niebuhr e del Moller nel senso di
una provenienza da settentrione, il terzo infine -più recente - tenta di aderire
in modo meno generico all'opinione di Dionisio d'Alicarnasso sull'autoctonia
degli Etruschi, ricercando le loro origini etniche nel substrato antichissimo
delle popolazioni preistoriche d'Italia, anteriori alla diffusione delle lingue
indoeuropee. Di queste tre tesi la più nota ed universalmente accettata è quella
dell'origine orientale. Essa è stata particolarmente cara agli archeologi,
italiani e stranieri, che in densa schiera hanno dedicato i loro appassionati
studi alle antichità dell'Italia protostorica. Ad essi apparve soprattutto
perspicua la coincidenza tra le notizie delle fonti e il fenomeno culturale
orientalizzante, manifestatosi a partire dalle coste tirreniche tra l'VIII e il
VI secolo a.C., come un improvviso avvento di progresso esotico in contrasto con
le forme apparentemente arretrate della precedente cultura villanoviana; si
sottolineò anche il capovolgimento del rito funebre dall'incinerazione
all'inumazione.
Edoardo Brizio (nel 1885) fu il primo ad impostare
scientificamente questa tesi, identificando gli invasori etruschi con i
portatori della civiltà orientalizzante (poi ellenizzante) in Toscana e in
Emilia, e identificando gli Umbri della tradizione erodotea - intesi come
ltalici indoeuropei - nei preesistenti incineratori villanoviani. Dopo di lui
sono stati tenaci assertori dello stesso punto di vista, tra gli altri, A.
Piganiol, R. Bloch. La tesi orientale ha trovato e trova larghissimo credito non
soltanto fra gli etruscologi, ma anche in generale fra i classicisti e studiosi
delle civiltà antiche non strettamente specializzati negli studi etruscologici,
attratti dall'autorità della tradizione, dalla facile spiegazione di alcune
caratteristiche «orientali» della civiltà etrusca, dalle notevoli concordanze
onomastiche tra l'etrusco e le lingue dell' Asia Minore (rilevate da O. Herbigs)
e dall'ancor più evidente rapporto linguistico dell'etrusco con l'idioma
preellenico di Lemno. Tuttavia non sono mancate varianti ed attenuazioni della
classica impostazione del Brizio, specialmente in conseguenza di una più
approfondita considerazione delle fonti antiche e dei dati archeologici: così vi
fu chi suppose un arrivo degli Etruschi dal mare, ma attraverso l'Adriatico e
non il Tirreno, sulla scia della tradizione dei Pelasgi (E. Pottier); chi
immaginò un'invasione in più ondate, a partire dal 1000 a.C..
Ancora più di
recente, l'origine stessa delle culture del ferro dette «tirreno-arcaiche» sia
con inumazione sia con cremazione (praticamente il villanoviano) è stata
attribuita ad un'ondata egea, entro la quale si collocherebbe l'avvento degli
antenati degli Etruschi storici da Lemno e da Imbro; o addirittura si è fatta
risalire l'immigrazione dei Tirreno-Pelasgi in Italia alla tarda età del bronzo.
Queste connessioni preistoriche e protostoriche con l'oriente sarebbero
confermate dalla più volte proposta identificazione dei Tyrsenoi con i Trs.
nominati dai geroglifici egiziani: vale a dire con uno dei «popoli del mare» che
tentarono l'invasione dell'Egitto sotto i faraoni Merneptah e Ramses III (tra il
1230 e il 1170 a.C.).
Infine, di fronte all'affermarsi del concetto di una
formazione storica degli Etruschi da più elementi (come si dirà più avanti),
l'apporto orientale è stato ultimamente riproposto in forma più cauta e
limitata, come un fattore di sollecitazione dovuto all'avvento di nuclei di
navigatori asiatici od egei, simili ai Normanni del medioevo, ma pur sempre
determinante in quanto esso avrebbe imposto la lingua etrusca in Italia. Su
questa linea di ipotesi si muovono le idee di H. Hencken circa successive
penetrazioni all'inizio del villanoviano e dell'orientalizzante, come l'attuale
tendenza a collocare le connessioni orientali in età più remota, cioè nella fase
micenea o immediatamente postmicenea secondo la tesi del Berard. La teoria
dell'origine da settentrione ebbe però il suo principale fondamento critico
nelle scoperte e nelle ipotesi archeologiche del secolo scorso, con particolare
riguardo alla ricostruzione pigoriniana, che già conosciamo, sulla discesa degli
incineratori delle terremare verso l'Italia peninsulare. Tra questi sarebbero
stati non soltanto gli Italici, ma anche gli Etruschi, tanto più che diversi
linguisti ritenevano che l'etrusco fosse una lingua indoeuropea e italica.
La teoria settentrionale sedusse alcuni archeologi - che però passarono poi
alla tesi della provenienza orientale - ma fu soprattutto sostenuta da studiosi
di storia antica. Tuttavia, dovendosi riconoscere una profonda differenza etnica
e linguistica fra Etruschi ed Italici, O. De Sanctis giunse a rovesciare la
teoria pigoriniana identificando gli Etruschi con i crematori discesi dal nord e
gl'Italici con le genti eneolitiche già stanziate nella penisola. L. Pareti ha
voluto riconoscere una più antica ondata indoeuropea (quella dei «Protolatini»)
negli eneolitici; un'ondata indoeuropea più recente (quella degli Italici
orientali) nei crematori «proto- villanoviani»; e infine il nucleo etnico del
popolo etrusco nei possessori della cultura villanoviana, derivata dalle
terremare e dalle palafitte dell'Italia settentrionale. Alla teoria della
provenienza settentrionale si ricollega, in sede linguistica, la ipotesi di P.
Kretschmer sulla pertinenza degli Etruschi ad un gruppo etnico-linguistico
«retotirrenico» o «reto-pelasgico» disceso dall'area balcanico-danubiana verso
la Grecia e verso l'Italia.
La terza tesi, o dell'autoctonia fu quindi
elaborata nel campo archeologico da U. Antonielli, ma soprattutto sviluppata
dalla scuola dei linguisti italiani tra cui O. Devoto, il quale ultimo ne dette
una formulazione organica già nella prima edizione del suo libro Gli antichi
ltalici (1931). Considerati i legami intercorrenti tra l'etrusco e le lingue
preindoeuropee del Mediterraneo, il popolo etrusco non sarebbe giunto in Italia
dopo gli Indoeuropei, ma rappresenterebbe invece un relitto delle più antiche
popolazioni preindoeuropee, una specie di «isola» etnica, così come i Baschi
dell'area dei Pirenei rappresentano tuttora l'avanzo di primitive popolazioni
ispaniche rispetto alle attuali nazioni neolatine che li circondano. La
toponomastica sembra dimostrare infatti, come abbiamo visto nel precedente
capitolo, l'esistenza nella penisola di uno strato linguistico più antico dei
dialetti italici e piuttosto affine all'etrusco stesso e agli idiomi dell’Egeo
preellenico e dell' Asia Minore. Gli Etruschi sarebbero un concentrarsi verso
occidente - sotto la spinta degli invasori ltalici - di elementi etnici
appartenenti a questo strato: naturalmente con notevoli commistioni ed influssi
linguistici indoeuropei. Dal punto di vista archeologico, cioè culturale, lo
strato etnico più antico sarebbe da riconoscere negli inumatori di età
neoeneolitica e dell'età del bronzo ai quali si sarebbero sovrapposti gli
ltalici o Protoitalici incineratori (rappresentati in Etruria dalla cultura
villanoviana), dando luogo alla nazione etrusca storica come un riaffermarsi
degli elementi originari della stirpe sotto gl'impulsi culturali provenienti
dall' oriente. Questa tesi, sia pure con formulazione diversa nei particolari,
fu cara anche a paletnologi «occidentalisti».
Analisi
della teoria della provenienza orientale
Le teorie sin qui esposte
tentano di spiegare ciascuna a suo modo i dati della tradizione, delle ricerche
linguistiche, delle scoperte archeologiche, per ricostruire lo svolgersi degli
eventi che hanno portato all'insediamento e allo sviluppo del popolo etrusco. Si
tratta in realtà di ingegnose combinazioni dei diversi elementi conosciuti; ma
esse soddisfano soltanto una parte delle esigenze che derivano da una piena
valutazione critica di tali elementi. Ciascuno dei tre sistemi e delle loro
varianti lascia qualcosa di inesplicato, urta contro fatti assodati: senza
tuttavia che questo torni a vantaggio delle altre ricostruzioni. Se ciò non
fosse, la discussione sarebbe stata da lungo tempo superata con un accordo di
massima tra gli studiosi, e la polemica tradizionale non sarebbe giunta ad un
punto morto.
Consideriamo in primo luogo criticamente la tesi orientale.
Essa riposa sopra una presunta concordanza tra dati della tradizione - per
quanto essi convergono sulla provenienza degli Etruschi dall'oriente
egeo-anatolico, siano stati essi Lidi o Pelasgi o abitanti di Lemno - e dati
archeologici, cioè la constatazione di una fase culturale orientalizzante
nell'Italia centrale. Si aggiungano sul piano linguistico, come già detto, la
forti somiglianze tra l'etrusco e il lemnio, nonchè le supposte connessioni
dell'etrusco con idiomi dell’Asia Minore e perfino del Caucaso. Ma innanzi tutto
quale è il valore effettivo di ciascuno di questi elementi posti a confronto,
preso isolatamente? Sulle tradizioni relative a migrazioni e a parentele etniche
derivate dai poeti e dai logografi greci la critica moderna è generalmente
scettica o almeno estremamente prudente. Ciò vale in primo luogo per i Pelasgi,
popolo leggendario che i Greci ritenevano originario della Tessaglia ed emigrato
in età eroica per via di mare in varie regioni dell'Egeo e perfino dell'ltalia,
sulla base di concordanze formali tra nomi di località tessale e località
esistenti nei paesi che si ritennero meta delle loro migrazioni. Così furono
dette pelasgiche tutte le zone nelle quali appariva il nome di città Laris(s)a
(dalla Larissa di Tessaglia) e cioè l'Attica, l'Argolide, l'Acaia, Creta, Lesbo,
la Troade, l'Eolide, l'Italia meridionale. Lo stesso si dica per i nomi affini a
quello della città di Gyrton nella Tessaglia, come Gortyna in Macedonia, in
Arcadia e in Creta, Kyrton in Beozia, Crotone nell'ltalia meridionale, Cortona
in Etruria. Va però tenuto presente che in età storica si consideravano di
origine pelasgica popolazioni non greche effettivamente esistenti al margine del
mondo greco, quasi avanzi di quella antica emigrazione, come gli abitatori delle
isole di Lemno e di 1mbro e dell'Ellesponto nell'Egeo settentrionale; e ciò fu
immaginato probabilmente - in direzione opposta, cioè in occidente - anche per
gli Etruschi fin dai primi contatti dei navigatori greci con l'Etruria, dato che
proprio alcuni centri etruschi costieri più aperti ad una intensa frequentazione
ellenica e perciò meglio conosciuti, come Caere (detta dai Greci Agylla, con i
porti di Alsio, Pyrgi, ecc.) e sull'Adriatico Spina, si consideravano originarie
fondazioni dei Pelasgi. È senza dubbio a questo filone di tradizioni che
s'ispira l'ipotesi erudita di un'identificazione dei Tirreni d'ltalia, cioè
degli Etruschi, con i Pelasgi, attribuita da Dionisio d'Alicarnasso allo storico
Ellanico, del tutto indipendente dalla versione di Erodoto sull'origine lidia e
palesemente contrastante con le opinioni degli autori antichi posterodotei che
parlano sì di un'occupazione pelasgica dell'Etruria, ma anteriore e comunque
distinta da quella dei Tirreni. Quanto al famoso racconto di Erodoto
sull'immigrazione dei Tirreni dalla Lidia (o meglio dei Lidi chiamati poi
Tirreni dal loro eponimo Tirreno), prescindendo dalla fortuna che esso ebbe
nell'antichità, difficilmente sfuggiremmo oggi - dopo le argomentazioni critiche
del Pareti - all'impressione che si tratti, così come è formulato, di
un'invenzione dei logografi ionici nella fase di più stretti rapporti
commerciali e culturali del mondo greco-orientale con l'Etruria e di probabili
presenze di navigatori etruschi nell'Egeo, di cui si dirà più avanti, cioè
essenzialmente nel VI secolo.
È possibile che questa storia abbia avuto
spunti ispiratori concreti, oltreche in talune apparenti somiglianze tra
l'Etruria e il mondo anatolico, anche in accostamenti onomastici con la città
lidia di Tyrrha o con il popolo dei Torebi e nella stessa esistenza di Tirreni
nell'Egeo, ricordati dagli scrittori greci a partire dal V secolo, ma spesso
confusi con i Pelasgi (cosicchè non è neppure esclusa l'ipotesi che si tratti di
un nome diffuso secondariamente in sede di erudizione etnografica come
conseguenza dell'identificazione dei Pelasgi con i Tirreni d'Italia, i quali
sarebbero dunque i soli Tirreni conosciuti dalla tradizione greca più antica).
Ancora ai Pelasgi ci riporta la notizia di Anticlide che, per quanto tarda e
contaminata favolisticamente con la versione di Erodoto, presenta
un'interessante precisazione geografica in quanto parla di un'immigrazione dalla
sfera nord-egea delle isole di Lemno e Imbro conosciuta storicamente dai Greci
come «pelasgica» (e alla quale richiamano i rapporti linguistici fra etrusco e
lemnio).
In conclusione i dati delle fonti letterarie classiche, leggendari
e contraddittorii, non offrono alcuna prova a favore di una provenienza del
«popolo etrusco» dall'oriente; tuttavia non escludono possibili echi di singole
più o meno remote connessioni del mondo etrusco con l'area egea.
Passando a
considerare l'aspetto archeologico del problema, va notato subito che il
fenomeno del manifestarsi della civiltà orientalizzante in Etruria non è tale da
giustificare l'ipotesi di un popolo straniero che approdi recando le sue
strutture e le sue forme di vita, come invece è evidentissimo in Sicilia e
nell'Italia meridionale all'arrivo dei coloni greci. Durante la fase del
villanoviano evoluto cominciano ad avvenire trasformazioni notevoli che
preludono allo splendore della successiva fase orientalizzante: si diffonde il
rito funebre dell'inumazione, appaiono le prime tombe a camera, l'uso del ferro
si generalizza, aumentala frequenza degli oggetti di bronzo decorato e dei
metalli preziosi (oro, argento), e nello stesso tempo s'incontrano sempre più
numerosi oggetti e motivi d'importazione straniera (scarabei e amuleti di tipo
egizio, ceramica dipinta d'imitazione greca). II passaggio alla civiltà
orientalizzante non è dunque radicale ed istantaneo. Molti degli aspetti di
questa civiltà, come le stesse grandi tombe architettoniche o di imitazione
architettonica, la ceramica d'impasto e di bucchero, arredi, gioielli, ecc.,
rientrano in pieno nello sviluppo della cultura indigena, sia pure sollecitata
da influenze esterne, orientali e greche, e soprattutto eccitata dal rigoglio
economico. Singoli oggetti importati e motivi provengono dall'Egitto, dalla
Siria, da Cipro, da Rodi e in genere dalla Grecia; altri hanno la loro patria
d'origine anche più lontano, in Mesopotamia o in Armenia (Urartu).
Caratteristico è il genere di decorazione che mescola motivi egiziani,
mesopotamici, siriaci, egeo-asianici, talvolta in composizioni ibride, o
sviluppa i repertori di fregi con animali reali e fantastici, presenti negli
oggetti di lusso di origine fenicio-cipriota, ma rielaborati e diffusi in parte
notevole dai Greci stessi soprattutto nel corso del VII secolo a.C.. In sostanza
l'impressione che si prova di fronte alle tombe etrusche orientalizzanti e ai
loro sontuosi corredi è che l'ossatura, le forme essenziali della civiltà
affondino le loro radici nelle tradizioni locali; mentre lo spirito e le
caratteristiche degli elementi decorativi, esterni, acquisiti, si riportino alla
«moda» orientale. E quando appunto si voglia prescindere da questo carattere
composito - indigeno ed esotico - della civiltà orientalizzante di Etruria' e ci
si voglia limitare all'esame dei soli elementi importati; allora appare chiaro
che essi non sono presenti soltanto in Etruria, ma appaiono più o meno con gli
stessi aspetti in altri paesi mediterranei nello stesso periodo, a cominciare
dalla Grecia stessa, là dove certo non si suppone un'immigrazione
asianica.
Allo stile orientalizzante succederà in Etruria un preponderante
influsso di elementi culturali ed artistici propriamente greci, dapprima
peloponnesiaci e ionici e poi attici, nel corso del VI e del V secolo a.C. Ad
essi è dovuta una ben più decisiva trasformazione della vecchia cultura indigena
in nuove forme di vita, anche nel campo più intimo della religione e delle
costumanze: basti pensare alle divinità e ai miti ellenici penetrati in Etruria.
Nessuno naturalmente oserebbe immaginare l'assurdo storico di una colonizzazione
etnica greca dell'Etruria nel VI secolo (anche se abbiamo prove convincenti
dell'esistenza di nuclei di commercianti greci nei porti etruschi). Non si
comprende dunque la necessità di attribuire la civiltà orientalizzante ad
un'invasione di stranieri, piuttosto che a un rinnovamento di civiltà. Anche per
quel che concerne il rito funebre non esiste alcun brusco trapasso dalla
cremazione del villanoviano all'inumazione dell'orientalizzante.
Già il
villanoviano più antico dell'Etruria meridionale mostra tombe a fossa commiste
con tombe a pozzo di cremati. L'affermazione dell'inumazione è progressiva nella
fase del villanoviano evoluto. Questo processo è del resto comune nel corso
dell'VIII secolo non soltanto in Etruria, ma anche nel Lazio, dove non si
suppone nessuna immigrazione. Inoltre esso appare limitato all'Etruria del sud,
perche l'Etruria interna (per esempio Chiusi) non abbandonerà il costume
dell'incinerazione prevalente ne durante l'orientalizzante ne per tutta la
successiva durata della civiltà etrusca. Nella stessa Etruria meridionale si
avrà una parziale ripresa della cremazione nel VI secolo. Un'incidenza di fatti
etnici è inimmaginabile, se si intende come sostituzione di un popolo ad un
altro.
Riconsideriamo ora questi diversi elementi nei loro reciproci rapporti
geografici ecronologici per verificare se sia sostenibile la tesi orientalistica
nella sua formulazione tradizionale e più diffusa - tuttora sostenuta da alcuni
studiosi e ripetuta in sede di pubblicazioni non specialistiche - dell'arrivo
degli Etruschi in Italia come portatori della civiltà orientalizzante. Ma quale
civiltà orientalizzante? Noi sappiamo benissimo che le importazioni orientali e
più generalmente il formarsi del gusto orientalizzante in Etruria tra la fine
dell'VIII e il principio del VI secolo ci riconducono a centri di produzione e
d'ispirazione estremamente diversi e dispersi del Vicino Oriente e del
Mediterraneo orientale, con una prevalenza, se mai, dell'area siro-cipriota, e
poi greco-orientale.
È dunque piuttosto alla navigazione fenicia e greca,
interessante con analoghi risultati anche altri territori del bacino
mediterraneo, che sarà da attribuire l'apporto culturale orientalizzante. Questo
quadro appare chiaramente inconciliabile con l'idea della immigrazione o della
colonizzazione di un popolo straniero che rechi con se il proprio bagaglio di
civiltà partendo da un punto ben definito del mondo orientale, cioè, stando alle
fonti, dalla Lidia o dall'Egeo settentrionale: tanto più che proprio per questi
territori manca ogni specifica analogia culturale con l'Etruria in
corrispondenza dell'età alla quale si è voluta riferire l'immigrazione etrusca.
Le scoperte di Lemno, delle località costiere della Ionia e dell'Eolide
asiatiche, di Sardi, dell'interno dell' Anatolia non hanno offerto finora alcun
elemento, se non piuttosto generico (per esempio tumuli, tombe a camera,
facciate rupestri, ecc.), di concordanza con i monumenti e con la civiltà
dell'Etruria per quel periodo che in Asia Minore è denominato «frigio» (IX- VII
secolo) ed a Lemno, impropriamente, «tirrenico» (meglio dobbiamo dire
«pelasgico», sulla base della tradizione storica più antica ed
autorevole).
La ceramica geometrica frigia, quella lidia e la caratteristica
ceramica arcaica di Lemno non hanno assolutamente alcun rapporto con la
produzione vascolare indigena e greco-geometrica d'Italia. Qualche vaso di tipo
lidio si diffonde in occidente soltanto nel VI secolo, insieme con tanti altri
tipi greco-orientali. Così anche la ceramica grigia asiatica è esportata dai
coloni di Focea nel Mediterraneo occidentale, ma è rara in Italia, dove non
sembra aver alcun rapporto con l'origine del bucchero etrusco. La fibula
asianica, presente con estrema dovizia in tutta l'Anatolia, ha una
caratteristica forma con arco semicircolare rigido e ingrossamenti a perle o in
forma di elettrocalamita; sembrerebbe impossibile che essa non avesse dovuto
accompagnare le migrazioni di un popolo asianico. Ma è un fatto che essa non ha
avuto diffusione verso occidente neanche per via commerciale: finora nell'Italia
centrale se ne è trovato un solo esemplare sui Colli Albani, e altri due
provengono dalla necropoli di Pitecusa, cioè in ogni caso fuori del territorio
dell'Etruria!
La recente scoperta di una tomba reale a Gordion, capitale
della Frigia, con grandi lebeti di bronzo con figure applicate simili a quelle
delle tombe orientalizzanti dell'Etruria edi Palestrina, offre un'altra
testimonianza della larga diffusione dell'arte bronzistica dell'Urartu sulle vie
della Grecia e dell'Italia, ma non è una prova di un rapporto diretto tra la
Frigia e l'Etruria. Viceversa le connessioni dei centri occidentali dell'Asia
Minore con l'Italia sono sempre più intense ed immediate nel VI secolo, a causa
delle navigazioni ioniche verso occidente e forse anche di presenze etrusche
nell'Egeo, culminando con le preponderanti influenze greco-orientali sull'arte
dell'Etruria arcaica. Ma questo fenomeno non ha ovviamente nulla a che vedere
con la questione delle origini.
L'identificazione della civiltà
orientalizzante con la supposta immigrazione etrusca secondo le fonti antiche
appare insostenibile anche per elementari ragioni di carattere cronologico e
storico. L 'inizio della civiltà orientalizzante etrusca non è anteriore alla
fine dell'VIII secolo, cioè ad un momento in cui i coloni greci erano già più o
meno saldamente stanziati sulle coste della Sicilia e dell'Italia meridionale.
Il racconto di Erodoto sull'immigrazione dalla Lidia non può essere invece
arbitrariamente distratto dal suo sistema cronologico, che riporta i fatti al
regno di Ati sulla Lidia: cioè, secondo la cronologia tradizionale, poco dopo la
guerra di Troia, tra il XIII e il XII secolo a.C. Lo stesso discorso vale anche
per le migrazioni pelasgiche. Un avvenimento così notevole agli albori dei tempi
storici - ed in parallelismo e in concorrenza con la colonizzazione greca - non
sarebbe sfuggito ad altre fonti storiche e soprattutto non sarebbe stato
trasfigurato, come in Erodoto, in un episodio leggendario di mezzo millennio più
antico.
Si consideri anzi che una fonte così autorevole come lo storico
greco Eforo (in Strabone, VI, 2, 2), parlando della fondazione di Nasso, la più
antica colonia calcidese della Sicilia, nell'VIII secolo, afferma che prima di
allora i Greci non si avventuravano nei mari occidentali per timore dei Tirreni:
ammette cioè implicitamente un'antica presenza e potenza degli Etruschi in
Italia prima dell'inizio della colonizzazione greca storica. Proprio se si vuol
dare giusto valore ai dati della tradizione quali possibili echi di una lontana
realtà storica occorrerà ricollocarli nel loro proprio contesto cronologico che
è quello dell' età eroica, cioè riportarli in ogni caso ad avvenimenti
corrispondenti alla tarda età del bronzo, che è quanto dire alle fasi
tardo-micenee e postmicenee degli ultimi secoli del II millennio a.C.: si
tratterebbe in ultima analisi di accogliere l'impostazione critica del Berard,
la sola metodologicamente accettabile. Ma anche volendo supporre che i racconti
di fonte classica contengano qualche reminiscenza di presenze e di apporti
orientali sulle coste tirreniche nella tarda età del bronzo, dovremmo comunque
sfrondarne le coloriture più ingenue e semplicistiche troppo palesemente
ispirate ai modelli delle colonizzazioni storiche, e respingere l'idea di
trasferimenti di popolazioni in massa.
Dovremmo anche, più sottilmente,
distinguere l'impostazione aneddoticamente caratterizzata, e perciò fittizia,
del racconto di Erodoto sulla provenienza dei Tirreni dalla Lidia - oltre tutto
basata sull'ambiguità del concetto e del nome di Tirreni - dai più vaghi ma più
diffusi, e presumibilmente più antichi, richiami alle navigazioni dei Pelasgi.
In questo senso potrebbe anche ammettersi una certa corrispondenza fra dati
della tradizione e dati linguistici, sia nella prospettiva geografica (pelasgità
di Lemno, provenienza degli Etruschi da Lemno secondo Anticlide, affinità fra
illemnio e l'etrusco), sia nella prospettiva cronologica (antichità del rapporto
così nel quadro delle tradizioni come nell'evidenza linguistica). Manca invece
una qualsiasi spia archeologica, anche se la possibilità che navigazioni egee
abbiano raggiunto il Tirreno nel tardo bronzo ci è suggerita da più o meno
sporadici trovamenti di ceramica di tipo miceneo, come già
sappiamo.
Analisi della teoria della provenienza
settentrionale e dell’autoctonia
Passiamo ora all'esame delle tesi
«occidentalistiche», a cominciare da quella della provenienza degli Etruschi da
settentrione. Il vecchio raffronto tra il nome dei Rasenna e quello dei Reti è
puerile: le iscrizioni rinvenute nel Trentino e nell' Alto Adige sono assai
tarde (posteriori al V secolo a.C.) e, se anche mostrano antichissimi legami o
recenti rapporti con l'etrusco, nulla provano ai fini di una supposta originaria
immigrazione degli Etruschi, come popolo già formato, dalla regione alpina. Dal
punto di vista archeologico la critica già fatta ai punti di vista del Pigorini
e dello Helbig in firma sostanzialmente l'ipotesi di una discesa di popoli dal
settentrione dell'ltalia verso il centro della penisola. L'etruschicità della
pianura padana è una ben definita conquista dal sud, come dicono anche le fonti
storiche: in questo si può andare d'accordo con il Brizio e con il Ducati, pur
facendo ogni riserva sulla cronologia ed escludendo che gli abitatori di Bologna
villanoviana siano da identificare con quegli Umbri italici la cui apparizione
sul versante orientale dell'Appennino è ancora più recente.
La linguistica
ha ormai da tempo superato la vecchia concezione delle affinità genetiche tra
etrusco e lingueitaliche: cosicche anche da questo punto di vista la tesi
pigoriniana di, una discesa unica di Etruschi edi ltalici ha perduto ogni
consistenza. Di qui la teoria del De Sanctis tendente a riconoscere gli Etruschi
nei crematori e gl'ltalici negli inumatori del vecchio ceppo eneolitico (meglio
noi diremmo ora, nelle genti di tradizione appenninica). Sul piano di una
grossolana identificazione dei fatti archeologici con quelli etnico-linguistici
queste equazioni sarebbero le sole idonee a spiegare la già constatata
corrispondenza delle aree dell'inumazione e della cremazione rispettivamente con
le aree indoeuropea e non indoeuropea d'ltalia. Ma è evidente, specialmente oggi
alla luce delle più recenti scoperte, che non si può parlare in blocco di
«crematori» come rappresentanti di un'unica e precostituita realtà
etnico-linguistica; che il villanoviano non è una cultura introdotta già formata
da qualche area esterna a quella del suo sviluppo, ne presenta forme più antiche
a nord dell' Appennino, ma anzi ha i suoi precedenti immediati piuttosto nel
«protovillanoviano» peninsulare, e tra l'altro proprio nell'Etruria tirrenica
(dai Monti della Tolfa al Grossetano); che fasi arcaiche di culture di crematori
affini al «protovillanoviano», come il «protolaziale» e il «protoveneto»,
appaiono all'inizio delle culture del ferro del Lazio e del Veneto, spettanti a
popoli storici di lingua indoeuropea ma di origine diversa, cioè rispettivamente
ai Latini e ai Veneti. Con ciò cade anche - o si riduce nella sfera delle
congetture indimostrabili - l'opinione del Pareti che i «protovillanoviani»
rappresentino originariamente una sola stirpe, quella degli ltalici orientali
(ipotesi tanto più inverosimile in quanto in età storica gl'Italici orientali
sono principalmente inumatori), e che una successiva ipotetica ondata di
«villanoviani» rappresenti la discesa degli Etruschi. Si tratta, come si vede,
di giuochi di pazienza senza alcun fondamento di verosimiglianza critica. In
nessun modo l'archeologia può dimostrare un «arrivo» degli Etruschi dal
nord.
Altro argomento a svantaggio della tesi settentrionale è proprio il
rapporto della lingua etrusca con la lingua preellenica di Lemno. Per spiegarlo
occorrerebbe accettare la tesi del Kretschmer di un'immigrazione parallela dal
bacino danubiano, per via continentale, nell'Egeo settentrionale e in Italia; ma
resterebbero pur sempre da spiegare gli elementi affini all'etrusco nella
toponomastica «tirrenica» dell'Italia peninsulare, che sono profondi e diffusi.
Ciò non esclude tuttavia la presenza in etrusco di elementi linguistici
continentali, ricollegabili a linguaggi nordico-occidentali del substrato
preindoeuropeo (come il «ligure» o il «retico») o addirittura a lingue
indoeuropee. Ma questo prova, se mai, una larga coincidenza e mescolanza locale
di fattori di diversa origine, attraverso una complessa sovrapposizione di aree
linguistiche.
Anche la tesi dell'autoctonia, intesa in un senso assoluto e
schematico, presenta il fianco a fondate critiche. Il punto di vista dei
linguisti (Trombetti, Ribezzo, Devoto, ecc.), che riconosce nel fondo
dell'etrusco il relitto di una più vasta unità linguistica preindoeuropea, è
teoricamente ineccepibile, in quanto tiene conto delle affinità mediterranee
della lingua etrusca e della presenza del substrato «tirrenico», rivelato
soprattutto dalla toponomastica, in gran parte del territorio italiano.
Viceversa la ricostruzione specifica dei fatti in base ai dati archeologici,
tentata dall'Antonielli e dal Devoto, si dibatte contro gravi difficoltà. Essa
presuppone una netta contrapposizione etnica tra indigeni inumatori
dell'eneolitico e dell'età del bronzo, e «villanoviani» crematori discesi da
settentrione, identificando i primi con lo strato primitivo «tirrenico», i
secondi con gli invasori italici indoeuropei. Ancora una volta la constatazione
della corrispondenza pressoche esatta delle aree d'incinerazione e di inumazione
rispettivamente con l'area non indoeuropea e con quella indoeuropea si oppone
alla ricostruzione astratta degli autoctonisti. Proprio l'Etruria, dove è tipica
e densissima l'occupazione degli incineratori, sarebbe il solo cantone
dell'Italia in cui la lingua primitiva avrebbe conservato i suoi caratteri sino
alla pienezza dei tempi storici; mentre invece le lingue italiche avrebbero
trionfato nella parte orientale della penisola, dove non si hanno tracce se non
sporadiche ed insignificanti del passaggio dei supposti incineratori
italici!
È chiaro che l'autoctonismo linguistico non può essere costretto
entro l'assurdità di questi schemi archeologici, nei quali appare ancora così
evidente l'impronta del vecchio preconcetto pigoriniano. Invano Devoto tentò di
ricondurre l'equazione incineratori = Italici al concetto di una corrente
«protoitalica» di cui però nulla chiaramente risulta nei fatti positivi
dell'etnografia storica italiana. In ogni caso un puro autoctonismo si presenta
a priori come una teoria antistorica: ed in concreto urta contro l'evidenza di
vicende culturali che denunciano influenze europee ed orientali e contro i dati
linguistici che dimostrano rapporti tra l'Etruria e l'Egeo oltre che una
profonda penetrazione di elementi indoeuropei nella lingua etrusca.
I
Villanoviani
Si denomina così la cultura dell’età del Ferro
caratteristica del territorio dell’Etruria, dell’Emilia centrale (area
delimitata dai corsi del Panaro, del Po e del Santerno), della Romagna orientale
(bacino del Marecchia), a Capua e a Pontecagnano. Così chiamata dalla scoperta
del Gozzadini nel 1850 a Villanova di Castenaso (Bo) di un centinaio di tombe
caratterizzate dalla sepoltura in pozzetti:
- rivestite da ciottoli (tomba a
pozzetto);
- limitata da lastre di pietra (tomba a cassetta);
- scavati
nel tufo, all’interno di grandi ovuli (tombe a ziro) nei quali veniva posto un
ossuario dalla tipica forma biconica coperto da una ciotola (femminile) o da un
elmo (maschile) contenente le ceneri del defunto. Il corredo era caratterizzato:
elementi tipici maschili come i morsi di cavallo, i rasoi lunati, spilloni,
fibule serpeggianti e la spada o da elementi tipici femminili come cinturoni,
fibule ad arco rivestito o ad arco ritorto, rocchetti e fusaiole. Pochi sono gli
elmi e le spade e questo ha fatto ipotizzare che per i guerrieri ci fosse un
altro tipo di rito, ma è molto più probabile che dato l’altissimo valore del
metallo, le armi restassero in eredità ai parenti del defunto, e solo in casi
eccezionali come quello di un "re" lo accompagnassero nell’ultimo
viaggio.
Questa popolazione aveva senz’altro tutta una serie di riti
religiosi che a noi spesso sfuggono. La ricorrente presenza della "barca solare"
ci testimonia il culto solare. In un primo tempo queste tombe furono credute di
una popolazione non meglio identificata, ma col progredire degli scavi in tutta
l’Etruria queste emersero facendo chiaramente capire che queste tombe sono da
riferirsi agli antenati degli etruschi, che si imposero senz’altro con la forza
il proprio dominio dalla pianura Padana alla Campania, come è testimoniato dalla
distruzione dei villaggi della fase precedente e dal sapersi opporre alla
colonizzazione greca; manifestarono una forte identità culturale testimoniata
dalla presenza di oggetti identici nei corredi.
I villanoviani vivevano in
capanne monofamiliari di forma rotonda , realizzate in legno e fango; ve ne
erano anche rettangolari, di dimensioni maggiori, destinate alle attività comuni
e di allevamento; la loro forma ci è documentata dalle urne a capanna (usate
come cinerario in area tosco-laziale), dalla forma degli ziri e dalla stele
della casetta ora al Museo di Bologna. Erano raggruppate in piccoli nuclei. I
Villanoviani si occupavano di agricoltura, non avendo ancora affinato la
capacità di sfruttare le miniere. La ceramica che è l’evidenza materiale che più
spesso incontriamo ci testimonia una certa specializzazione artigianale
richiedendo (dato il notevole spessore) temperature elevate di 7000°-8000°, era
decorata con motivi a meandro, a zig-zag, a fascia continua ecc.. L’arte
villanoviana è straordinaria, troviamo una ricerca continua di nuove forme,
tutto può essere rappresentato.
I Villanoviani in Emilia-Romagna
Con la fine del XII secolo vengono abbandonati i siti che avevano visto una
presenza della cultura terramaricola i motivi non sono stati ancora
sufficientemente chiariti. Abbiamo uno iato (vuoto) fino al IX secolo, quando si
insediarono i primi agglomerati villanoviani, in siti apparentemente non
coincidenti con quelli precedenti. In una vasta area ad occidente del corso del
fiume Panaro non si hanno tracce consistenti di occupazione addirittura per il
periodo dal XII al VII secolo a.C.. Questo dato potrà senz’altro essere rivisto,
quando si faranno altri scavi alla ricerca delle tracce di questa fase. Ci
devono essere state cause naturali (alluvioni, irrigidimento climatico ecc) e
delle cause storiche (invasioni di altri popoli) che hanno spinto i
terramaricoli a spostarsi: è tutto da chiarire, forse ci riuscirà uno di voi
quando un domani diventerà un valente archeologo.
A Carpi, però, recenti
scavi hanno messo in luce le tracce della presenza villanoviana a Carpi S.
Croce-Via Zappiano e a Budrione - Via Gusmea, anche se sono da collocarsi
cronologicamente in quella fase di "attardamento" villanoviano caratteristica
del villanoviano bolognese, cioè tra metà VII e metà VI a.C. con una continuità
fino al V testimoniata dalla presenza di ceramica depurata etrusco-padana. A
Bologna dal IX° secolo a.C. abbiamo una moltitudine di dati che ci testimoniano
una società poco differenziata dal punto di vista sociale dedita all’agricoltura
e all’allevamento e nel Modenese: a Savignano, Castelfranco e Cognento. i
villaggi erano perlopiù arroccati su colline con le necropoli poste nelle zone
più basse.
In Romagna Verucchio è il centro principale della Cultura
Villanoviana, posto su di un colle prospiciente il fiume Marecchia, fu al centro
di intensi traffici commerciali che dall’area Baltica (Via dell’ambra), dalla
penisola Illirica, dal centro Europa, dall’area Veneta qui arrivavano. Le merci
venivano poi smerciate verso il centro Italia. Per gli archeologi è un
osservatorio privilegiato per tutto il periodo storico, infatti la sabbia e
l’aria salmastra hanno permesso al legno e ad altri materiali come stoffe,
vimini e semi di conservarsi, unico caso in tutta l’Italia, stranamente in
questo contesto i metalli si sono molto consumati. E’ stato trovato un vestito
di lino ornato di perline d’ambra e fermato con numerose fibule (spille-bottoni)
che serviva a dare l’identità fisica al defunto cremato.
I villanoviani
nella Tuscia
Con l'età del Bronzo tardo si assiste all'aumentare
progressivo della popolazione: la crescita demografica in Etruria non porta
all'aumento del numero degli abitati ma alla nascita di abitati più estesi, più
popolosi, meglio organizzati.
Questa fase vede la nascita dei primi nuclei di
quasi tutte le future città dell'Etruria storica: è l'inizio dello sviluppo
protourbano che si manifesta con la formazione di grandi abitati, posti sempre
su pianori difesi, ma di superficie nettamente superiore rispetto ai villaggi
protovillanoviani, talvolta superiore ai 100 ettari. I siti più importanti di
questa fase sono, da Sud a Nord, Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci (Canino),
Orvieto, Vetulonia, Chiusi e Volterra. La maglia dei territori dei centri
villanoviani mostra come sia aumentata l’estensione del territorio posto sotto
il loro controllo politico, da poche decine a 1000-2000 chilometri quadrati:
questo processo, denominato sinecismo, denota un marcato aumento della
compattezza politica del popolo etrusco che, proprio in questa fase iniziale
dell'Età del Ferro, inizia a delinearsi come entità politica e culturale
autonoma e peculiare.
Lo sviluppo dei siti nel luogo delle future città
etrusche avviene precocemente nell'Etruria settentrionale: Populonia e Vetulonia
sono gli abitati che mostrano per primi il costituirsi delle grandi comunità, e
già nel X secolo a.C.. Molte comunità villanoviane sembrano sorgere su siti che
hanno già visto fasi dell'età del Bronzo, o almeno della fase finale, dal X
secolo a.C.. Bisogna ricordare che testimonianze della cultura villanoviana sono
state rinvenute non solo nel territorio dell'Etruria propriamente detta, ma
anche in Emilia Romagna, nelle Marche ed in Campania, sul litorale salernitano:
si è discusso molto se considerare le emanazioni extra-Etruria come "colonie"
etrusche o come semplici influenze culturali su popolazioni locali. Fatto certo
è la forte e quasi totale permeazione di elementi villanoviani in queste
zone.
Con l'inizio dell'età del Ferro, nel IX secolo a.C., la popolazione si
concentra in gruppi anche di migliaia di individui in grandi centri: questi sono
situati al centro di territori molto vasti e sono formati da nuclei abitati
distinti che occupano pianori e colline adiacenti. All'interno delle aree
controllate da ciascun centro sono presenti degli abitati molto più piccoli,
posti talvolta nelle zone di confine con il territorio di altri centri: è stato
supposto il loro ruolo di centri satellite posti a controllo del territorio. In
quest'ultimo sono presenti risorse diverse come, ad esempio, colture, pascoli,
aree metallifere; spesso il centro egemone sorge nei pressi di importanti assi
viari, fluviali od in prossimità di approdi costieri, da cui dista circa 4-5 km
in media. Caso unico Populonia, in Toscana, che sorge proprio sulla costa,
grazie probabilmente al suo ruolo di utilizzatrice del metallo dell'Isola d'Elba
e, per questo, al controllo del traffico marittimo da e per l’isola tirrenica.
Riguardo alla presenza di vari nuclei di abitato all'interno di un solo
insediamento, si cita ad esempio Veio, che ne mostra diversi (Campetti, Macchia
Grande, Portonaccio, Comunità, sullo stesso pianoro, e Piazza d'Armi, Isola
Farnese, Monte Campanile, Vaccareccia, su colline prospicenti); la distribuzione
frammentata dei vari nuclei d'abitato è delineata anche dalle diverse necropoli
(Valle la Fata, Quattro Fontanili, Casal del Fosso, Grotta Gramiccia). La stessa
situazione è mostrata dai nuclei abitativi di Tarquinia (pianori della Civita,
del Calvario, di Tarquinia moderna) e dalle diverse necropoli (Poggio
Selciatello, Poggio Selciatello di Sopra, Poggio Selciatello di Sotto, Poggio
dell'Impiccato, Arcatelle e "Le Rose").
Per ricostruire la struttura interna
degli abitati dell'età del Ferro ci si può purtroppo attenere a pochi dati di
rilievo, poiché sono pochi gli scavi archeologici effettuati all'interno di aree
abitate di questo periodo. A Veio lo Stefani all'inizio del secolo ha messo in
luce le tracce di capanne circolari piccole (Veio-Piazza d’Armi) e ovali più
grandi (Portonaccio e Campetti). A Torre Valdaliga (Civitavecchia) e
nell'abitato della Mattonara (Civitavecchia) sono state rilevate strutture a
pianta circolare, ovale e rettangolare. Al villaggio del Gran Carro sul Lago di
Bolsena appaiono anche abitazioni su palafitta poste sulla riva lacustre,
sopraelevate per un probabile innalzamento del livello delle acque.
L'insediamento villanoviano meglio conosciuto è quello di Tarquinia-Monte
Calvario: sono state rinvenute le piante di 25 capanne a pianta ovale,
rettangolare allungata e quadrangolare. Queste abitazioni non differiscono molto
da quelle dell'età del Bronzo e si nota, all'interno degli abitati, tra le
capanne, l'esistenza di aree coltivate e destinate al ricovero degli
animali.
Dalle urne a capanna rinvenute in Etruria e nel Lazio antico è
possibile conoscere quale fosse la struttura in elevato di queste abitazioni. Si
tratta di capanne dal tetto a doppio spiovente o a quattro falde, con struttura
lignea ricoperta da frasche, talvolta coibentate ed impermeabilizzate da argilla
asciugata all'aria, frammista a paglia e, come accade ancora oggi in molte
civiltà capannicole asiatiche ed africane, ad escrementi di bovini. Talvolta le
abitazioni avevano, come a Luni sul Mignone (Blera), il pavimento scavato nel
banco roccioso, forse per ricavarvi un ambiente sotterraneo atto alla
conservazione delle derrate alimentari; l'elevato, per far sì che non deperisse,
essendo in materiale vegetale, appoggiava su muretti di pietrame a secco anziché
sul banco stesso. Per evitare infiltrazioni d'acqua piovana all'interno delle
capanne, attorno al perimetro delle stesse venivano scavate una o più canalette
di scolo con cui, spesso, veniva accumulata in cisterne. Al centro delle
capanne, lontano dalle pareti, c'era il focolare, "cuore" dell'abitazione, in
genere mantenuto acceso dalle donne. I fumi uscivano da aperture apposite sul
tetto.
I villaggi dell'età del Ferro, come del resto era avvenuto nell'età
del Bronzo, dovevano il proprio sostentamento principalmente all'agricoltura ed
all'allevamento; ma c'è ora un nuovo elemento a modificare la stratificazione
sociale: la specializzazione artigianale, soprattutto dei metallurghi, che porta
all'accumulo di ricchezza. Oltre a questo, il ceto emergente, quello dei
guerrieri, basa il proprio censo sul controllo delle terre e delle loro risorse,
raggiungendo posizioni di potere all'interno della società villanoviana. Il
processo di differenziazione sociale, che come abbiamo visto sembra avere una
fase embrionale nella tarda età del Bronzo, è forse mostrato dall'eccezionale
ricchezza di alcuni corredi funerari: numerosi oggetti in bronzo, ferro, alcuni
in oro, ambre, ceramiche pregiate (soprattutto dopo la ripresa dei rapporti con
il mondo egeo anche d’importazione). "Simbolo" dell'appartenenza alla classe
superiore sono le armi, gli elmi (in terracotta o, assai più raramente, in
bronzo) ed i morsi per i cavalli: questo animale, introdotto nella media età del
bronzo in area tirrenica è un chiaro segno del rango superiore di alcuni
defunti, segno che, presto, verrà accompagnato dall'uso del carro a due
ruote.
Un altro indicatore sono forse le urne a capanna, che in ambito
etrusco sono sia maschili che femminili, forse pertinenti a persone che avevano
nella società dei ruoli particolari. Alcuni autori sostengono che sia forse
presto parlare dell'esistenza di una differenziazione sociale e notano una
relativa uniformità nei corredi funerari del periodo: sono però d'accordo
sull'esistenza di un processo di stratificazione sociale, preparatorio alla
società orientalizzante "dei principi" del VII secolo a.C.. Attorno alla metà
dell'VIII secolo a.C. si assiste al passaggio tra il villanoviano tipico a
quello evoluto: si inizia effettivamente a distinguere una netta
differenziazione dei corredi, negli oggetti che li compongono, in qualità e
quantità, nella struttura stessa delle tombe (ciste di pietra), nell'apparire
del rito dell'inumazione accanto a quello dell'incinerazione. L'inumazione è
prevalentemente in fosse scavate nel terreno.
Non ci sono nette diversità nei
corredi delle tombe ad incinerazione ed in quelle ad inumazione: si nota
comunque un generalizzato aumento degli oggetti costituenti il corredo, in
particolare di quello degli inumati. La presenza di oggetti importati da altre
culture dell'Italia protostorica denota la forte mobilità delle genti
protoetrusche: sono accertati contatti e scambi con i Sardi, con le aree
transpadane (soprattutto con i paleoveneti), con le genti dell'Italia
meridionale (enotri): presto, sin dall'inizio dell'VIII secolo a.C., iniziano ad
apparire anche oggetti provenienti dall'Egeo. Come già detto, il tema dei
rapporti con genti provenienti dal mondo greco, va ricordato poiché è proprio
grazie all'influenza culturale orientale che inizia quel processo di permeazione
degli elementi greci, definito ellenizzazione, che influenzerà moltissimo la
cultura etrusca per tutta la durata di questo popolo.
Se alla fine dell'VIII
secolo a.C. si assiste all' esplosione orientalizzante in cui appare chiara la
civiltà etrusca d'età storica con la sua stratificazione sociale, la sua
cultura, le sue forme politiche ed economiche, lo si deve in buona parte anche
all'influenza greca. Il rapporto con i Greci si fa più intenso dopo la
fondazione da parte di questi dell'emporio di Pithekusa (Ischia) e della colonia
di Cuma. Gli abitati aumentano nettamente la propria popolazione e si estendono
in nuclei attigui, allargandosi su diversi pianori. Le abitazioni sono ancora in
capanne più o meno complesse: si prepara però la fase preurbana dell'età
Orientalizzante in cui iniziano ad apparire, all'interno degli abitati, alcune
unità abitative assai più articolate; anche qui, data la relativa scarsità di
dati, esse sono riconoscibili soprattutto dalla pianta complessa delle tombe a
camera orientalizzanti, arricchite da elementi architettonici scolpiti, a
ricordare struttura interna ed architettura domestica. Le abitazioni presentano
il tetto di frasche fino alla metà del VII secolo a.C. e ciò può essere
testimoniato dalla tomba "a capanna" di Cerveteri e dalla camera laterale
sinistra del Tumulo Cima di Barbarano Romano, in cui appare sia il tetto
semicircolare tipico delle capanne, che la struttura con orditura lignea tipica
dei tetti con tegole: il Tumulo Cima è databile attorno al 650 a.C..
Le
prime aree pubbliche, più o meno monumentalizzate, non appaiono prima della metà
del VII secolo a.C.: esempi possono essere la cisterna di Veio, un luogo di
culto di Roselle e la monumentalizzazione dell'area della Civita di Tarquinia.
Secondo alcuni autori con l'istituzione di tali strutture civiche si può
considerare concluso il lungo processo di evoluzione urbana iniziato
embrionalmente nel IX secolo a.C.. I gruppi di aristocratici apparsi nettamente
nel Villanoviano evoluto sono alla base di quell'esplosione culturale, economica
e sociale che porterà alla fase storica del popolo etrusco iniziata con il
"periodo orientalizzante" (fine VIII - fine VII secolo a.C.). Tra i siti
principali della provincia di Viterbo che hanno restituito testimonianze della
cultura Villanoviana, cioè della fase etrusca dell'età del Ferro, ricordiamo
Vulci, Tarquinia, Bisenzio (Capodimonte), Vetralla, Barbarano Romano, Civita
Castellana, San Giovenale e Luni sul Mignone (Blera): esse sono visibili nei
Musei Archeologici di Vulci (Castello della Badia), di Tarquinia (Palazzo
Vitelleschi), Barbarano Romano (Museo Civico), Bolsena (Castello Monaldeschi -
Museo territoriale del Lago di Bolsena), Civita Castellana (Forte del
Sangallo).
La Storia
Estensione territoriale e sviluppo dell'Etruria
interna
L’espansione e l’apogeo degli Etruschi in Italia
L’alleanza
cartaginese e gli scontri con i Greci e con Roma
L’Etruria
“federata”
L’epilogo etrusco: i Galli e Roma
Estensione
territoriale e sviluppo dell'Etruria interna
In Tuscorum iure paene omnis
Italia fuerat: quasi tutta l'Italia era stata sotto il dominio degli Etruschi,
dice Catone (Servio, ad Aen., XI, 567); e Livio (I, 2; V, 33) insiste sulla
potenza, sulla ricchezza, sulla fama degli Etruschi in terra e in mare dalle
Alpi allo stretto di Messina. I dati archeologi ci ed epigrafici e le notizie di
altre fonti storiche confermano il valore di queste tradizioni, pur limitandone
la genericità e consentendo di chiarire con sufficiente approssimazione quali
territori italiani furono propriamente abitati e quali sottomessi dagli Etruschi
o in qualche modo da loro influenzati politicamente, economicamente o
culturalmente.
Consideriamo anzitutto quella che siamo soliti denominare
Etruria propria, compresa tra il Mare Tirreno, il corso del Tevere e il bacino
dell' Amo, cioè l'Etruria storica costituente la Regione VII dell'Italia
augustea. Ad essa appartengono le dodici città (dodecapolis) che secondo il
canone tradizionale formavano la nazione etrusca. La tradizione antica ha
accreditato presso gli storici moderni l'idea che questo territorio fosse la
sede originaria della stirpe, dalla quale sarebbero partite le imprese marittime
e le conquiste terrestri (verso il Lazio e la Campania e verso le zone
transappenniniche). Ma su questa semplice affermazione occorrerà comunque un più
approfondito giudizio critico.
Già trattando delle origini etrusche si è
fatto cenno alle ipotesi di una progressiva «etruschizzazione» dell'Etruria
storica che, secondo i sostenitori della provenienza trasmarina dei Tirreni,
sarebbe logicamente avvenuta partendo dalle coste verso l'interno, con la
sottomissione o l'incorporazione di elementi indigeni italici (gli Umbri di
Erodoto). A riprova della esistenza di questo originario fondo italico e della
persistente eterogeneità etnica di aree comprese entro i confini geografici
dell'Etruria si addusse tra l'altro l'abbondante presenza di nomi personali di
origine italica nelle città etrusche, per esempio a Caere, ma non soltanto a
Caere (l'Etruria settentrionale è particolarmente ricca di tali elementi
soprattutto in tempi recenti); si è dato inoltre particolare valore al fenomeno
dei Falisci, di lingua originariamente latina, abitanti nell'ansa orientale del
Tevere, oltreche al ricordo dei Camertes Umbri dell'Etruria interna e di Umbri
Sarsinates per la zona di Perugia.
Ma il significato di queste constatazioni
può rovesciarsi, considerando l'eventualità (che è del resto controllabile in
molti casi) di penetrazioni storiche sabine e umbre in Etruria specialmente
nelle zone di confine e di processi di latinizzazione come a Caere dopo
l'imporsi dell'egemonia romana nel IV secolo a.C. Soltanto nel caso del
territorio falisco riconosciamo effettivamente la presenza originaria di una
popolazione di lingua non etrusca stabilita sulla riva destra del Tevere, in
presumibile continuità con l'area latina estesa a sud oltre il fiume; ed è
significativo che in questa zona, come nel Lazio, manca la tipica cultura del
ferro villanoviana, che invece è presente, vistosissima, nel non lontano centro
di Veio. Il territorio falisco subì certamente un'influenza politica e culturale
etrusca determinante, soprattutto in età arcaica, non diversamente da alcune
parti del Lazio inclusa la stessa Roma (la ricorrenza di iscrizioni etrusche
accanto a quelle falische è prova del bilinguismo delle classi dominanti); ma
poi prevalsero pressioni ed infiltrazioni di elementi italici sabini che
caratterizzarono fortemente il dialetto locale. In ogni caso possiamo
considerare assolutamente certo che fin dall'inizio dei tempi storici esiste un
mondo etrusco ben definito e riconoscibile la cui estensione coincide
sostanzialmente con quella della regione che fu chiamata dagli antichi Etruria,
cioè non solo la fascia costiera tirrenica ma anche tutto il retroterra fino
alla valle del Tevere e alle pendici dell' Appennino Tosco-Emiliano. Lo
dimostrano da un lato l'impronta unitaria della lingua documentata dalla
diffusione delle iscrizioni etrusche fin dal loro primo apparire nel VII secolo;
da un altro lato il carattere inconfondibile degli aspetti culturali a partire
dal villanoviano e per tutti i loro successivi sviluppi, in piena coincidenza
con l'univoca tradizione antica sulla etruscità di questi territori e dei
relativi centri. Ogni ipotesi circa l'eventualità di preesistenti differenze e
sovrapposizioni o commistioni etniche andrà semmai respinta più lontano nella
preistoria. Ogni progresso dalle coste verso l'interno si spiega logicamente,
non già con l'idea di una penetrazione etnica, ma con le concrete ragioni
storiche di una penetrazione d'impulsi economici e culturali provenienti dai
centri marittimi più direttamente esposti a sollecitazioni esterne. Seppure con
minore concentrazione ed intensità gl'insediamenti interni partecipano in pieno
e vigorosamente allo sviluppo dell'Etruria arcaica.
Esistono, ben s'intende,
condizioni ambientali diverse da quelle delle zone litoranee. Mancano i
fondamentali e primordiali presupposti di un accelerato incremento basato sui
contatti e sui commerci marittimi, oltreche sullo sfruttamento delle miniere
prevalentemente concentrate lungo la linea costiera, e sulla potenzialità, di
ambedue questi fattori combinati. Si offrono in compenso estese, profonde e
variate terre vallive e collinari ricche (allora) di boschi o idonee al pascolo
e specialmente all'agricoltura, costituente la base principale dell'economia;
mentre le comunicazioni interne dovevano essere favorite dalla navigazione
fluviale e lacustre e si aprivano vie di contatti e di scambi, lungo ed oltre il
corso del Tevere e dell'Amo ed attraverso la dorsale appenninica, con le regioni
centrali della penisola e con il settentrione fino al versante adriatico. A
questa configurazione del paese con le sue risorse sembrano potersi in qualche
modo ricollegare i caratteri delle forme associative e delle strutture
socio-economiche e in ultima analisi i lineamenti della storia più antica
dell'Etruria interna.
Di fatto noi vediamo apparire molto diffuso un sistema
di piccole aggregazioni sparse nel territorio o più intensamente addensate in
zone presumibilmente favorevoli a coltivazioni granarie od ortofrutticole o a
vigneti (quando fu introdotta e si diffuse la vite) o al piccolo allevamento:
tipici gli esempi attorno al lago di Bolsena, lungo la valle tiberina, nei
territori di Chiusi, di Volterra, ecc.; si può parlare di persistenze della
tradizione dei villaggi preistorici, ma anche di fattori economici e sociali che
possono aver determinato lo sviluppo di insediamenti rurali ed un incremento
demografico decentrato. L 'emergere di ceti dominanti, cui si deve ovviamente
ogni impulso innovatore, poggia soprattutto sul possesso terriero: ne cogliamo
un riflesso nei grandi sepolcri a tumulo con ricchi corredi funebri più o meno
isolati nelle campagne (presso Cortona, nel Chianti, nella valle dell' Amo),
contemporanei e simili a quelli che appaiono invece accorpati nelle grandi
necropoli urbane di Caere, di Tarquinia, di Vetulonia, di Populonia. C'è poi da
considerare la frequenza di centri di maggiore consistenza aventi carattere di
«borghi» generalmente in altura e muniti (in latino si sarebbero detti oppida),
per i quali si può pensare a comunità autonome in qualche modo affini ai piccoli
popu/i ricordati dalla tradizione per il Lazio protostorico: ne conosciamo
esempi rilevanti, anche per le loro testimonianze archeologiche, soprattutto
nell'Etruria meridionale e centrale, come San Giovenale, San Giuliano, Blera,
Norchia, Tuscania, Acquarossa, Bisenzio, Castro, Poggiobuco, Pitigliano,
Satumia, ecc. Alcuni di questi abitati, come quelli molto simili del vicino
territorio falisco, ad esempio Narce, risalgono a nuclei dell'età del bronzo.
Alla loro vitalità arcaica sembra aver fatto seguito dopo il VI secolo una
decadenza talvolta fino alla sparizione (è il caso di Acquarossa presso Ferento)
per il mutare delle condizioni economiche e politiche determinato dalla crescita
delle grandi città, sia litoranee sia interne, da un più marcato imporsi del
loro dominio territoriale, da presumibili fenomeni di inurbamento, di
accentrazione fondiaria, di insicurezza delle campagne a seguito di eventi
bellici, minacce esterne, ecc.; ma alcuni dei vecchi centri di media grandezza
avranno all'opposto rilevanti sviluppi in età avanzata (Sutri, Tuscania,
Sovana).
Un caso particolare rivelato dagli scavi recenti è quello dello
splendido complesso architettonico-urbanistico di Poggio Civitate presso Murlo
nel territorio di Siena che dà l'impressione di una fondazione principesca,
santuario e forse anche residenza, fiorita fra il VII e VI secolo e poi
praticamente abbandonata, richiamando in certo senso a quel sistema di dominii
gentilizi che parrebbe altrimenti intravvedersi, soprattutto nel nord, dai
grandi sepolcri monumentali extraurbani. Ma l'Etruria interna ha anch'essa le
sue città, seppure meno numerose e addensate di quelle della fascia litoranea.
La nascita e lo sviluppo di alcune di esse, meno distanti dal mare come Veio e a
nord Volterra, o più arretrate come Volsinii (Orvieto) e Chiusi, avvengono
contemporaneamente ai processi formatori delle città costiere e sostanzialmente
con le stesse caratteristiche. Per altri centri che avranno pari dignità in
avanzata età storica come Perugia, Cortona, Arezzo si può discutere, alla luce
dei dati archeologici finora conosciuti, se il vero e proprio accentramento
urbano si sia attuato più lentamente, per il perdurare di forti nuclei abitativi
nei possedimenti aristocratici delle campagne; ma anche se l'origine può essere
stata diversa queste città esistevano già certamente in età arcaica.
Ciò che
appare soprattutto interessante è il fatto che le città dell'Etruria interna si
trovano disposte in qualche modo ad arco o a corona lungo una fascia
approssimativamente corrispondente ai confini geografici dell'Etruria: da sud a
nord, a breve distanza dalla riva destra del Tevere, Veio, Falerii (seppure di
origini falisce), Volsinii (nella zona di confluenza del Paglia con il Tevere),
Perugia; al margine dei monti confinanti con l'Umbria Cortona; lungo l'Arno
Arezzo e Fiesole; ne si escludono del tutto da questo sistema, benche meno
periferiche, Chiusi e Volterra. Senza dubbio esiste un generale rapporto con le
grandi vie fluviali. Ma non si può sfuggire all'impressione che nell'ubicazione
delle città si configuri anche una sorta di delimitazione protettiva che in
certo senso conferma l'idea di un'antica concezione unitaria del territorio
etrusco.
Per altro verso proprio la marginalità di questi centri deve aver
offerto possibilità di contatti e di scambi con le confinanti regioni esterne,
oltreche di aperture a fenomeni espansivi: quali s'intravvedono per Veio (e per
il territorio falisco) con il Lazio e la Sabina; per Volsinii e Perugia con
l'Umbria; per le città più settentrionali in genere con i paesi d'oltre
Appennino.
Una vera e propria ricostruzione di eventi storici, di
politica interna ed esterna, nell'età più antica è impossibile come per
l'Etruria costiera. È immaginabile uno sviluppo parallelo e notevolmente
differenziato dalle singole zone per l'ampiezza del territorio e per la
diversità delle situazioni e delle gravitazioni come si è già accennato. Di
primitive monarchie, sorte dai ceti egemonici o come prevalente affermazione di
piccoli potentati locali, possediamo soltanto echi leggendari (e naturalmente
d'incerta autenticità e cronologia): così per Veio si ricordavano un re Morrius
o Mamorrius discendente di Halesus fondatore di Palerii (Servio, ad Aen. VIII,
285) ed un re Propertius connesso con le origini della città di Capena (Catone
in Servio, ad Aen. VII, 697), ed inoltre un re Velo Vel Vibe vissuto ai tempi di
Amulio di Albalonga, cioè riferibile all'VIII secolo a.C. secondo la cronologia
tradizionale; più concretamente le iscrizioni arcaiche ci danno nomi di stirpi
gentilizie di alto rango di cui una, i Tulumne, assurgerà al potere regio, se
non prima, nel V secolo. È difficile dire quali rapporti, di rivalità, di
alleanza, ecc., vi siano stati fra i centri dell'Etruria interna e tra questi e
i centri costieri: una immagine piuttosto attendibile di queste situazioni nella
prima metà del VI secolo potrebbe riflettersi nel fregio «storico» dipinto della
Tomba Francois di Vulci (posteriore di oltre due secoli agli avvenimenti, ma
fondato, come crediamo, su buone tradizioni), che mostra figure e nomi di
principi o capi di alcune città, come Laris Papathna di Volsinii (Velznax) e
Pesna Arcmsna forse di Sovana (Sveamax), collegati a quanto sembra con Cneve
Tarchunie, cioè un Tarquinio di Roma (Rumax), contro condottieri e avventurieri
provenienti da Vulci. Ancora più difficile è ipotizzare se, o fino a che punto,
già in età arcaica si siano venute determinando quelle tradizioni o istituzioni
di colleganza stabile, religiosa e in parte politica, tra le «dodici città»
dell'Etruria, che in età più recente vedremo incentrata intorno al santuario del
dio Voltumna, il Fanum Voltumnae, a Volsinii o presso Volsinii, e che porterà al
prestigio e alla fama di questa città come «capitale dell'Etruria» Etruriae
caput (Valerio Massimo, IX, 1).
Ma il momento del grande sviluppo,
socialmente rivoluzionario, di Volsinii, sembra doversi collocare - alla luce
delle testimonianze archeologiche ed epigrafiche delle necropoli di Orvieto -
piuttosto negli ultimi decenni del Vl secolo come si avrà occasione di
sottolineare più avanti, Certamente invece molto antica, e straordinaria, è la
fioritura economico-culturale, e di conseguenza presumibilmente la potenza, di
Chiusi, situata nel cuore dell'Etruria centro-settentrionale, in una posizione
eccezionalmente favorevole di accessi e di transiti al centro di densissimi
abitati, con irradiazioni verso l'alta valle del Tevere e Perugia attraverso il
Lago Trasimeno e le vie terrestri, e da un altro lato verso il Senese (si pensi
al già ricordato «santuario-palazzo» di Murlo, dove si manifestano influenze
artistiche chiusine); cosicchè non deve far meraviglia che la tradizione storica
registri sul finire del VI secolo una espansione politico-militare di Chiusi in
piena area costiera tirrenica, con la spedizione del re Porsenna contro Roma,
spiegabile soltanto immaginando un'egemonia della monarchia chiusina
progressivamente acquisita già nei decenni precedenti su gran parte dell'Etruria
interna.
L’espansione e l’apogeo degli Etruschi in Italia
A questo punto, considerata l'Etruria propria, converrà affrontare il
quadro di quella più vasta «Etruria» che oltre i confini geografici del Tevere e
dell' Appennino fu creata dall'espansione non soltanto economica e politica, ma
anche in parte notevole stanziale e demografica degli Etruschi in altri
territori dell'ltalia antica. Espansione, va detto subito, che anche e
soprattutto alla luce delle scoperte e delle valutazioni critiche più recenti
deve ritenersi assai più precoce di quanto si credesse in passato, diremmo
addirittura contestuale al primo manifestarsi della civiltà etrusca, comunque in
atto già per diversi aspetti avvenuta all'inizio dei tempi storici: se, come
dobbiamo presumere ed abbiamo già fondatamente supposto, la presenza del
villanoviano a sud nel Salernitano e a nord in alcune zone dell'Emilia e della
Romagna significa presenza etrusca (o, se si preferisce volendo giocare sui
termini, protoetrusca).
Ma va anche detto subito e fermamente che non sembra
lecito rinunciare al concetto di espansione, cioè di stanziamenti secondari o
conquiste, per ipotizzare vaghe e confuse insorgenze etniche in luoghi lontani;
e ciò per due ragioni: 1) in primo luogo per il rispetto dovuto alla tradizione
storica antica che esplicitamente e concordemente parla di fondazioni o
colonizzazioni etrusche in Campania e nell'ltalia settentrionale; 2) inoltre per
la reale differenza che si percepisce, sulla base dei dati linguistici,
archeologici e storiografici, fra il territorio compat- tamente etrusco
dell'Etruria propria e le regioni esterne nelle quali convivono altre stirpi,
lingue e tradizioni e nelle quali l'etruschizzazione, anche se intensa, appare
comunque limitata nello spazio oltre che nel tempo. Ciò premesso, sempre sul
piano generale non può sfuggire alla nostra attenzione il fatto che la
espansione etrusca, lungi dal manifestarsi concentricamente attorno all'area
originaria, appare orientata secondo un lungo asse longitudinale che scende a
sud seguendo il versante tirrenico in direzione della Campania e sale a nord
attraverso l'Appennino Tosco-Emiliano verso la pianura padana, lasciando
praticamente intatto e non superato il confine orientale del Tevere che separa
l'Etruria dall'Umbria. La spiegazione dell'appariscente fenomeno potrà
ricercarsi, se non andiamo errati, proprio nelle condizioni dei tempi remoti ai
quali risalgono le prime spinte espansive, in parte collegabili con le attività
marittime, lungo il Tirreno, in parte identificabili con fattori d'attrazione
delle piaghe transappenniniche, mentre meno favorevole doveva apparire una
penetrazione verso l'interno della penisola anche per la forte presenza e
pressione di quelle genti italiche che sono storicamente conosciute come Sabini
e Umbri.
Verso il Sud
Il dominio etrusco in Campania, la cui
storicità fu rivendicata da una classica opera di J. Beloch contro precedenti
scetticismi, è largamente comprovato dalle fonti letterarie antiche, dai
documenti epigrafici e dalle testimonianze archeologiche. Gli scrittori greci e
romani parlano della fondazione di una dodecapoli (Strabone, V, 4,3)
evidentemente sul modello di quella dell'Etruria propria, e più specificamente
dell'origine o dell'occupazione etrusca di Capua, considerata la capitale, NoIa,
Nocera, Pompei e altri centri campanr. Le iscrizioni etrusche sono piuttosto
abbondanti, e tra queste primeggia la tegola di Capua, che è il più lungo testo
in lingua etrusca che possediamo dopo il manoscritto su tela della Mummia di
Zagabria. Il materiale archeologico e le opere figurate presentano più o meno
spiccate, a volte strettissime, analogie con gli aspetti e le sequenze culturali
dell'Etruria fino al V secolo. Occorrerà tuttavia, per dare una più sicura e
precisa dimensione storica a questo quadro generale, cercare di definirne per
quanto possibile i termini geografici e cronologici.
Va comunque ricordato
che la presenza degli Etruschi in Campania costituisce soltanto uno dei fattori
che concorrono a definire la fisionomia etnica, politica e culturale,
estremamente complessa, di questa regione la cui funzione fu d'importanza
primaria - e per certi aspetti ed in alcuni momenti determinante - nella storia
dell'ltalia antica. Gli altri fattori sono le popolazioni indigene, variamente
denominate Ausoni, Opici, Osci, Sanniti, Campani; e la colonizzazione greca. La
tradizione antica fu propensa a schematizzare questa pluralità etnica nel senso
di una successione di invasioni ed occupazioni: ciò che in parte, ma solo in
parte, corrisponde a reali avvicendamenti storici. Più concreta appare invece la
prospettiva geografica, che delimita la presenza greca alla fascia costiera del
golfo di Napoli (fondazioni degli Eubei a Pithecusa, cioè lschia, e a Cuma, con
estensione a Partenope o Paleopoli, donde poi Napoli; forse Rodii; più tardi
Samii a Dicearchia cioè Pozzuoli; mentre altri attacchi coloniali greci
s'incontrano soltanto a sud del fiume Sele); colloca l'espansione etrusca fra il
golfo di Salerno e il retroterra campano, la «mesògaia», fino al fiume Volturno;
riconosce alle genti indigene il carattere di generale sottofondo etnico e
perduranti stanziamenti marginali specialmente a nord del Volturno; ambienta i
Sanniti sull'arco montano con processo verso la pianura. È molto probabile che
le origini dell'etruschizzazione della Campania siano da collocare nel quadro
delle più antiche attività marittime degli Etruschi nel Tirreno, di cui si è già
discorso. L'apparizione di un tipo di cultura villanoviana a Pontecagnano presso
Salerno nel IX secolo con qualche riflesso verso l'interno (Valle del Tanagro),
come elemento che ha tutto l'aspetto di essere intrusivo rispetto alle dominanti
manifestazioni culturali locali di inumatori, e le successive sequenze in parte
analoghe e parallele a quelle dell'Etruria propria, includenti, ciò che è più
importante, la presenza di iscrizioni etrusche arcaiche nella stessa
Pontecagnano e nell'area della penisola sorrentina fino a Castellammaredi Stabia
e a Pompei, coincide piuttosto significativamente con le notizie delle fonti
antiche circa il possesso etrusco del litorale salernitano, cioè del cosiddetto
«agro picentino», fino alla foce del Sele e alla esistenza della colonia etrusca
di Marcina.
Il problema che si pone è quello del rapporto, cronologico e
storico, tra questi remoti insediamenti costieri e la più vasta area del dominio
territoriale etrusco interno tra il Volturno e la valle del Sarno, cioè la vera
e propria Campania etrusca avente come centro principale Capua e tutta una serie
di città caratterizzate dalla presenza di iscrizioni etrusche e di materiali
propri di una cultura materiale di tipo etrusco (benchè di regola pertinenti ad
una fase cronologica piuttosto avanzata, tra la fine del VI e la prima metà del
V secolo), come Suessula, Acerra, Nola, Pompei, Nocera: queste due ultime
costituenti in certo modo una cerniera con l' area
sorrentino-salernitana.
L'ipotesi di una netta priorità della colonizzazione
costiera pel golfo di Salerno sul dominio etrusco della mesògaia campana che ne
sarebbe stata quasi una tardiva conseguenza va attenuata o corretta nel senso di
una possibile e probabile pluralità di antiche vie di approccio dall'Etruria
propria alla Campania, e soprattutto del maturare di condizioni storiche diverse
attraverso l'età arcaica.
La stessa discussione sul problema
dell'interpretazione dei dati tradizionali circa la cronologia della fondazione
etrusca di Capua appare di secondaria importanza: i recenti scavi hanno
confermato la progressiva formazione di un grosso centro fra il IX e I'VIII
secolo, con caratteri indigeni ma con sensibili richiami alI' area culturale
etrusca, falisca e laziale, e con una progressiva affermazione di influenze
etrusche soprattutto nel VI secolo; prove sicure del carattere fondamentale
etrusco della città si avranno tuttavia soltanto per gli inizi del V secolo. Si
può presumere che alla primordiale colonizzazione, o protocolonizzazione, del
litorale salernitano abbiano fatto riscontro penetrazioni per via terrestre
(valle del Sacco e del Liri?) e per via di mare (foci del Liri e del Volturno?)
verso l'ubertosa e appetibile pianura della Terra di Lavoro; e che la precoce e
salda installazione coloniale greca nel golfo di Napoli (già almeno dalla metà
dell'VIII secolo), chiudendo questa privilegiata via d'accesso portuosa, abbia
favorito il consolidarsi di un dominio etrusco interno, a sua volta serrato ad
arco attorno alla fascia d'influenza di Cuma e tendente a sfociare al mare più a
sud alla foce del Sarno (Pompei) e nel golfo di Salerno in congiunzione con i
vecchi scali del territorio picentino. Si disegnerebbero così, con una certa
verosimiglianza, le grandi linee interpretative della storia della
etruschizzazione della Campania e della sua dialettica di contrasto con la
colonizzazione greca, ferma restando anche l'esistenza del problema dei rapporti
con le popolazioni locali, che possiamo immaginare di coesistenza e di
sovrapposizione nelle zone di più intensa occupazione etrusca, e di vicinato,
scambi e influenze nelle zone marginali specialmente a nord del Volturno, come
nel retroterra picentino, ma anche già forse di minacciosa irrequietezza lungo
l'arco montano abitato dai Sanniti dal quale proverranno gl'impulsi e i
movimenti destinati a segnare nel futuro la sorte dell'Etruria campana e
dell'intera Campania.
Gli sviluppi di questa storia nel V secolo appartengono
tuttavia ad una fase cronologica più avanzata che sarà oggetto di trattazione
successiva. La presenza e la dominazione degli Etruschi in Campania coinvolgono
naturalmente il problema dell'espansione etrusca nell'area intermedia fra
l'Etruria e la Campania, cioè nel Lazio. Una fase di prevalenza etrusca nella
storia del Lazio è esplicitamente affermata dalla tradizione antica, con
particolare riguardo ai racconti relativi alla dinastia etrusca dei Tarquini
regnante in Roma tra la fine del VII e gli ultimi decenni del VI secolo;
confermata largamente dalle scoperte epigrafiche e in generale dalle
testimonianze archeologiche e artistiche; universalmente riconosciuta dagli
studiosi moderni. Ma va subito aggiunto che, rispetto alla Campania, esiste una
differenza sostanziale. Nonostante la maggiore vicinanza geografica, anzi la
contiguità territoriale con l'Etruria, che manca alla Campania, non si può
parlare per il Lazio di un dominio etrusco definito, unitario e stabile, tanto
meno di una colonizzazione demografica, quali sono accertabili per la Campania
come si è visto; si riconosceranno semmai sovranità parziali, immigrazioni di
capi, influenze istituzionali e culturali, tali da giustificare l'impressione di
una sorta di «protettorato» che ha la sua ragione storica, evidentissima,
nell'esigenza di assicurare alle città etrusche, considerate singolarmente e nel
loro insieme, il controllo delle vie di transito terrestri e marittime (cioè di
appoggio al cabotaggio) verso la Campania. Ma il fondo della popolazione con la
sua lingua, le sue tradizioni e le sue strutture resta non etrusco, cioè latino:
ciò che senza dubbio dipende dal fatto che l'espansione etrusca a sud del
Tevere, quando avviene, trova un mondo di società protostoriche già da tempo
evolute, organizzate, sulla via dell'urbanizzazione e presumibilmente coscienti
di una loro identità «nazionale», quale è quello che ci si rivela attraverso le
scoperte archeologiche soprattutto recenti e recentissime, con le sue fasi di
cultura «protolaziale» o «albana» dei crematori della fine dell'età del bronzo e
del principio dell'età del ferro (X-IX secolo) e di cultura dei fiorenti centri
di inumatori dell'VIII-VII secolo tipicamente esemplificata dalla grande
necropoli di Decima.
La penetrazione degli Etruschi non sembra anteriore al
VII secolo. Essa appare preceduta da una serie di scambi tra i territori
dell'una e dell'altra sponda del Tevere, che tuttavia non alterano la
sostanziale diversità della loro fisionomia culturale: basti pensare che gli
aspetti caratteristici della civiltà villanoviana, che pure raggiungono le
lontane coste del Salernitano, sono ignoti al Lazio (come del resto al
territorio falisco pur situato sulla sponda etrusca). Viceversa è notevole la
diffusione nel villanoviano dell'urna cineraria in forma di capanna che ha la
sua origine e il suo epicentro nell'area laziale. I rapporti culturali piuttosto
stretti esistenti tra il Lazio e i territori di Capena e di Falerii fra il IX e
il VII secolo si giustificano con l'identità del fondo etnico-linguistico.
Ma
si può parlare anche di una più vasta rete di connessioni che include Veio, il
territorio capenate e falisco e Roma. D' altra parte su questa zona
medio-tiberina deve aver pesato, in questo stesso periodo, anche un altro
elemento di indubbia rilevanza storica, e cioè la pressione degl'italici Sabini
discesi dall'interno della penisola lungo la valle del Tevere fino a raggiungere
Roma e ad essere implicati nelle sue stesse origini. Una concreta presenza
etrusca nel Lazio è attestata dalle tombe principesche di Palestrina, l'antica
Praeneste (tombe Castellani, Bernardini, Barberini) databili intorno al secondo
quarto del VII secolo, caratterizzate da fasto si corredi orientalizzanti per
molti aspetti analoghi a quelli di Caere e dalla presenza di un'iscrizione
etrusca; inoltre dalla tomba a tumulo pure orientalizzante scoperta a Lavinio,
la città sacra costiera a sud di Roma, sotto un più tardo sacrario ricordato
dagli antichi come «tomba di Enea»; nonche dai sepolcri e dai depositi votivi di
Satricum includenti una iscrizione etrusca della fine del VII secolo. Per quel
che riguarda Roma la tradizione antica colloca l'inizio della dinastia etrusca
dei Tarquini negli ultimi decenni del VII secolo, con la «chiamata al potere» di
Tarquinio Prisco in sostituzione del re sabino Anco Marcio; ne per quanto
sappiamo esistono indizi archeologici a favore di una presenza etrusca in Roma
prima di quel momento. Tutti questi dati esigono un tentativo d'interpretazione
storica. È possibile che la richiesta di sicurezza dei confini delle città
etrusche meridionali, Caere e Veio, e di aperture commerciali e politiche verso
il sud abbiano imposto, nel momento di massima fioritura della potenza
tirrenica, la creazione di punti di controllo e l'imposizione di signorie
etrusche nei centri locali, sia all'interno in direzione della cruciale via
della valle del Sacco (come è presumibile per Palestrina), sia lungo la costa
fino a quel territorio dei Rutuli (e poi dei Volsci) che Catone ricordava sotto
il dominio etrusco.
Il «ritardo» di Roma - pur divisa dall'Etruria solo da
un guado, e dunque naturalmente esposta per prima ad un ingresso degli Etruschi
nel Lazio - costituisce un problema la cui spiegazione potrà ricercarsi, oltre
che nella stessa grandezza e potenza autonoma di un centro in rapido sviluppo
(tanto che già nel VII secolo, stando alla tradizione, era stato in grado di
distruggere Albalonga, cioè di imporre il suo predominio sulle antichissime
comunità albane nel cuore del Lazio), anche e soprattutto nell'ostacolo
rappresentato dai Sabini allora presenti e presumibilmente predominanti a
livello di direzione politica in Roma stessa (contro i Sabini appunto si
manifesterà poi, sempre secondo la tradizione, la principale attività militare
di Tarquinio Prisco assurto al potere regio). Alla tradizione annalistica
raccolta dalla grande storiografia romana (specialmente Livio e Dionisio
D'Alicarnasso) circa gli eventi dinastici e socio-politici di Roma dalla fine
del VII e per tutto il VI secolo non possiamo più negare oggi, sia pure con ogni
riserva e prudenza critica, una sostanziale veridicità storica. Combinata con
altre versioni collaterali delle fonti antiche e parzialmente confermata dai
dati epigrafici e archeologi ci (cioè topografico-monumentali e artistici), essa
ci offre un quadro sufficientemente perspicuo della presenza etrusca a Roma e
nel Lazio.
Prescindendo dai particolari aneddotici e dall'autenticità
individuale dei personaggi - di cui tuttavia non è da diffidare a priori (si
pensi ad esempio alla spiccata verosimiglianza di una figura come quella della
regina Tanaquil, con il suo prenome femminile etrusco Thanachvil di larga
diffusione nella epigrafia arcaica, nata da nobile famiglia tarquiniese ed
esperta nell'interpretazione dei prodigi celesti secondo la scienza degli
Etruschi: Livio, I, 34) -, noi possiamo riconoscere l'esistenza di una fase
iniziale di affermazione e di consolidamento della sovranità etrusca in Roma, e
di etruschizzazione di Roma, collocabile tra gli ultimi decenni del VII e i
primi decenni del VI secolo e sia pure convenzionalmente definibile come «età di
Tarquinio Prisco». Dobbiamo ritenere che allora l'aggregato romano abbia assunto
il suo volto definitivo di città unitaria ed organizzata, con una cinta
difensiva, la creazione di uno spazio pubblico (il foro) distinto dalle
abitazioni private, l'attrezzatura dell'arce del Campidoglio con l'inizio della
costruzione del tempio di Giove Capitolino, secondo esplicite notizie delle
fonti letterarie; ed effettivamente le scoperte archeologiche sembrano far
risalire a questo periodo le prime stabili costruzioni architettoniche civili e
religiose con le loro decorazioni di terracotta, soprattutto alla Regia
(presumibile santuario-dimora ufficiale dei re) e al Comizio, sopra tracce di
tombe e capanne più antiche.
Sul piano politico e sociale si presumeranno
l'avvento e la supremazia di una classe dirigente etrusca, che possiamo pensare
installata di preferenza con le proprie dimore ai piedi del Campidoglio tra la
valle del Foro e il guado tiberino, in quello che sarà il futuro Vicus Tuscus:
ne abbiamo testimonianze dalle iscrizioni etrusche, di cui due provenienti
dall'adiacente area sacra di S. Omobono (una specialmente, incisa su una
placchetta d'avorio in figura di leoncino, menziona un Araz Silqetenas Spurianas
di possibile origine tarquiniese come lo stesso re Tarquinio secondo la
tradizione); il carattere prevalentemente aristocratico della struttura dei
poteri della città al principio del VI secolo potrebbe trovare una conferma
indiretta anche nell'iscrizione dedicatoria latina del cosiddetto vaso di
Duenos, se duenos è termine generico indicante una qualità sociale del donante
(= bonus, cioè «nobile»). È importante notare che le iscrizioni in lingua
etrusca sembrano essere tutte di carattere privato, mentre il testo del famoso
cippo del Lapis Niger nel Foro Romano, ormai con sicurezza databile in questo
periodo e riferibile a prescrizioni di cerimonie sacre del re nel Comizio, è
scritto in latino e pertanto documenta, nonostante la sovranità etrusca, l'uso
del latino come lingua ufficiale dello stato.
Gli eventi e i personaggi del
regno di Servio Tullio succeduto a Tarquinio Prisco, nei decenni centrali del VI
secolo, ci appaiono in verità ricordati dalla storiografia romana con
particolari drammatici, in parte fiabeschi e talvolta persino contraddittori
(origini oscure, comunque non etrusche, del protagonista; irregolarità formali
della sua assunzione al potere; riforme e popolarità, per cui pote essere più
tardi esaltato come fondatore delle libertà repubblicane e persino ispiratore
della costituzione della repubblica: esplicitamente Livio, I, 60; imparentamento
e rivalità con la famiglia dei Tarquini, di perdurante potenza, culminanti nella
sanguinosa «presa di potere» di Tarquinio il Superbo), tali da far pensare ad un
racconto in qualche modo sistematizzato che nasconda situazioni, avvenimenti e
processi istituzionali assai più complessi. Il riferimento dell'imperatore
Claudio, nel suo discorso al Senato registrato dalle Tavole di Lione (C.I.L.
XIII, 1668), a una tradizione etrusca che identificava Servio Tullio con
Mastarna compagno di gesta di Caelius Vibenna eponimo del Monte Celio apre il
discorso sulla fondata possibilità di inserire in questo periodo - che potremmo
anche qui definire convenzional-mente come «età serviana» - tutti gli
avvenimenti e personaggi connessi con il «ciclo» semileggendario delle avventure
dei fratelli Celio (o Cele) e Aulo Vibenna (nella forma etrusca Caile e Avle
Vipina) e di Mastarna o Maxtarna (etrusco Macstrna), citate in numerosi e vari
accenni delle fonti letterarie e raffigurate nelle pitture della Tomba Francois
di Vulci oltre che in qualche altrò monumento minore. Si tratta di un' azione
militare o di un complesso di azioni militari, presumibilmente tendenti al
formarsi di una grossa «signoria» nel cuore dell'Etruria meridionale e su Roma
stessa, condotta dal «nobile duce» Celio Vibenna con il fratello Aulo, ambedue
originari di Vulci (Festo, Arnobio), e con il «fedelissimo compagno» (Claudio)
Mastarna, oltre che con altri camerati di varia estrazione, un Larth Ulthe, un
Marce Camitlna e un Rasce (l'«etrusco»?) forse di condizione servile (Tomba
Francois).
È dubbio se questa sconvolgente iniziativa sia partita da un
tentativo ufficiale di affermazione egemonica della città di Vulci, che comunque
più tardi sembra essersene appropriata la gloria come provano le pitture della
Tomba Francois; in ogni caso s'incontrò l'opposizione di altre città tra cui
Volsinii e Roma, i cui capi coalizzati (Larth Papathna di Volsinii, Pesna
Arcmsna di Sovana? , Cneve Tarchunie di Roma), dopo aver catturato lo stesso
duce nemico Celio Vibenna - liberato dall'amico Mastarna -, furono a loro volta
sconfitti e a quanto sembra massacrati (Tomba Francois). Ne conseguì la mano
libera su Roma, con il presumibile abbattimento del potere dei Tarquini che
forse in origine avevano favorito l'azione dei Vibenna (Tacito, Festo),
l'installazione di questi ultimi al margine della città (sul Celio?), infine con
la morte di Celio il probabile passaggio del dominio di Roma ad Aulo - il cui
cranio trovato sul Campidoglio farebbe parte di una storiella pseudoetimologica
tendente a spiegare il nome Capitolium come «caput Oli regis» - e quindi a
Mastarna, cioè, secondo le fonti di Claudio, a Servio Tullio.
L 'insieme di
questi fatti potrebbe collocarsi tra la fine del regno di Tarquinio Prisco e
l'inizio del «regno» di Servio Tullio, diremmo attorno ai tempi di passaggio dal
primo al secondo venticinquennio del VI secolo (Tacito, Ann.. IV, 65 accenna a
Tarquinio Prisco, ma da storico prudente avverte che per i rapporti con i
Vibenna potrebbe essersi trattato anche di «un qualsiasi altro re»: ed
effettivamente nella Tomba Francois appare un Cneve Tarchunie, un Gneo
Tarquinio, del tutto ignoto alla tradizione storiografica canonica).
La
cronologia proposta, e diciamo pure la storicità dell'intera saga dei Vibenna e
di Mastarna, trova una luminosa concreta conferma archeologica nella scoperta a
Veio dell'iscrizione dedicatoria di un Avile Vipiiennas, recante in forma
arcaica l'identica formula onomastica di Aulo Vibenna e databile nella prima
metà del VI secolo. Abbiamo dunque ragioni per credere che in questo periodo i
legami fra Roma e l'Etruriasiano stati rafforzati dalla presenza di elementi e
di poteri diversi dalla dinastia dei Tarquini. La questione diventa più
complessa per quanto riguarda l'interpretazione storica del personaggio Mastarna
che, pur nel suo stretto vincolo con i Vibenna, non ci appare necessariamente di
origine etrusca: il suo nome singolo ha tutta l'apparenza di un appellativo
qualificante o di un titolo, per di più chiaramente riferibile alla parola
latina mogister con l'aggiunta del suffisso aggettivale etrusco -no. Ciò ha
indotto alcuni studiosi moderni a supporre l'esistenza a Roma già in età regia
della funzione del mogister populi che all'inizio della repubblica avrebbe
sostituito il potere del re come magistratura suprema unica di dittatura
ordinaria, collegata al concetto di populus quale totalità dei cit- tadini, in
un quadro tendente a trasformare lo stato in una comunità egualitaria contro la
supremazia delle vecchie oligarchie gentilizie. Il «re» Servio Tullio, al quale
la tradizione attribuiva la riforma centuriata, potrebbe essere stato il
promotore di questo rinnovamento ed egli stesso esponente dell'affermazione
delle nuove classi sociali in qualità di mogister populi (donde
l'identificazione con Mastarna) in contrasto con l'ordine preesistente
rappresentato dalla dinastia dei Tarquini; la sua azione politica, dopo la
parentesi della reazione tirannica di Tarquinio il Superbo negli ultimi decenni
del VI secolo, sarebbe stata destinata a trionfare con l'inizio della
repubblica. Ma con questi avvenimenti siamo già in una fase avanzata di cui si
tratterà specificamente in una parte successiva di questo capitolo.
Verso il Nord
Passando a considerare l' opposta direttiva dell'
espansione terrestre degli Etruschi, cioè l' Italia settentrionale, dobbiamo
dire che anche qui esistono zone per le quali si può parlare, come per la
Campania, di una occupazione stanziale, cioè di un dominio di popolamento, che
s'incentra essenzialmente nell'attuale Emilia- Romagna a contatto con l'Etruria
propria attraverso i passi del crinale appenninico. Le fonti antiche alludono
insistentemente ad una colonizzazione e del pari alla fondazione di dodici
città, di riflesso delle dodici città dell'Etruria propria. Si aggiunga il
ricordo di un'azione colonizzatrice particolarmente antica, adombrata nella
leggenda che l'attribuiva principalmente a Tarconte, l'eroe delle origini
eponimo e fondatore di Tarquinia (versioni citate negli Scholia Vernonesia e in
Servio, ad Aen., X, 200, specialmente a proposito delle origini di Mantova). Una
derivazione ravvicinata dalle zone dell'Etruria settentrionale interna si
percepisce d'altra parte nelle tradizioni relative alla fondazione di Felsina
(Bologna) e di Mantova da parte di Ocnus (altrimenti Aunus, forse da Aucnus)
figlio o fratello di Aulestes, a sua volta fondatore di Perugia. A parte la
questione delle origini la presenza degli Etruschi a nord dell' Appennino
Tosco-Emiliano è larghissimamente testimoniata dagli scrittori classici, storici
e geografici, e confermata dall'archeologia con estrema dovizia di dati
incontestabili, inclusi i documenti epigrafici.
Si tratta ora di precisare,
nei limiti del possibile, i tempi, i luoghi, i caratteri e gli sviluppi di
questa occupazione. Nella più diffusa tradizione degli studi moderni la
conquista etrusca dei territori della pianura padana, cioè di quella che suol
definirsi appunto «Etruria padana», avrebbe avuto luogo con notevole ritardo
rispetto alla nascita dell'Etruria propria, e cioè non prima della fine del VI
secolo, quando a Bologna, a Marzabotto e a Spina - i centri archeologicamente
più significativi dell'etruschismo nordico - appaiono i primi segni di una
civiltà d'inconfondibile impronta etrusca e con iscrizioni etrusche.
Questa
tesi fu proposta dai primi scavatori delle necropoli bolognesi e in particolare
sostenuta da E. Brizio in rapporto alla generale teoria della provenienza degli
Etruschi dall'oriente e della loro sovrapposizione agli Umbri identificati con i
«Villanoviani», tenuto conto del perdurare della cultura villanoviana a Bologna
fino all'inoltrato VI secolo e dell'apparente distacco topografico fra i
sepolcreti appartenenti a questa cultura e le tombe di tipo «etrusco». Ma questa
interpretazione è già stata oggetto in passato di più o meno cauti dubbi, ed ora
crediamo di poter affermare con sufficiente fondatezza che l'apparizione, tutto
sommato localmente improvvisa, del villanoviano nel IX secolo debba considerarsi
la manifestazione esteriore di un iniziale passaggio di elementi etruschi dalla
Toscana oltre l'Appennino, e ciò non soltanto per le valutazioni precedentemente
espresse sul significato etnico della diffusione villanoviana in generale, ma
anche proprio per l'indizio, non da sottovalutare, di quelle tradizioni che
associavano in qualche modo la colonizzazione padana con i tempi delle origini
della nazione etrusca.
Che a Bologna in età villanoviana già si parlasse
etrusco sembrerebbe del resto dimostrato dalla recente individuazione di una
iscrizione etrusca incisa sopra un vaso della fase tardo-villanoviano di
Arnoaldi, databile intorno al 600 a.C., cioè assai prima della supposto
«conquista etrusca» della fine del VI secolo. Un altro motivo che collega ab
antiquo il villanoviano transappenninico alla grande matrice dell'Etruria
tirrenica si coglie nella sua stessa localizzazione geografica, che è
rappresentata da due zone limitate immediatamente aderenti all'Appennino: la
prima in Emilia, a Bologna e nei suoi immediati dintorni, in corrispondenza
dello sbocco delle valli dei fiumi Reno e Savena, cioè dei passi Piastre-Collina
e Futa; la seconda in Romagna, a Verucchio, San Marino ed altre località minori,
in corrispondenza e a guardia della valle del Marecchia con i suoi raccordi
montani all'alto bacino del Tevere e al Casentino. Esse hanno veramente tutta
l'apparenza di due "teste di ponte" dall'Etruria verso la pianura padana e la
costa adriatica. La cultura villanoviana di Verucchio si evolve dal IX fino al
VI secolo attraverso almeno tre fasi, di cui soprattutto la seconda presenta
singolari affinità con il villanoviano evoluto dell'Etruria meridionale, mentre
la terza fase, in cui pur resta dominante la cremazione, appare già largamente
imbevuta di elementi orientalizzanti; assai notevoli e comprensibili in ogni
caso sono i rapporti con le vicine culture medio-adriatiche di Novilara e del
Piceno.
Alla possibilità di una remota penetrazione etrusca lungo le coste
del Mare Adriatico si ricollega l'esistenza dell"'isola" villanoviana di Fermo
nelle Marche, in piena zona di cultura picena, con caratteristiche anche qui di
forti somiglianze con il villanoviano dell'Etruria meridionale; non sembra
incongruo citare in proposito il ricordo di una fondazione tirrenica, cioè
etrusca, del santuario di Hera a Cupra a non grande distanza da Fermo (Strabone,
V, 4, 2): è immaginabile una sia pur modesta attività marittima sull' Adriatico
analoga a quella coeva sul Tirreno? Per quel che riguarda il villanoviano
dell'Emilia è eviqente che esso ha attirato e attira in modo preminente
l'attenzione degli studiosi non soltanto per la priorità delle scoperte
risalenti a circa la metà del secolo scorso e per la ricchezza dei materiali, ma
anche e soprattutto per la possibilità di sistematiche classificazioni
topografi-che e cronologiche e per la continuità di vita storica del suo
maggiore centro, Bologna. L'area circostante in pianura, entro limiti piuttosto
ristretti segnati dai corsi del Panaro e del Santerno e, a nord, del Reno
presenta insediamenti di villaggi con tutto l'aspetto di una specifica
occupazione agricola (ne si può escludere che proprio la disponibilità di queste
estese terre coltivabili abbia primamente attratto gli abitatori delle zone a
sud dell'Appennino); ma l'occupazione si addensa essenzialmente a Bologna che
via via assumerà il carattere di un aggregato protourbano. Ed è a Bologna che
noi cogliamo le linee di uno sviluppo che va dal IX al VI secolo, distinto in
quattro fasi successive (più o meno corrispondenti ai periodi già designati con
i nomi delle località dei sepolcreti: Savena-San Vitale, Benacci I, Benacci II,
Arnoaldi), delle quali le ultime appaiono progressivamente imbevute di elementi
orientalizzanti, pur nella tradizionale fedeltà al rito della cremazione, con
l'apparizione di stele funerarie scolpite e il sostituirsi ai vecchi cinerari
biconici di cinerari in forma di situle (secchie) con decorazione
stampigliata.
È difficile dire quale impatto possano aver avuto le prime
penetrazioni etrusche a nord della catena appenninica con le popolazioni locali
di là dalle sfere, ripetiamo limitate, della presenza villanoviana. Di queste
altre popolazioni sappiamo del resto poco o nulla, anche dal punto di vista
della documentazione archeologica che per il resto dell'area emiliano-romagnola
e in generale per la Padania orientale risulta ancora scarsamente conosciuta
durante l'età del ferro, mal distinguibile dalle sopravvivenze della tarda età
del bronzo che fu comunque fiorente in queste zone (notevole, anche se priva di
significato storico dato il dislivello cronologico, è la netta contrapposizione
tra l'area delle terremare del bronzo nell’Emilia occidentale e l'area di
occupazione villanoviana dell'età del ferro). Fa, bene inteso, eccezione il
grosso e netto complesso di manifestazioni della civiltà Paleoveneta a nord del
Po e dell'Adige, con il suo svolgimento parallelo a quello del villanoviano
emiliano e la sua certa connotazione etnica.
Un fenomeno protostorico ben
definito che sembra fronteggiare a nord della grande piana fluviale il fenomeno
villanoviano esteso ai piedi dell'Appennino, cioè già i Veneti di fronte agli
Etruschi, e con influenze culturali via via crescenti sull'area emiliana,
sensibili soprattutto nell'ultima fase bolognese di Arnoaldi. Sui fatti della
Romagna, non rileno incerti di quelli emiliani per i tempi più antichi, si potrà
accennare soltanto ad osservazioni sporadiche specialmente in zone montane, con
particolare riguardo alle tombe di guerrieri in circoli di pietra di San Martino
in Gattara nell'alta valle del Lamone, che per altro non sono anteriori alla
fine del VI secolo e che possono oggi attribuirsi con certezza, più che a genti
indigene (o peggio a supposti invasori gallici), all'avanzata verso il nord di
Italici umbri, dei quali si avrà occasione di riparlare. In sostanza la
espansione protostorica degli Etruschi verso la pianura padana e la costa
adriatica non deve aver trovato rilevanti ostacoli in preesistenze probabilmente
non dense e forse attardate; in ogni caso essa deve esser rimasta contenuta ai
margini dello spartiacque appenninico con aspetti economici, sociali e culturali
di sostanziale conservatorismo rispetto all'Etruria propria (ciò che tuttavia
non esclude un pro gresso, accelerato tra il VII e il VI secolo, sia negli
scambi con le aree esterne tirrenica, veneta e medio-adriatica, sia negli
aspetti interni delle forme di vita e del lusso: specialmente a Verucchio, dove
più che a Bologna s'intravvede il formarsi di gerarchie economico-politiche e
conseguenti emergenze culturali).
Il solo indizio, sia pure discutibile e
discusso, di una politica attiva oltre i limiti dell'Emilia centrale e
interessata alla difesa degli equilibri dell'intera pianura padana parrebbe
riconoscersi nella notizia di Livio (V, 34) sulla battaglia combattuta, e
perduta, dagli Etruschi nelle vicinanze del Ticino contro i Galli discesi in
Italia con Belloveso e Segoveso ai tempi del re Tarquinio Prisco e della
fondazione focea di Marsiglia, cioè intorno al 600 a.C., se questa cronologia
alta dell'invasione celtica è accettabile come crediamo: saremmo comunque in un
periodo avanzato di Bologna villanoviana, corrispondente alla fase Arnoaldi, e
curiosamente proprio ai tempi nei quali si data la prima iscrizione etrusca
sopra ricordata. Ma la grande espansione etrusca nel nord, con la sua massima
estensione e con la pienezza e ricchezza delle sue più caratteristiche
espressioni, deve collocarsi effettivamente non prima degli ultimi decenni del
VI secolo, quale probabile conseguenza di avvenimenti economici e politici di
portata assai più vasta riguardanti non soltanto l'Etruria, ma l'intera area
italiana e i mari circostanti. È in questo momento, e soprattutto a partire
dagli inizi del V secolo, che l'incipiente crisi della potenza marittima etrusca
nel Tirreno può aver richiamato allo sbocco adriatico; che lo sviluppo dei
centri dell'Etruria interna (Volsinii, Perugia, Chiusi, Volterra, Fiesole) può
aver favorito un più pressante interesse per gli aperti territori d'oltre
Appennino e determinato nuove ondate di migrazione verso il nord; che
l'incremento dei traffici con l'Europa centrale attraverso le Alpi ed in pari
tempo la minacciosa pressione dei Celti già dilaganti nella pianura padana
possono aver reso necessario un consolidamento ed un ampliamento della presenza
etrusca nell'ltalia settentrionale trasformandola in vero e proprio dominio. Di
fatto vediamo ora trasformarsi l'antico centro bolognese in città, l'etrusca
Felsina; nascere subitaneamente nella media valle del Reno, quale stazione
viaria, ma probabilmente anche come centro d'interesse minerario, Marzabotto
(cui si ritiene di attribuire il nome antico di Misa), con la sua esemplare
pianta regolare a strade incrociate di tipo ortogonale che gli dà una così
evidente impronta di "colonia"; fiorire sul mare alla foce di un antico ramo del
Po la grande città di Spina aperta ad ogni traffico e ad ogni presenza e
influenza dei Greci, e più a nord Adria condominio degli Etruschi e dei Veneti
(sui quali ormai si riversa il prestigio culturale etrusco).
Nell'antica area
marittima romagnola è ricordato e in parte attestato il possesso etrusco di
Ravenna; il controllo degli Etruschi si estende anche all'Emilia occidentale
almeno fino all'Enza e forse oltre (certamente contenuto dall'opposta avanzata
celtica: priva di fondamento è l'etruscità e comunque incerta l'ubicazione di
Melpum già da molti ritenuto un avamposto etrusco in Lombardia); sicuramente fu
passato il Po verso le Alpi come provano le tradizioni dell'origine etrusca di
Mantova e taluni indizi culturali ed epigrafici, con preminente attrazione verso
la valle dell' Adige quale canale di comunicazioni transalpine fra il territorio
dei Veneti e l'espansione dei Celti, donde la tradizione liviana dell'origine
etrusca dei Reti.
La civiltà etrusca nell'Italia settentrionale tra la fine
del VI e l'inoltrato IV secolo è rappresentata tipicamente a Bologna, come nei
centri coevi e archeologicamente emergenti di Marzabotto e di Spina, dalla fase
culturale tradizionale detta della Certosa (da uno dei più rappresentativi
sepolcreti bolognesi): la caratterizzano abbondanti arredi di tipo etrusco,
larghissime importazioni di ceramica greca attica, il diffondersi del rito
funebre dell'inumazione, le stele sepolcrali figurate (essenzialmente a
Bologna), le iscrizioni etrusche. Alcuni di questi elementi possono suggerire
qualche fondata ipotesi sulle correnti d'origine, dall'Etruria propria, del
popolamento e delle influenze culturali di questa grandiosa "colonizzazione".
Molti indizi archeologici, epigrafici e onomastici ci riportano, con indubbia
verosimiglianza storico-geografica, alle città dell'Etruria settentrionale
interna quali Chiusi, Volterra e Fiesole (si pensi tra l'altro alla comune
seppur differenziata produzione delle stele nel volterrano, attorno a Fiesole e
a Bologna); transiti diretti ed antichi furono senza dubbio le medie valli
appenniniche. Ma esistono anche tracce di influenze provenienti dall'Etruria
meridionale che potrebbero far sospettare una direttiva risalente lungo la valle
del Tevere, tramite Volsinii e Perugia, fino a raggiungere la costa adriatica:
ciò che da un lato ci consente di richiamare la saga "perugina" di Aulestes e di
Ocnus, da un altro lato ci fa pensare alle remote affinità del villanoviano
romagnolo e di Fermo con il villanoviano sud-etrusco.
Quali che siano le
provenienze e i fattori di alimentazione dell'etruscità padano-adriatica, certo
essa acquistò nel V secolo una sua individualità e compattezza, attorno ai
centri maggiori (dalla polarità interna di Felsina a quella marittima di Spina),
oltreche una sua straordinaria rilevanza storica-economica, politica, culturale,
tale da giustificare la tradizione della dodecapoli nordica contrapposta alla
dodecapoli tirrena. Ma dello sviluppo e della sorte finale di queste città e di
questo dominio si tratterà in modo più specifico nel quadro della successive
vicende del mondo etrusco.
Non può tralasciarsi infine un cenno a quell'altra
direttiva di espansione etrusca verso il nord che è rappresentata dalla Liguria.
Ci troviamo di fronte a premesse e a situazioni storiche del tutto diverse, in
cui l'attività marittima deve aver avuto la sua parte di naturale rilevanza
rispetto a possibili conquiste o installazioni terrestri, con qualche analogia
(per altro vaga e diremmo embrionale) con i fenomeni dell'avanzata e della
presenza etrusca nel mezzogiorno. Il territorio compreso tra le foci dell' Amo e
la valle del Magra, cioè la Versilia e la Lunigiana, fu certamente investito da
una penetrazione etrusca già in età arcaica, anche se prevalentemente abitato da
popolazioni liguri e con una certa fluttuazione nel tempo tra Etruschi e Liguri:
lo attestano le fonti antiche (seppure con ambiguità nella sua attribuzione alle
due stirpi), alcune testimonianze archeologiche ed epigrafiche, oltre che la
finale attribuzione di queste zone all'Etruria augustea; ma la stessa Pisa, pur
nella importanza della sua posizione geografica alla foce dell'Arno, non sembra
essere mai stata tra le maggiori città etrusche, collocandosi in una zona
marginale del territorio di Volterra e quasi di confine rispetto al resto
dell'Etruria; mentre Luni avrà anch'essa un suo autentico e grosso sviluppo
urbano soltanto alla fine della civiltà etrusca. Fra l'Etruria padana e le
penetrazioni etrusche in territorio ligure non sono pensabili coerenti rapporti
sia per l'interposta area montuosa tenuta da primitive e notoriamente bellicose
tribù locali, sia anche e soprattutto per l'avanzata dei Celti. Una progressione
terrestre verso occidente non sembra del resto aver superato la Magra; mentre è
probabile, e comprovata da iscrizioni etrusche, una presenza commerciale
etrusca, forse anche al limite di un controllo "coloniale" ; nel centro portuale
di Genova; più oltre le attività marittime verso le coste provenzali debbono
aver trovato un fermo nelle istallazioni greche, effettivamente coloniali, di
Monaco e di Nizza.
L’alleanza cartaginese e gli scontri
con i Greci e con Roma
Le fonti storiche greche ci parlano per il VI
secolo a.C. di accese rivalità “internazionali” per il controllo delle rotte
marittime, dandoci notizia di vere e proprie battaglie navali tra Greci ed
Etruschi. Così, ad esempio, nel caso della battaglia combattuta l’anno 535 a.C.
circa, nelle acque del Mare Sardo, della quale ci informa Erodoto.
Si tratta
di uno degli episodi più salienti di tutta la storia etrusca, provocato
dall’intrusione greca nel “mare di casa” degli Etruschi e, in particolare, dalla
fondazione, intorno al 565 a.C., della colonia di Alalie (Aleria) sulla costa
orientale della Corsica. Protagonisti di questa impresa erano stati i profughi
della città di Focea, nella Ionia asiatica, che per sfuggire alla minaccia
persiana si erano trasferiti a più riprese in Occidente e, attorno al 600 a.C.,
si erano stabiliti alle foci del Rodano fondandovi Massalie (Marsiglia). Gli
scali marittimi e le stazioni commerciali che i Massalioti avevano installato
nel Golfo del Leone e sulle coste del Mar Ligure misero così in crisi il
commercio etrusco.
Quando l’ultima ondata di Focei provenienti dalla madre
patria occupati dai Persiani si stabilì in Corsica, gli etruschi furono
costretti a reagire. A muoversi fu Cere, la quale si alleò con Cartagine,
anch’essa seriamente danneggiata nei suoi interessi commerciali dall’intrusione
focea. L’alleanza condusse allo scontro armato al quale presero parte sessanta
navi dei Focei e altrettante di Etruschi e Cartaginesi.
Stando sempre a
Erodoto, a vincere furono i Greci, ma la vittoria rimase senza frutto “poiché -
scrive lo storico - quaranta delle loro navi furono distrutte e le restanti rese
inservibili”, sicché “essi tornarono ad Alalie, presero a bordo i figli, le
donne e quanto dei loro beni potevano trasportare e, lasciata la Corsica,
partirono verso Reggio”.
Alcuni dei prigionieri focesi furono portati a
Cere e lapidati. Coloro che passavano sul luogo dell’eccidio, racconta ancora
Erodoto, animali o uomini, “diventavano rattrappiti, storpi o paralitici”. Gli
Etruschi mandarono allora a interrogare l’oracolo di Delfi, il quale ordinò loro
di celebrare sacrifici e di tenere ogni anno giochi per placare le anime dei
Focesi massacrati.
Il successivo clamoroso episodio della lotta per il
predominio del Mediterraneo di verificò agli inizi del V secolo a.C. nel 480
a.C. quando i Greci di Sicilia, accettando la supremazia dei Siracusani,
affrontarono a Imera i Cartaginesi sbarcati in forze nell’isola sotto la guida
di Amilcare. La sconfitta dei Cartaginesi fu un colpo anche per gli etruschi,
benché non avessero partecipato direttamente al conflitto. Qualche anno dopo,
nel 474 a.C., essi dovettero affrontare Cuma, ribelle al loro predominio in
Campania, e il tiranno siracusano Gerone, da Cuma chiamato in soccorso. Furono
sconfitti in una memorabile battaglia navale presso Capo Miseno, che segnò
l’inizio del declino della loro potenza sul mare. I Greci cominciarono ad
assalire e saccheggiare le località etrusche della costa tirrenica, creando così
un calo delle attività produttive degli Etruschi, che non potevano fare più
affidamento sull’esportazione. Durante una spedizione siracusana, vennero
saccheggiate Vetulonia e Populonia.
Anche sull’Adriatico gli Etruschi avevano
cercato di espandersi. Tappe fondamentali la fondazione di Marzabotto, una sorta
di stazione intermedia in Emilia sul percorso verso il delta del Po, e di Spina,
sul mare. Spina era un emporio molto vivace, frequentato dagli Ateniesi, fino al
IV secolo a.C., quando la presenza di questi sull’Adriatico cominciò ad essere
contrastata e alla fine soppiantata dai Siracusani. Incidentalmente, era da
questi mercati adriatici che transitava l’ambra, la resina giallastra reperibile
sul Baltico, usata in gioielleria, per la quale donne, ma anche uomini, andavano
matti. Ragioni economiche più che mire espansionistiche spiegano dunque il
dilatarsi della presenza etrusca a nord e a sud della penisola.
Nel corso del
V secolo a.C. due gravi pericoli si affacciarono ai due estremi del mondo
etrusco: a nord, la pressione delle tribù celtiche penetrate da tempo in Italia
attraverso le Alpi; a sud, l’incipiente espansionismo di Roma la quale, scaduta
la tregua del 474 a.C., riprese con determinazione la guerra contro Veio. Nel
396 a.C. Veio venne conquistata e distrutta, mentre il suo territorio fu
incorporato nello Stato romano. Nello stesso anno della caduta di Veio, le fonti
storiche parlano di occupazione da parte dei Galli della prima città
dell’Etruria padana: una non meglio precisata Melpum che alcuni pensano di
localizzare nei pressi di Milano o persino di identificare con
essa.
Nell’Etruria meridionale, intanto, due fatti nuovi vennero a
caratterizzare il IV secolo a.C. Da una parte ci fu la progressiva emarginazione
di Cere che, sia pure pacificamente, finì col soccombere all’alleata Roma, alla
quale cedette il suo antico ruolo. Da un’altra parte, ci fu invece il ritorno di
Tarquinia, la quale grazie ad una accorta politica di sfruttamento delle risorse
agricole del suo territorio, riuscì a superare la crisi che l’aveva lungamente
abbattuta e a rifiorire, con ricchezza e potenza. Ma l’accresciuta potenza e la
sua stessa posizione geografica, portarono Tarquinia ad una situazione di
antagonismo con Roma, che portò alla guerra scoppiata nel 358 a.C. e che si
concluse nel 351 a.C. senza vincitori né vinti, ma con una tregua quarantennale.
Intanto sul fronte settentrionale finiva l’Etruria padana: nella seconda metà
del IV secolo infatti l’onda celtica travolse tutti i centri etruschi della
regione, compreso quello più importante di Felsina (Bologna), occupata dai
Galli. Alla fine del IV secolo a.C. gli etruschi erano ormai ridotti entro i
confini originari, peraltro già intaccati a sud dall’espansione romana. Nel 311
a.C. si riaccese la guerra contro Roma. Ancora una volta l’iniziativa dovette
essere degli Etruschi, ma protagoniste dello scontro furono ora le città
centro-settentrionali, con a capo Volsini affiancata da Vulci, Arezzo, Cortona,
Perugia e Tarquinia, svincolatasi dalla tregua appena scaduta. Nel 308 a.C.
Tarquinia rinnovò la tregua, mentre Cortona, Arezzo e Perugia si arresero
accettando condizioni umilianti. L’anno 302 a.C. la guerra etrusco-romana, non
ancora definitivamente conclusa, tornò a riaccendersi, per protrarsi, con una
serie pressoché ininterrotta di campagne annuali, fino al 280 a.C.: i Romani
quasi sempre all’attacco, gli Etruschi costretti alla difensiva e a rinchiudersi
spesso nelle loro città fortificate. Tra il 281 e il 280 a.C. si arresero per
sempre Vulci e Volsini, mentre le città settentrionali si affrettarono a
rinnovare i precedenti trattati di pace. Tutti infine dovettero sottoscrivere
patti associativi o “federativi” (dal latino foedus, trattato), in forza dei
quali mantenevano una formale indipendenza, con lo status giuridico di “alleate”
(sociae), mentre, di fatto, accettavano la supremazia di Roma, ponendosi nei
confronti di questa in rapporto di sudditanza.
L’Etruria
“federata”
La capitolazione delle città etrusche e il loro ingresso
forzato nell’alleanza con Roma segnò l’inizio dell’ultimo periodo della storia
etrusca: quello che viene definito dell’Etruria “federata”. A fondamento del
nuovo ordine imposto all’Etruria stavano dunque i vincoli federali derivanti dai
trattati. Questi ebbero, a seconda dei casi, clausole speciali e diverse,
particolarmente dure per le città che più direttamente si erano opposte a Roma e
più lungamente e duramente avevano lottato contro di essa. Includenti tra
l’altro anche l’imposizione di tributi e il controllo sulla pubblica
amministrazione.
In generale, i trattati imponevano a tutte le città di
rinunciare a qualsiasi iniziativa politica autonoma; di riconoscere come propri
gli amici e gli alleati di Roma e i suoi nemici; di fornire alla stessa Roma
aiuti ogniqualvolta essa ne facesse richiesta, specialmente in occasione di
guerre e con contributi di uomini e mezzi; di coordinare con gli interessi
Romani ogni loro attività, anche di natura produttiva e commerciale; di
garantire il mantenimento dei propri ordinamenti istituzionali fondati sul
potere delle oligarchie aristocratiche; di accettare (o di richiedere)
l’intervento di Roma in caso di gravi turbamenti sociali e di conflitti interni.
L’aspetto positivo del sistema federativo consisteva nel fatto che le singole
città continuavano a vivere la loro vita “locale”, sostanzialmente libera e
autonoma, regolata e ordinata secondo i principi e le usanze della tradizione
nazionale, di mantenere le proprie leggi, la propria lingua e la propria
religione.
La federazione fu messa a dura prova dall’invasione dell’Italia
da parte di Annibale. La seconda guerra punica (218 - 202 a.C.) toccò l’Etruria
soltanto marginalmente, durante la discesa dell’esercito cartaginese lungo la
valle tiberina, ma l’impressione suscitata dalla disfatta subita dai Romani al
Trasimeno, in territorio etrusco, fu tanto forte che nelle città etrusche si
risvegliò qualche desiderio di rivincita. Ci furono dei movimenti di simpatia
nei confronti di Annibale e qualche seria agitazione che costrinse i Romani a
rafforzare i loro presidi. Poi comunque i patti vennero rispettati e ogni città
diede il suo contributo prezioso prima alla resistenza e poi alla riscossa
romana; in particolare quando, nel 205 a.C., furono forniti aiuti massicci a
Scipione per l’allestimento della sua spedizione africana. Tito Livio scrive in
proposito che le città etrusche si comportarono ognuna secondo le proprie
possibilità e ne elenca dettagliatamente i contributi: Cere dette frumento e
viveri di vario genere; Tarquinia tele di lino per le vele delle navi; Roselle,
Chiusi, e Perugia fornirono legname per la costruzione degli scafi e frumento;
Volterra frumento e pece per le calafature; Populonia ferro; Arezzo, infine,
approntò grandi quantità di armi (3.000 scudi e altrettanti elmi e 100.000
giavellotti), strumenti e attrezzi da lavoro e 100.000 moggi (= antichi
recipienti) di grano e rifornimenti di ogni sorta da servire per quaranta navi.
Con il I secolo a.C., tra il 90 e l’89, Roma concesse agli Etruschi i diritti di
cittadinanza e nacquero così, tra l’80 e il 70 a.C., i municipi Romani
dell’Etruria. La realtà storica degli Etruschi venne infine consacrata con una
delle regioni in cui la stessa Italia venne suddivisa da Augusto: la regione
VII, alla quale toccò di perpetuare, fino alla fine del mondo antico, il nome
glorioso dell’Etruria.
L’epilogo etrusco: i Galli e
Roma
In questo paragrafo analizziamo in modo più approfondito il
rapporto tra Roma e gli Etruschi. Abbiamo già detto che l’Etruria perde la
supremazia sui mari a scapito di Siracusa e vede fallire il suo progetto di
alleanza con i Cartaginesi ed (a livello più ampio) con i Persiani sconfitti a
Salamina dagli ateniesi (filo-siracusani). Infatti presso Cuma, in particolare a
Capo Miseno, la flotta etrusca è sconfitta dai siracusani, che, successivamente,
saccheggiano le coste toscane, in particolare Populonia e Vetulonia, e l’isola
d’Elba e prendono la Corsica e Ischia (454 a.C.). In Sicilia, presso Imera,
stavolta per via di terra, gli Etruschi perdono di nuovo contro i siracusani e
contemporaneamente a Salamina la Grecia sconfigge i Persiani. Fallisce così
l’alleanza tra Etruschi, Cartaginesi e Persiani che voleva contrapporsi a quella
tra Greci e Siracusani. Nel 350 a.C. alcuni ambasciatori tirreni si recano in
Mesopotamia da Alessandro Magno, per chiedere aiuto, ma non ricevettero una
pronta collaborazione: Alessandro avrebbe preparato un’invasione dell’occidente
solo dopo circa dieci anni.
Dopo Veio, testimone della scarsa coesione tra le
città della lega, cadono le altre città, una dopo l’altra, tra cui Falerii,
capitale dei Falisci e gli avamposti di Tarquinia. Nel 387 a.C. i Celti di
Brenno sconfiggono i Romani ad Allia, devastano l’Etruria e Roma, che si
ricostruisce, anche se in un primo momento, nel quale Camillo si oppose, si
pensava di spostare la capitale da Roma a Veio. Nel 350 a.C. i siracusani
depredano Pyrgi e Caere, Roma conquista Tarquinia, con forti rappresaglie ed i
Galli dilagano in Valle Padana, non trovando la minima resistenza. Tutte le
città della lega del nord sono prese, ad eccezione di Spina e Mantova. Spina ed
Adria verranno poi prese dai greci che nel frattempo avevano fondato Ancona.
L’economia agricola è distrutta: non si produce più vino, ricompaiono le paludi
in Valle Padana, il sistema idrico è distrutto, cresce solo del grano che la
città di Spina commercia con la Grecia (non si producono più vasi attici, anche
perché la città greca di Marsiglia ha una florida attività con i Liguri e i
Galli). Per rappresaglia contro i Galli, alcuni etruschi eseguono atti di
pirateria sui carichi di grano.
Nel 310 a.C. i Romani, comandati da Q. Fabio
Rulliano, invadono e saccheggiano la Selva Cimina ritenuta sacra e inviolabile.
Gli Etruschi non seppero sfruttare le guerre sannitiche: nel 295 a.C. subirono
in particolare una sconfitta a Sentinum, non interagendo bene con gli Umbri. E’
anche vero che i Romani separarono geograficamente le varie tribù sannitiche tra
loro e queste, a loro volta, dagli Etruschi, mantenendo neutrale la striscia di
territorio dei Peligni (Sulmona-Chieti). Nel nel 283 a.C. assoldarono (dapprima
venendo depredati) i Galli per combattere contro Roma vicino Bassano in
Teverina, sul lago Vadimone, ma furono sconfitti, tanto che le acque del Tevere
si tinsero di rosso. In tale occasione furono cacciati dall’Italia i Galli
Senoni (che subirono un genocidio nei pressi di Rimini), con la fondazione di
Sena Gallica (Senigallia) ed i Boi. Si ribellarono ai Roamni ad Arezzo, ma
furono annientati. Sperarono inutilmente in Pirro, che dopo aver vinto ad
Eraclea (Basilicata) nel 282 a.C., perse a Maleventum. Sostennero Annibale
vanamente nel 210 a.C., subendo ritorsioni e processi sommari dai Romani.
Eseguirono azioni di sabotaggio, di frode e di pirateria contro Roma.
I
Romani fondarono colonie di controllo in Etruria: Rusellae, Castrum Novum (Porto
Clementino), Alsium, Fregene, Saturnia e Graviscae. Nel 225 a.C. i Galli
devastano di nuovo l’Etruria e sono sconfitti dai Romani a Talamone, la Maremma
non si riprenderà più dalla devastazione: il grande sistema idrico di bonifica è
stato distrutto e si lascia il posto a paludi e zanzare. Si racconta che
Ansedonia, Graviscae, Rusellae erano città inospitali, con aria insalubre.
L’Etruria pagò a caro prezzo le azioni di guerriglia e di favoreggiamento dei
vari condottieri, scesi in Italia per combattere i Romani: confische di beni,
tribunali, persecuzioni, liste di proscrizione. Fino al 100 a.C. i Tirreni
godevano ancora di un’agiata economia e di una certa ricchezza, segno di una
continua attività commerciale, seppure sempre più debole. Osserviamo che in
questa fase il destino dei Tirreni è molto simile a quello dei Sanniti, entrambi
in lotta contro Roma. Il latifondismo riduce alla fame il Sannio e l’Etruria: il
prezzo del grano si è ridotto, visto che tanti oramai sono i paesi dell’impero
che lo producono. Con l’avvento di Caio e Tiberio Gracco viene proposta la
riforma agraria e si fonda un partito d’ispirazione popolare, per porre un freno
a questa piaga della società. A seguito della loro uccisione nel 130 a.C.
l’Italia conosce il flagello della guerra sociale. Il console Lucio Giulio
Cesare, per evitare la guerra, propone la lex julia: abroga il latifondo e
concede la cittadinanza romana, anche se non con diritto di voto, ai popoli si
schierano per la pace. Gli Etruschi si accontentano ed evitano di scendere in
combattimento al fianco dei Sanniti, che assieme ai Piceni e Marsi avevano
fondato una capitale a Corfinium, in Abruzzo. Tale evento è ricordato a Perugia
nell’Ipogeo dei Volumni.
Cessata la guerra tale legge fu respinta dal Senato
e scoppiò la guerra civile che vide come protagonisti Mario, popolare,
vittorioso sulle tribù celtiche dei Cimbri e Teutoni, e Silla, uomo degli
ottimati (patrizi), abile e astuto stratega. Nonostante il popolo si fosse
schierato per il primo, Silla, dopo aver massacrato i Sanniti, marciò su Roma e
prese il potere. Pompeo intanto sconfisse truppe tirrene in Val di Chiana e ad
Arezzo (88 a.C.). Mario, assieme a Cinna, altro popolare, approfittando della
guerra che Silla aveva mosso a Mitridate in Grecia, riprende il potere. E’ un
buon periodo per tutti i popoli italici. Mario e Cinna muoiono tra l’86 e l’84
a.C.. Silla ritorna e nell’82 a.C. sconfigge i popolari a Prenestae, dove
avviene una strage di Sanniti, e poi a Porta Collina (Monte Antenne-Roma) con un
altro famoso massacro. Silla si dirige in Etruria, dove subisce l’unica
sconfitta a Saturnia, ma poi si vendica a Chiusi con l’aiuto di Pompeo. Fino al
79 a.C., anno della caduta di Volterra, ci sono state rappresaglie, liste di
proscrizione, con premi per chi uccideva i proscritti, inibizione dalle cariche
pubbliche, confische di beni, riduzione dei territori ad Arezzo, Fiesole e
Chiusi. L’Etruria era alla fame. Solo più tardi, Cicerone riuscì a far ridare
terre a Volterra ed Arezzo.
Nel 62 a.C. alcuni abitanti di Fiesole e Arezzo
si unirono vanamente a Catilina e furono sconfitti a Pistoia. Come si vede,
l’Etruria, è stata sempre sede di sommosse. Il periodo di Cesare (49-44 a.C.) è
ottimo per i Tirreni: c’è rispetto, pace e riprendono le attività commerciali.
Del resto Arezzo si mostrò simpatizzante il generale, accogliendo le coorti
spedite in avanscoperta prima di passare il Rubicone. Con la morte di Cesare
finisce il nono secolo etrusco. Con l’avvento di Augusto si assiste alla
distruzione di Perugia del 40 a.C. per aver appoggiato il fratello di Marco
Antonio, sconfitto ad Azio da Agrippa nel 31 a.C., con la deportazione di 300
perugini, trucidati nel Foro Romano. Mecenate consigliò l’imperatore di
ricostruire Perugia, che si chiamò Augusta Perusia. Comincia per l’Etruria uno
sviluppo nel turismo, di moda già all’epoca. Famose erano le fonti termali
Fontes Clusini presso Chianciano e Aquae Populoniae presso
Populonia.
Nacquero le provincie, le colonie, le regioni romane ed i processi
di latinizzazione presero sempre più piede. L’ultimo imperatore amico dei
tirreni fu Claudio, loro grande studioso, morto nel 54 a.C., che compose i "
Tyrrhenica ", studi di etruscologia, mai trovati. Dunque gli Etruschi
insegnarono moltissimo ai loro discepoli romani, che li distrussero e
perseguirono una politica di propaganda e di denigrazione nei loro confronti:
tecnica adottata nei confronti di tutti i popoli vinti, in particolare dei
tirreni che erano stati i fondatori dell’urbe.
I
Personaggi
Riportiamo brevemente la storia di alcuni personaggi
caratteristici della storia etrusca. Come già ricordato nel capitolo precedente,
è importante tenere presente che le notizie storiche pervenuteci sono state
filtrate dal mondo culturale filo romano (tranne nel caso della vicenda del
mitico Mastarna e dei Vibenna), per cui è lecito supporre che per alcuni tratti
le vicende riportate si siano arricchite di leggenda, al fine di esaltare la
cultura romana che aveva sconfitto quella etrusca.
Cicerone Marco
Tullio
Fabia (gens)
Furio Camillo Marco
Mastarna ed i
Vibenna
Mecenate Caio Cilno
Ocresia
Porsenna
Ravnthu
Servio
Tullio
Spurinna (gens)
Tanaquilla
Tarquinio Lucio Prisco
Tarquinio
Lucio il Superbo
Tullia
Velia
Virgilio Publius Maro
Vulca
MARCO
TULLIO CICERONE
Marco Tullio Cicerone nacque nel 106 a.C. in
territorio di Arpino, da famiglia equestre nella villa paterna alla confluenza
del Liri col Fibreno e sempre si considerò un puro Arpinate, quasi continuatore
del grande conterraneo Mario. Nell'orazione Pro Plancio esprime vivo
l'attaccamento viscerale alla sua terra di origine quando ricorda quale affetto
leghi gli Arpinati fra di loro e con quale partecipazione questi seguano le sue
vicende politiche. Lì, sui monti dei Volsci, aggiunge, è la forza d'Italia,
perché ha conservato gli antichi costumi, senza malevolenze, senza finzioni e
conclude: "La nostra patria è rozza e montuosa ma semplice e fedele".
E nel
momento del suo esilio indica alla moglie Terenzia, quale rifugio sicuro, la
villa di Arpino e al suo unico figlio egli darà la toga virile non in Roma, ma
nel foro dell'antica città volsca. Cicerone ben presto fu inviato a Roma dove
studiò Retorica e Diritto, ma anche Filosofia e Lettere e completò la sua
preparazione ad Atene e a Rodi. Il suo cursus honorum iniziò nel 76 a.C. con una
rapida e inarrestabile ascesa: fu questore nella Sicilia orientale, poi edile
curule, pretore nel 66 a.C. e console nel 63. La sua oratoria robusta ed
euritmica gli aveva aperto la strada alle affermazioni politiche. Nel periodo
turbolento che viveva la Repubblica dei suoi tempi, Cicerone fu personaggio
controverso: ora acclamato pater patriae dopo aver sventato la congiura di
Catilina, ora esiliato per la vendetta di Clodio. In bilico fra il vecchio ed il
nuovo fu incerto nello schierarsi, ma se la sua fede politica sembra mutare,
sempre costante fu la sua fedeltà ai valori morali e alla Repubblica.
Nella
lotta fra Cesare e Pompeo si schiera con Pompeo, ma dopo Farsalo si riavvicina a
Cesare. Le Idi di Marzo lo trovano dalla parte dei tirranicidi e con le
Filippiche si scaglia contro Antonio.
Quando questi si accorda con Ottavio,
Cicerone capisce che la sua ora è suonata. E allora tutto, indecisione,
incertezza, opportunismo, fu riscattato dalla sua morte affrontata
consapevolmente, anzi cercata, e alte suonano le parole della seconda Filippica:
"Ed ora per me, o Senatori, la morte rappresenta un desiderio ... Una sola cosa
desidero: di lasciare libero morendo il popolo romano. Niente di più bello può
essermi concesso dagli dei immortali". Infatti raggiunto a Formia dai sicari di
Antonio, gli fu troncata la testa che egli aveva sporto dalla lettiga.
Era il
7 dicembre del 43 a.C. Le Verrine, le Catilinarie, le Filippiche furono i
momenti più alti della sua oratoria; il De legibus, il De Officiis, il De
Republica, le Tuscolanae sono l'espressione del Cicerone pensatore, studioso,
interprete dell'anima latina. Le Epistolae, infine, sono il documento che ci
rivela l'umanità, l'inquietudine, i dubbi e le angosce dell'uomo
Cicerone.
FABIA (Gens)
La gens Fabia possedeva dei territori nella zona a
ridosso di Veio e presto la lotta per il predominio territoriale divenne
inevitabile. Nel 478 a.C. la famiglia dei Fabii, aveva chiesto e ottenuto
l'autorizzazione al Senato, per combattere una sorta di guerra privata contro
la la rivale etrusca. 306 membri della prestigiosa famiglia romana,
accompagnati da una guarnigione di 4000 uomini, probabilmente loro clienti, si
accamparono a poca distanza da Veio, sulle rive del fiume Cremeria, un piccolo
affluente del Tevere.
Da lì conducevano una guerra fatta di piccoli scontri,
incursioni e razzie di bestiame. Il 13 febbraio del 477 a.C., caddero in
un'imboscata preparata dai veienti: 305 componenti della famiglia dei Fabii,
caddero sotto i colpi dei nemici. Solo un giovane si salvò e garantì in questo
modo la discendenza dalla famiglia che rimase comunque una delle gens più
importanti dell'antica Roma.
FURIO CAMILLO Marco
Generale e uomo
politico romano (fine del V sec. a.C.- 365 a.C.). Censore nel 403, sei volte
tribuno militare con potestà consolare tra gli anni 401 e 381, dittatore nel 396
a.C., si segnalò nella guerra contro gli Etruschi, conquistando Veio già
assediata da dieci anni e raddoppiando il dominio territoriale di Roma. Tre anni
dopo aver concluso la pace con i Falisci, in seguito a una condanna, andò in
esilio ad Ardea (391).
Secondo una tradizione poco verosimile, sarebbe
tornato nel 390, dopo la presa di Roma da parte dei Galli, interrompendo le
trattative di riscatto con la famosa frase « Non con l'oro ma con il ferro si
salva la patria » e avrebbe ricacciato gli invasori. Attese, quindi, alla
ricostruzione di Roma e diresse, nel 389 a.C., le guerre contro gli Equi, gli
Ernici e i Volsci; inoltre aumentò l'effettivo dell'esercito romano,
introducendo lo stipendio per i nullatenenti, e circondò il Campidoglio di
potenti fortificazioni. Grande personalità ebbe il soprannome di Secondo
Fondatore di Roma e la leggenda ne abbellì la figura e le gesta.
MASTARNA ed
i VIBENNA
Riflessi sulla storia di Roma
Quello di cui ci
accingiamo ora a parlare è un capitolo della storia di Roma che manca
completamente nei racconti degli storici di età tardo-repubblicana e imperiale,
cioè nella storiografia ufficiale romana, pur trattandosi di un capitolo
d'importanza non trascurabile, come vedremo. È questo un esempio tra i più
evidenti della distanza che intercorre tra le memorie dei tempi protostorici c
arcaici e la grande stagione della letteratura latina. Dei fatti in questione
abbiamo tuttavia qualche sentore più che dalle opere di storia dagli scritti di
erudizione: frammenti di notizie sparse e perfinodiscordanti, fra le quali
tuttavia non mancano spunti di autorevole credibilità e alle quali documenti
archeologico-epigrafici originali offrono un appoggio determinante. Nella sua
forma più semplice il racconto si riferiva ad un nobile condottiero etrusco
chiamato Caele o Caelius Vibenna venuto a Roma ai tempi di Romolo per dargli
aiuto contro i Sabini, ovvero al tempo del re Tarquinio (s'intende Prisco), e
che in ogni caso avrebbe dato il suo nome al Monte Celio da lui occupato e
abitato. La prima variante cronologica è riportata essenzialmente da Vatrone (de
lingua Lat. V, 46), accolta per cosl dire incidentalmente da Dionisio di
Alicarnasso là dove si parla di Romolo, e altrimenti piuttosto nota e diffusa.
Ma questa versione faceva genericamente riferimento agli Etruschi o ai Lucumoni
o a personaggio denominato Lucumone (Cicerone in de Republica II, 8,14). L'altra
versione che abbassa l'avventura di Vibenna all'età dei Tarquinii cioè al VI
secolo ha dalla parte l'autorità di Tacito, Annali IV, 65,1-2 e soprattutto
l’importantissimo anche se estremamente mutilato frammento di Festo sotto Tuscum
Vicum, 486,12-19, in cui si parla di Cele e di un fratello Vibenna originari di
Vulci (se l’aggettivo etnico che li definisce va reintegrato Volcientes come è
pressochè certo sulla base di altre fonti), e con loro di un Maxtarna (del cui
nome sono conservate solo le prime tre lettere, ma la cui completa restituzione
non dovrebbe dar luogo a dubbi).
C'è poi una.testimonianza il cui valore
supera quello di ogni altro argomento, e cioè l'annotazione contenuta in un
discorso al senato dell'imperatore Claudio (riportato nelle tavole di bronzo di
Lione), nel quale si affèrrria che secondo autori etruschi Servio Tullio era
stato in origine un personaggio chiamato Mastarna, fedelissimo sodalis e
compagno di ogni avventura del duce Caelius Vivenna, del cui esercito variamente
provato dagli eventi ed uscito dall'Etruria egli avrebbe condotto i resti ad
occupare il Monte Celio; cambiato nome avrebbe poi ottenuto il regno di Roma con
grande vantaggio per lo stato. L'autorità di questa fonte, rispetto ad ogni
altra attestazione letteraria, è garantita dalla certezza del testo, dalla
ufficialità della sede e dalla solennità dell'occasione in cui fu pronunciata
l'orazione claudiana, tali da escludere ogni irresponsabile fantasia, infine
ovviamente dalla pedantesca competenza dell'imperatore etruscologo.
Tutti
questi dati della tradizione sono confermati, collegati e per così dire
illustrati da quel singolare documento che è il fregio dipinto della Tomba
Francois di Vulci, databile intorno agli ultimi decenni del IV secolo a.C., che
è quanto dire poco più di due secoli dopo gli avvenimenti presumibilnente
descritti. Le figure sono accompagnate dalle didascalie con i nomi relativi. Il
fregio si sviluppa su tre tratti di parete; vi è rappresentato un combattimento
con cinque coppie di personaggi, in gran parte in nudità o seminudità (eroica?):
partendo da sinistra (vicino alla porta della cella iella tomba), Caile Vipinas
{Celio Vibenna) liberato da Macstrna (Mastarna) che gli taglia i ceppi alle mani
con la spada ed ha pronta per lui un'altra spada; seguono Larfs UIfes (Larth
Ulthes), indossante una tunica, che trafigge Laris Papasfnas Velznax, cioè Laris
Papathnas di Volsinii; Rasce in atto di colpire Pesna Arcmsnas Sveamax, cioè
Pesna Arcmsna di una città chiamata *Sveama, forse Sovana, avvolto in un nanto
listato che gli copre il capo; Avle Vipinas, cioè Aulo libenna, che afferra la
chioma e infila la spada sotto il braccio di un nemico di apparente chioma
bionda, designato da ma scritta mal conservata come Vensficau... plsaxs (nome
inidentificabile: si è pensato anche ad un etnico Venthi per Veletus, e città
d'origine anch'essa non riconoscibile); infine Marce Camitlnas che ha atterrato
o sorpreso a terra e tiene per i capelli Cneve T arxunies RumaX, cioè Gneo
Tarquinio di Roma che abbiamo già menzionato, il quale tenta di fermare con la
destra la spada che sta per inferirgli il colpo fatale. Analizziamo la scena
cominciando dai personaggi.
L'ultimo duello è per noi il più
significativo perchè ci garantisce l'ancoraggio cronologico dell'intera storia
con l'età dei Tarquinii, oltre che il suo diretto rapporto con Roma, offrendo
così il più puntuale riscontrò con le fonti di Claudio e di Tacito. Un altro
dato importante è l'apparizione di Aulo Vibenna, il fratello di Celio che dalle
fonti letterarie citate non era contemplato se non nel tormentato passo di Festo
dove peraltro non è leggibile il prenome. Ma la coppia dei due fratelli torna a
presentarsi comunque chiaramente appaiata, con le relative didascalie (Caile
Vipinas e Avle Vipinas), in procinto di aggredire un giovane cantore vaticinante
di nome Cacu (ma quanto diverso dal Caco feroce brigante della leggenda
romana!), nella figurazione di uno specchio del Museo Britannico proveniente da
Bolsena; lo stesso tema si riscontra in rilievi di urne cinerarie di Chiusi ma
senza i nomi. È evidente da queste figurazioni che i due personaggi sono
considerati eroi ed entrati nel mito.
Considerando ora tutto il complesso del
fregio vulcente distinguiamo chiaramente le due parti in conflitto. Sei figure
costituiscono il gruppo vincente: oltre Macstrna che libera Caile Vipinas,
quattro combattenti che colpiscono i nemici con la spada, di cui soltanto uno
tunicato (Larth Ulthes), gli altri nudi (Rasce, Avle Vipinas, Marce Camitlnas).
Va sottolineato che la maggior parte di questi personaggi è designata con la
formula onomastica bimembre, prenome e gentilizio, rivelando con ciò la sua
appartenenza alla classe dotata di diritti civili, cioè i due Vibenna, Larth
Ulthes (l'unico che sia parzialmente vestito) e Marce Camitlnas; mentre Macstrna
e Rasce hanno un unico nome individuale e dovrebbero quindi ritenersi di
condizione servile o comunque inferiore, secondo quanto sappiamo del sistema
onomastico etrusco. I loro quattro avversari soccombenti sono tutti
caratterizzati da prenome e gentilizio, cui si aggiunge un terzo elemento in
posizione di cognomen (ma non con le caratteristiche morfologiche di un
cognomen, e perciò piuttosto un derivato con valore di « etnico ») indicante la
città di provenienza o di appartenenza: Volsinii per Laris Papathnas, *Sveama-
per Pesna Arcmsna, nome non leggibile per Venthicau..., Roma per Cneve
Tarchunies. L'intenzionalità della precisazione etnica per i quattro sconfitti è
evidente: si direbbe che la si sia voluta contrapporre ad aggressori «senza
patria». La presenza tra loro di un Tarquinio di Roma fa ragionevolmente pensare
che per tutti si tratti di personaggi di alto rango, se non addirittura di capi
o re delle rispettive città.
Dalle persone si può passare ora alla natura
dell'azione. Tutta una serie di indizi prova chiarissimamente che qui non si è
inteso offrire un quadro generico di battaglia, ma si è voluto rappresentare un
episodio storico molto particolare e ben definito. Tale episodio presuppone che
Caile Vipinas, capo di una certa consorteria (come mostra il risalto datogli dal
fregio), sia stato preso prigioniero da uno schieramento avversario. I suoi
compagni ne hanno predisposto la liberazione con un'azione che coglie di
sorpresa, forse nel sonno, i catturatori. La scena appare ritratta con una
simultaneità di movimenti quasi come una «istantanea». Ogni assalitore colpisce
un avversario con la spada snudata; ad uno degli assaliti scivola il manto dal
capo; un altro lascia cadere lo scudo che non ha fatto in tempo ad abbracciare;
un altro ancora è a terra, non ancora levato o caduto. Per quel che riguarda il
primo gruppo, che naturalmente è il principale, mentre intorno la lotta infuria
vediamo il liberatore Mastarna tagliare i legami del prigioniero e portargli la
spada destinata a farlo entrare nel combattimento.
Che cosa significa tutto
questo? Si tratta senza dubbio di un fatto importante, presumibilmente decisivo;
di vicende concernenti le avventure dei Vibenna e dei loro seguaci, contrastate
da avversari potenti. Di una prigionia e conseguente liberazione di Cele Vibenna
la tradizione letteraria non parla, almeno per quanto essa è giunta tanto
lacunosamente fino a noi. Che questo evento e in generale la storia dei Vibenna
siano presenti tra i soggetti pittorici della grande Tomba Francois di Vulci,
unico tema «storico» locale tra i molti ispirati dalla mitologia greca (a parte
il «ritratto» in apparente costume trionfale di Vel Saties, titolare e membro
della famiglia proprietaria della tomba, di cui non è qui il caso di discutere),
si spiega con l'intento di glorificare antichi personaggi, se non già
addirittura eroi, della città come i Vibenna e in pari tempo alludere alla loro
vittoria sul romano Tarquinio, in un momento (fine del IV secolo) in cui Vulci
doveva essere gravemente minacciata dai Romani già penetrati a fondo in
Etruria.
S'intende che anche proprio per questo l'episodio rappresentato
dalla liberazione di Caile Vipinas deve intendersi come vittoria, e vittoria
clamorosa, della sua parte contro la parte avversa. Resterebbe forse da spiegare
perchè questa parte avversa veda schierarsi simultaneamente e parallelamente
quattro «rappresentanti» eminenti di quattro città che, con la loro uccisione,
debbono intendersi vinte. Qui sospettiamo che il realismo della scena episodica
abbia ceduto almeno parzialmente il campo ad un certo simbolismo figurativo, per
cui si sia voluta considerare presente e soccombente l'intera coalizione nemica
attraverso i suoi capi, eventualmente anche fondendo in uno altri fatti, con
quella visione contemporanea di momenti diversi che sarà poi caratteristica
della pittura e del rilievo trionfali romani. Chiaro sembra anche il proposito
di contrapporre alla pari ed elevata dignità dei vinti la mancanza di
qualificazione etnica e l'eterogeneità sociale dei vincitori (partecipazione dei
due individui senza gentilizio: Mastarna e Rasce).
Un ultimo gruppo di
testimonianze, interessante proprio Roma in maniera più diretta, va preso in
esame a proposito di Aulo Vibenna, il fratello del «capo». Meno illustre e meno
ricordato per quel che riguarda l'avventura primaria, egli sembra apparirci
protagonista di vicende conseguenti incentrate a quanto sembra attorno a Roma.
Il documento fondamentale, tanto ricco di dati interessanti quanto poco chiaro,
è un lungo passo dello scrittore cristiano Arnobio (Adversus gentes VI, 7) in
cui si fa riferimento a diverse fonti annalistiche risalendo in ultima analisi
fino a Fabio Pittore. In forma retorica e alquanto complicata si allude ad
eventi della vita di Olus (cioè Aulus) Vulcentanus e in particolare si accenna
al fatto che egli fu ucciso per mano di un servo, che non si vollero accogliere
le sue spoglie in patria, che fu sepolto sul Campidoglio e che il tempio
capitolino (con il colle) prese nome dal suo cranio ritrovato dopo qualche tempo
(caput Oli = Capitolium).
La leggenda della scoperta del cranio al momento
della fondazione del tempio di Giove ricorre in diversi autori romani; in
particolare l'etimologia caput Oli è ricordata da Servio nel commento all'Eneide
(VIII, 345) e dalla fonte del Cronografo di Vienna (anno 354 d.C.), che precisa
che sul cranio era scritto in lettere etrusche «caput Oli regis»; di una
iscrizione in lettere etrusche parlava anche Isidoro, Origines XV, 2,31. Da
notare che questo prodigioso rinvenimento, ritenuto augurale per la futura
grandezza di Roma anche da interpreti etruschi interpellati in proposito, è
riportato da Livio (I, 55) al regno di Tarquinio il Superbo, cioè in tempi
posteriori agli ipotetici eventi del «periodo serviano». Ma a fronte di queste
memorie favolose noi possediamo una testimonianza concreta di straordinario
valore, rappresentata con pressochè assoluta certezza da un documento originale
dello stesso Aulo Vibenna, cioè una iscrizione dedicatoria etrusca trovata nel
santuario di Portonaccio a Veio con il suo nome in forma arcaica Avile
Vipiiennas, incisa sopra un piede di vaso di bucchero databile tra il secondo
quarto e la metà del VI secolo. La presenza nello stesso deposito di oggetti
offerti da personaggi di alto rango come i Tulumne che poi regneranno a Veio ci
autorizza a credere che qui si tratti veramente di quell'Aulo Vibenna di cui era
rimasta a Roma una cosl cospicua memoria. Ma c' è pi più. In una coppa etrusca
di imitazione greca dipinta a figure rosse della metà circa del V secolo
proveniente molto probabilmente da Vulci, attualmente conservata a Parigi nel
Museo Rodin, c'è una dedica Avles Vi(i)pinas la quale fa pensare che questo
personaggio fosse stato ben presto addirittura eroizzato (personalmente e
singolarmente, cioè in un quadro diverso dalla tradizione dei racconti mitici da
cui derivano le citate figurazioni dei due fratelli nello specchio di Bolsena e
nelle urne chiusine).
Da tutto l'insieme di dati sin qui raccolti, anche se
scarni e di tanto diversa natura, non è tuttavia impossibile cercare
un’interpretazione storica. E’ cosa certa che nella prima metà del VI secolo un
grosso sconvolgemento ha turbato l’Etruria meridionale e Roma (riguardo
all’Etruria questa vicenda appare tanto più importante se si considera quanto
poco sappiamo della storia politica etrusca in generale). Si tratta di un'azione
militare guidata da un condottiero originario di Vulci, Caile Vipinas, e dai
suoi seguaci, presumibilmente a scopo di rapina e di conquista, senza peraltro
escludere altre eventuali ragioni di carattere ideologico o sociale che ci
sfuggono. L 'impresa come già sappiamo è un esempio tipico dell'avventurosità
delle aristocrazie arcaiche (i Vibenna erano di stirpe nobile come risulta da
Varrone e, presumibilmente, dalle fonti di Arnobio) e sembra avere, almeno
inizialmente, il carattere di un'iniziativa privata o se si preferisce
«gentilizia»: non certo espressione della politica di una città, nella
fattispecie Vulci, anche se più tardi Vulci la esaltò come una sua gloria nelle
pitture della Tomba Francois (che probabilmente sono copie della decorazione di
un edificio pubblico).
Tuttavia non si può del tutto escludere che nel
movimento suscitato dai Vibenna possa essersi inserito qualche elemento di
tendenza riformistica e antioligarchica, forse maturata proprio a Vulci città
apertissima alle influenze della Grecia e quindi anche possibilmente alle sue
innovazioni socio-politiche. Ciò porterebbe ad un contrasto con gli ambienti più
conservatori soprattutto dell'Etruria interna; e sarebbe una spiegazione,
peraltro del tutto ipotetica, di quell'estendersi della sfera d'azione della
potenza armata dei Vibenna fino ad investire e minacciare grandi città come
Volsinii e Roma. Bene inteso non sarà da pensare a cambiamenti politici ingenti
e durevoli, se non forse per Roma, come vedremo. La presentazione dei
rappresentanti vinti ed uccisi delle quattro città nel fregio della tomba
Francois è verosimilmente un'amplificazione di singoli e più modesti avvenimenti
reali. Le forze degli aggressori saranno passate come un uragano attraverso
l'Etruria meridionale interna e la valle del Tevere, con vicende alterne, come
provano da un lato la «varia fortuna» del testo di Claudio, da un altro lato gli
episodi della cattura e della liberazione dello stesso capo della spedizione
Caile Vipinas testimoniate dalle pitture vulcenti. La quasi totalità di questi
avvenimenti deve essersi svolta in Etruria. A Roma, stando alla versione
claudiana, sarebbero giunti solo i resti dell'esercito sotto la guida di
Mastarna, ciò che implicherebbe l'uscita di scena di Caile.
Che cosa
accadde poi? Per rispondere a questa domanda conviene. considerare più da vicino
le persone degli attori del dramma. Si è già detto dei Vipina (forma originaria
arcaica Vip(i)ien(n)a, forma latina Vibenna con la variante Vivenna della
registrazione epigrafica del discorso di Claudio); si può aggiungere che questo
nome gentilizio apparirà diffuso in tutta l'Etruria per l'intero corso della
storia etrusca, con particolare riguardo all'area vulcente, centro-etrusca e
chiusina: deriva da una forma semplice «prenominale» Vipi (latino Vibius) comune
anche all'onomastica delle lingue italiche e più frequente nell'Etruria
meridionale (ricordiamo tra l'altro il Vel Vibe veiente del frammento di Nevio).
La compagnia di Caile Vipinas nella Tomba Francois appare, ripetiamo,
socialmente mista: la presenza di parenti (Aulo), amici di pari rango (Larth
Ulthes, Marce Camitlnas) e coadiutori di rango inferiore (Macstrna, Rasce)
ricorda molto da vicino la composizione delle consorterie che accompagnavano la
migrazione del futuro Tarquinio Prisco o sdstenevano Servio Tullio aspirante al
regno nel racconto degli storici. Larth Ulthes ha un raro gentilizio attestato
in tempi più recenti anche con forme affini in area centro-etrusca.
Quanto al
nome Camitlnas, in verità isolato, l'ovvia assonanza con Camillus può essere
fuorviante; anche se non sarà da rigettare a priori; il richiamo più pertinente
potrebbe essere con il tipo Camcdius e derivati, di area laziale, campana,
umbro-sannitica: dunque forse un commilitone «meridionale» (al quale sarebbe
toccato il gesto più pregnante, quello di colpire Tarquinio). Restano i due
«senza nome»: Mastarna e Rasce, per il quale ultimo si può pensare ad un
semplice ausiliare designato genericamente dalla sua nazionalità (Ras-ce con
formazione equivalente a Rasna, Rascnna, cioè « l'etrusco» o « un etrusco
»?).
Mastarna esige un più particolare esame perchè il suo nome e la sua
personalità costituiscono il problema centrale di ogni possibile tentativo di
interpretazione storica di questi fatti per quanto essi riguardano Roma. Che la
forma onomastica etrusca Macstrna (latinizzata in Max(tarna), Mastarna) contenga
la parola latina magister è una vecchia certezza che non può dar luogo a dubbi.
La questione è invece quella del suffisso -na che in etrusco è un sicurissimo
indicatore di appartenenza. La forma macstr-na non può quindi equivalere
semplicemente a macstr- cioè magister; ma deve piuttosto significare qualcosa
come «relativo al magister», «appartenente a magister». Cadrebbero di
conseguenza tutte le ipotesi formulate in precedenza, anche dall'autore di
questo libro, circa una funziont di potere esercitata dal personaggio Mastarna
in Roma con il titolo di magister, sia come comandante militare luogotenente di
Tarquinio Prisco, sia come magister populi più o meno di estrazione popolare, o
simili. Il magister al quale si riferisce il nome di Mastarna non sembra possa
essere altro che Cele Vibenna, quel capo di cui Mastarna era stato sodalis
fidelissimus secondo la tradizione claudiana. Proprio questa sodalitas si
esprime nella forma che indica grammaticalmente il concetto di appartenenza, e
può spiegare in pari tempo la condizione di inferiorità sociale di Mastarna,
privo di un nome gentilizio e contraddistinto solo da una qualifica funzionale,
e l'intimo legame di personale devozione al suo comandante di cui è
testimonianza, oltre al fidelissimus claudiano, la scena della liberazione nel
fregio di Vulci. Si può e si deve immaginare uno speciale rapporto di fiducia e
di amicizia di Cele verso il suo «scudiero», tale da porre quest'ultimo in una
posizione di privilegio, di cui si vedranno forse nel futuro le
conseguenze.
Quanto al fatto che il capo etrusco della grande spedizione
possa essere stato ricordato con il titolo latino di magister senza dubbio esso
costituisce per noi un motivo di perplessità: non però gravissimo se si pensa
che il termine latino appare, sia pure in tempi assai più recenti, nella
titolatura dei magistrati etruschi (macstrev in un sarcofago di Tuscania, Corpus
lnscriptionum Etruscarum 5683), ma ancor più supponendo antiche profonde
interferenze fra mondo etrusco e mondo latino in particolari settori del
linguaggio tecnico-istituzionale, o la possibilità di usare un termine straniero
alla moda, o qualche altra cosa di simile. L'estremo punto d'arrivo dello
sconvolgente movimento dei Vibenna calato per la valle tiberina - via che
diverrà tradizionale per ogni invasione dal nord - è, come si diceva, Roma; ed a
Roma si svolgeranno gli ultimi atti di questa vicenda storica, per quanto
sappiamo. Non si può dire se la versione data dalle fonti di Claudio circa la
presenza a Roma solo dei resti della spedizione senza più il suo capo sia
integralmente accettabile sul piano storico. Nella testimonianza figurata del
fregio vulcente il rappresentante di Roma Cneve Tarchunies cade vinto in
presenza di Calle Vipinas, il quale dunque è da considerarsi responsabile della
sconfitta di Roma simboleggiata in questa scena e potrebbe aver colto il frutto
della sua vittoria occupando in tutto o in parte la città nemica. Ne si può
escludere la eventualità che realmente al suo nome si ricolleghi quello del
Caelius mons come voleva unanimemente la tradizione antica, anche se è più
sensato credere con gli storici moderni che si tratti di una falsa etimologia.
Comunque l'idea che il capo della spedizione sia personalmente arrivato fino a
Roma nel corso delle sue azioni militari non è da scartare. Ciò che conta è
quanto accade dopo la sua scomparsa (dovuta alla morte o a una qualsiasi altra
ragione) ed è adombrato nel racconto claudiano, cioè il fatto che una parte
residua del suo esercito sarebbe rimasta affidata a Mastarna il quale l'avrebbe
impiegata per installarsi definitivamente in Roma.
A questo punto il
discorso si fa più complesso ed ipotetico. Tutte le notizie che abbiamo raccolto
su Aulo Vibenna indipendentemente dagli scenari nei quali egli appare in coppia
con il fratello inducono a pensare che egli abbia avuto una propria storia
probabilmente da collocare in una fase posteriore alla scomparsa di Cele. E’
facile immaginare che questa scomparsa abbia creato problemi di successione e
che, la stretta parentela e la comunanza delle imprese abbiano naturalmente
portato Auto ad assumere l'eredità del fratello nel comando della spedizione e
dell'esercito. E’ sospettabile che a questa designazione abbia concorso
soprattutto la parte «aristocratica» della consorteria, quelli che le fonti
storiografiche designano in casi analoghi, come «parenti» ed «amici» del capo.
Ma l'esercito di Cele Vibenna comprendeva anche i sodales, le clientele e in
genere gli ausiliari, come si indovina in qualche maniera nella stessa scena
pittorica della Tomba Francois. Soprattutto esisteva il fatto certissimo
(concordemente provato dalla testimonianza claudiana e dalle pitture vulcenti)
del rapporto molto stretto di fedeltà e di fiducia tra Cele Vibenna e Mastarna,
che può aver procurato a quest'ultimo un potere illimitato evidentemente
prolungatosi oltre la morte del capo.
Una fondamentale rivalità ed un finale
scontro fra Auto Vibenna e Mastarna sono da immaginare logicamente e oseremmo
dire con certezza. In Roma conquistata (per merito di Mastarna) Aulo avrà avuto
inizialmente la supremazia, per i suoi diritti familiari di successione al
fratello: ne abbiamo qualche indizio nelle fonti già citate a proposito del
caput Oli e tra queste il ricordo di una supposta iscrizione etrusca che lo
designava addirittura come re. Ma Mastarna, capo di fatto con l'appoggio
dell'esercito, avrà finito con il prevalere eliminando il rivale. Di questi
ipotetici avvenimenti non esistono testimonianze. Tuttavia un filo tenue di
prova potrebbe intravedersi nel citato confuso testo di Arnobio, dove, certo
sulla scorta di remote fonti annalistiche (forse dello stesso Fabio Pittore), si
accenna come a fatto notorio alle ragioni per cui Olus sarebbe stato ucciso da
un servo, «...cur manu servuli vita juerit spoliatus et lumine». Un sicario di
Mastarna? o Mastarna stesso designato dal primo relatore del fatto come «servo»
per le sue originarie condizioni d'inferiorità sociale?
L'occupazione di Roma
da parte degli invasori etruschi, i Vibenna, Mastarna, i loro compagni, le loro
truppe, è conseguenza e causa del crollo della monarchia dei Tarquinii. Non
abbiamo dati sufficienti per indicarne con precisione la cronologia (e con essa
naturalmente la fine del «periodo di Tarquinio Prisco» e l'inizio del «periodo
serviano»); tuttavia una proposta che la collocasse intorno al 570-560 non
sarebbe forse troppo lontana dal vero. La caduta di Cneve Tarchunies nella scena
di combattimento della Tomba Francois fa pensare logicamente a scontri cruenti e
alla soppressione violenta del potere della dinastia regnante, con una eventuale
sostituzione dei nuovi dominatori nel ruolo e nel titolo regio. Sarebbe questa
la spiegazione dell'« Olo (Aulo) re» della favolosa iscrizione del Campidoglio
(pur ricordata da fonte tardissima e incerta); si potrebbe cioè immaginare che
Aulo Vibenna sia senz' altro salito sul tropo degli spodestati Tarquinii (anche
se il suo nome, obliterato o cancellato, non apparirà nella lista canonica dei
re di Roma); e potrebbe essere che in questa posizione e in questo periodo Aulo
Vibenna offrisse un suo donario nel santuario di Veio. Ma si può pure pensare,
in modo diverso, che la sovranità dei Tarquinii non sia stata subito e del tutto
annullata e che, pur sotto la dominazione o la soverchiante presenza
degl'invasori, essi abbiano continuato a portare il titolo regio e a conservare
una loro sede in un settore della stessa città, con vicende alterne di
convivenza e di conflitti (di cui potrebbe darci qualche idea la stessa
tradizione a proposito dei rapporti fra i Tarquinii e Servio Tullio).
Ci
chiediamo se nell'insediarsi a Roma degli epigoni delle imprese di Cele Vibenna
possano essere emersi, ed aver acquistato rilievo, quei motivi di irrequietezza
sociale e di tendenza ad un riformismo in senso antioligarchico diffusi in
Etruria, di riflesso dal mondo greco, che abbiamo già sospettati presenti
all'inizio del movimento dei Vibenna. E’ possibile che proprio in queste fasi
finali della occupazione di Roma l'originario carattere «gentilizio» del
movimento stesso sia andato attenuandosi e gli elementi di estrazione subalterna
abbiano preso sempre maggiore risalto nella conduzione delle
milizie.
L'affermazione di Mastarna e la ipotetica ma verosimile eliminazione
di Aulo Vibenna possono essere considerate come le manifestazioni più
appariscenti di queste tendenze. Lo stimolo sovvertitore o almeno perturbante
proveniente dall'esterno può aver avuto importanti ripercussioni anche sugli
ambienti locali di Roma. Rivendicazioni e innovazioni possono aver trovato il
loro terreno più favorevole nelle zone di Roma più aperte ad influenze straniere
e alle sfere del commercio e del lavoro, in particolare come è naturale attorno
al porto tiberino (è un fatto interessante che proprio qui nel santuario di S.
Omobono si sia trovata tanta ceramica etrusco-corinzia di produzione vulcente:
un rapporto con la patria dei Vibenna?). La politica conservatrice restò
probabilmente legata alla tradizione dei Tarquinii e ai loro circoli.
Immagineremmo volentieri la loro roccaforte su quel monte capitolino sul quale
si avviava a sorgere il grande tempio di Giove (dedicato da Tarquinio Prisco,
compiuto dal Superbo secondo gli storici romani), massima espressione della
pietà, della magnificenza e della potenza della dinastia.
Resta ora da
affrontare il problema che ci si attenderebbe come conclusione a questo punto:
quello della identità di Mastarna e di Servio Tullio affermata dalle fonti
etrusche di Claudio. In realtà non possiamo sfuggire, ne sfuggì un certo settore
dell'erudizione antica, alla suggestione di coincidenze rilevantissime. Mastarna
è a Roma uno straniero privo di nome gentilizio e perciò appartenente ad una
classe inferiore; Servio Tullio è ricordato dalla tradizione come straniero e
apolide, cioè originariamente senza diritti di cittadinanza. Mastarna si impone
a Roma a seguito di eventi che implicano la sconfitta e presumibilmente
l'uccisione di un Tarquinio; Servio Tullio salirà al trono, o piuttosto si
impossesserà del regno dopo l'uccisione di Tarquinio Prisco. Si può aggiungere
che le riforme attribuite a Servio Tullio comprendono la creazione di un sistema
di rappresentanza (e pertanto una fonte di potere politico), cioè i comizi
centuriati, essenzialmente basato sopra una struttura militare: ciò che fa
pensare alla importanza che potrebbe aver avuto per la vita pubblica di Roma la
presenza di un esercito organizzato come quello di cui, dopo la scomparsa. di
Cele Vibenna, era diventato arbitro Mastarna.
Sembra dunque lecito
argomentare senza eccessivo sforzo di fantasia che Mastarna, rimasto ormai solo
a capo delle milizie stanziate in Roma dopo l'eclissi dei due Vibenna, abbia
inteso progressivamente stabilizzare il suo potere, assumendo un nome gentilizio
e cercando localmente una legittimità a quella dignità regia alla quale forse
con effimera esperienza si era accostato Aulo Vibenna. Ma in ultima analisi che
i fatti si siano svolti in un certo modo e che propriamente Servio Tullio sia la
stessa persona di Mastarna è non solo non dimostrabile con cettezza, ma forse
anche irrilevante per il nostro giudizio storico finale. Ciò che conta è che
esiste un possibile e logico legame di continuità fra ciò che rappresentano
nelle loro rispettive sfere le figure di Mastarna e di Servio
Tullio.
MECENATE Caio Cilno
Caio Cilno Mecenate, nato ad Arezzo nel
69 a.C. e discendente da una schiatta regale etrusca, divenne il personaggio più
famoso della corte augustea. La famiglia dei Cilni risaliva al IV secolo a.C.
Militare, nella prima parte della sua vita, e politico, Mecenate fu testimone
della trasformazione definitiva di Roma e del passaggio dalla Repubblica
all’Impero. Eletto "vicario" da Ottaviano per la grande fiducia che era riuscito
ad ispirare, seppe accontentarsi del titolo di "eques", proprio degli
appartenenti all'ordine equestre, classe sociale definita da Orazio "la più
eletta del popolo per squisitezza di gusto" (Sat. 1,10,76).
Ritiratosi dalla
vita politica, visse delle ricchezze familiari che gli provenivano da certe
fabbriche di vasi che fiorirono in Arezzo dal 30 a.C. in poi. Nella vita privata
si dedicò solo ai piaceri dello spirito scrivendo, conversando e "banchettando"
alla maniera etrusca. Seppe, con oculatezza rara, scegliersi gli amici. Nel suo
ruolo di "scopritore di talenti" Mecenate si era creato una cerchia di amici di
notevole sensibilità: Virgilio, Properzio, Gallo, Orazio, Marziale. Con intuito
e riservatezza tipicamente etruschi, tra questi ne preferì due che hanno dato
fama al suo nome: Virgilio e Orazio.
Virgilio, privato dei campi in riva al
Mincio dalle riforme di Augusto e con la speranza che gli sarebbero restituiti,
il Poeta arrivò a Roma. Asinio Pollione, governatore delle terre sul Mincio, lo
presentò a Mecenate. Virgilio già autore delle Bucoliche dove si esaltava la
vita pastorale, piacque all’"etrusco" che intercedette presso Augusto. Ma il
centurione Arrio, divenuto nel frattempo proprietario di quei campi, minacciò di
"accoppare" il Poeta. Mecenate allora, come risarcimento dell'esproprio subito,
assicurò a Virgilio un podere in Campania. Nel "fundus" napoletano, solitario e
lontano dal viavai cittadino, il Poeta poté astrarsi, meditare e riscoprire la
stessa pace dei campi mantovani. E nacquero le Georgiche che trattano della
bellezza dei campi.
Le umili origini di Orazio sono note a tutti. Figlio di
un liberto e nato in un piccolo centro sulla via Appia, Venusia o Venosa, vicino
a Potenza, in Basilicata. Per i sacrifici del padre, Orazio ebbe un'educazione
letteraria degna di un nobile. La povertà e la cattiva sorte lo perseguitarono a
tal punto che dovette accontentarsi di un modesto ufficio di scrivano quando
Virgilio lo presentò a Mecenate. Il lungimirante etrusco trovò essenziale, al
vivere, il buon senso e 1'avversione ad ogni gesto irrazionale del Poeta. In
seguito si stabilì tra i due uomini una stretta amicizia che proseguì fino alla
morte avvenuta per entrambi nello stesso anno: l' 8 d.C.. Mecenate aveva donato
al fedele amico una villa in Sabina. Qui Orazio si ritirava nei suoi ozi
meditativi spesso raggiunto dallo stesso Mecenate. Le Satire e le Odi, tra le
opere di Orazio, sono le più significative per il nostro argomento. Il ricco e
raffinato etrusco non disdegnava sedere alla parca mensa dell'amico a mangiare
olive e bere il vino modesto che la terra sabina - corrispondente, oggi, in
parte alla provincia di Rieti e in parte al territorio di Roma - offriva. Nel
descrivere la villa di Mecenate, Orazio ammirava le ghirlande composte di fronde
verdi, miste a frutta e fiori, che pendevano dalle pareti dei
triclinii.
OCRESIA
Ocresia era un’ancella che Tanaquilla aveva
scelto tra molte fanciulle tarquiniesi per portarla con sè a Roma. Oppure, come
dicono alcuni, una semplice serva; o, come affermano altri, una schiava condotta
come bottino di guerra nella reggia romana, dopo la morte in battaglia di suo
marito, il re di Cornicolum, dal quale aspettava un figlio. Comunque siano
andate le cose, Ocresia entrò presto nel potente cerchio magico e divinatorio
della regina Tanaquilla e diventò così un personaggio chiave nella tormentata
storia della monarchia etrusca nell’Urbe, perché fu madre del sesto re di Roma.
Sulla nascita e la giovinezza di questo re si raccontano fatti straordinari: “Un
giorno – apprendiamo da Plinio – apparve tra le fiamme di un focolare della
reggia di Tarquinio Prisco un membro virile e Ocresia che lì sedeva ne fu resa
incinta. Il figlio che nacque da questo concepimento magico si chiamò Servio
Tullio”. L’insolito evento era stato quasi dimenticato col passare del tempo,
“quando – è Livio che ora racconta – avvenne un altro fatto mirabile. Tutti
videro lunghissime fiamme ardere intorno alla testa di Tullio
giovinetto”.
Tanaquilla chiamò il re e, avendo accanto Ocresia, profetò: “Il
figlio di questa donna e del nume che per lui si manifesta con il fuoco, sarà
nei momenti oscuri il salvatore degli etruschi in Roma. E come ora splendono
queste fiamme che gli avvolgono il capo, così da lui verrà molta luce alla casa
dei Tarquinii”.
Il giovane, protetto dai vaticini, fu allevato con tale
regalità che Tarquinio Prisco, non conoscendo un romano che reggesse il suo
confronto, quando giunse l’ora gli dette in sposa sua figlia. I ritrovamenti
archeologici più recenti contrastano nettamente con queste leggende e dimostrano
in modo inequivocabile che in realtà Servio Tullio era Mastarna, l’eroe di Vulci
che si recò a Roma non per difendere i Tarquinii che riteneva arroganti e
tirannici, ma per combatterli a favore del popolo e riorganizzare gli
ordinamenti pubblici.
A lui si deve, infatti, la Costituzione Serviana che
eliminava i privilegi della nobiltà del sangue e assegnava per la prima volta i
diritti politici e la possibilità di entrare nelle milizie a tutti i cittadini,
anche romani. Ma per le leggende, dure a morire, il suo destino regale nacque,
si snodò e si compì nella reggia dei Tarquinii, manovrato dalla ferrea volontà
di Tanaquilla. Infatti quando Tarquinio Prisco venne ucciso in una congiura di
palazzo sulla quale tutto è lecito ipotizzare, fu lei a tenere nascosto per
molto tempo il cadavere del marito e a regnare in sua vece nel chiuso della
reggia. Solo quando tutte le fazioni si furono piegate ai suoi disegni e tutte
le opposizioni furono sedate nel sangue, Tanaquilla apparve solennemente al
popolo per comunicare che il vecchio re era appena morto. Poi annunciò con voce
ferma e autorevole che il nuovo re di Roma era Servio Tullio, figlio di Ocresia
e del Fuoco, considerato dagli stessi Dei un Tarquinio perché nato
prodigiosamente nella loro reggia.
PORSENNA
Lucumone della città
etrusca di Chiusi verso la fine del V sec. a.C. Secondo la tradizione romana,
sollecitato da Tarquinio il Superbo, cercò con le armi di ricondurlo a Roma,
donde era stato cacciato. Per la giovane repubblica romana non erano tempi
facili, la battaglia appena vinta contro i veienti non era che il preludio di
una grande guerra che avrebbe opposto la città dei sette colli ad una lega di
popoli etruschi costituita su sollecitazione di Tarquinio il Superbo e comandata
da un certo Lars Porsenna, lucomone della città di Chiusi. Ad incoraggiare gli
etruschi c’erano sicuramente la particolare situazione politica di Roma,
dilaniata dai conflitti sociali, e le forti tensioni esistenti tra la stessa e
le altre città del Lazio. L’avanzata degli Etruschi fu inesorabile e gli stessi
riuscirono a penetrare nel territorio romano fino ad occupare il Gianicolo,
sulla sponda destra del Tevere. Ma proprio quando erano pronti ad invadere
l’Urbe attraverso il ponte Sublicio, l’eroico comportamento di un comandante
romano, Publio Orazio detto il Coclite (perché cieco da un occhio), evitò la
disfatta; rimasto solo sulla sponda destra del Tevere riuscì ad impegnare le
sbigottite truppe etrusche, dando il tempo ai suoi soldati di abbattere il
ponte. I soldati etruschi erano realmente sorpresi dalla furia e dalle urla con
cui questo valente guerriero accompagnava i suoi fendenti. Lanciarono contro di
lui i loro giavellotti, che finirono inesorabilmente contro il suo
scudo.
Finalmente il ponte crollò alle sue spalle, Roma era momentaneamente
in salvo, ma il destino del Coclite sembrava segnato avendo lui perso la sua
unica via di fuga. Ma lui non si perse d’animo, si gettò nel Tevere con tutta
l’armatura e riuscì ad attraversarlo, rientrando in quella città a cui aveva
evitato, con il suo eroico gesto, un infausto destino. Roma gli dimostrò la sua
gratitudine dedicandogli una statua e regalandogli un appezzamento di
terreno.
Ma il pericolo non era certo finito. Le truppe di Porsenna non erano
riuscite ad entrare in città ma l’avevano posta in assedio, tagliandole ogni
possibilità di rifornimento. A Roma già cominciavano a scarseggiare i viveri
quando un giovane aristocratico romano, Muzio Cordo, propose al Senato un piano
che prevedeva l’uccisione del lucomone etrusco. Ottenuta l’autorizzazione passò
immediatamente all’azione: armato di un pugnale, penetrò nelle linee nemiche
fino a raggiungere l’accampamento dove Porsenna, assistito dal suo segretario,
era intento a distribuire la paga ai soldati. Muzio aspettò che l’operazione
finisse e quando il suo obiettivo rimase solo lo uccise con un colpo di pugnale.
Ma il suo era stato un tragico scambio di persona: aveva ucciso il segretario
del re. Catturato dai soldati e portato al cospetto di Porsenna, l’aristocratico
romano non tentennò neanche un attimo: “Ero qui per uccidere te. Sono romano e
il mio intento era quello di liberare la mia patria, ma ho fallito e quindi
punisco quella parte del mio corpo resasi colpevole di questo imperdonabile
errore”. Così dicendo mise la sua mano destra in un braciere dove ardeva il
fuoco dei sacrifici e non la tolse fino a che non fu completamente consumata. Da
quel giorno e per l’eternità questo coraggioso nobile romano avrebbe assunto il
nome di Muzio Scevola (il mancino).
Porsenna rimase molto impressionato da
questo gesto, che faceva il paio con il comportamento di Orazio Coclite, e
decise di liberarlo. Fu allora che Muzio inventò una storia destinata a cambiare
il destino di Roma, dimostrando di essere anche molto astuto oltreché
coraggioso. “Per ringraziarti della tua clemenza, voglio rivelarti che 300
giovani nobili romani hanno solennemente giurato di ucciderti. La sorte aveva
stabilito che io fossi il primo e ora sono qui davanti a te perché ho fallito.
Ma prima o poi qualcuno degli altri 299 riuscirà nell’intento”. Questa falsa
rivelazione spaventò molto il principe etrusco ed anche suo figlio, il meno
convinto di quella spedizione.
Lo stesso affermò che era molto più importante
salvaguardare il futuro del re di Chiusi piuttosto che preoccuparsi del destino
dei Tarquini. Fu così che Porsenna prese la decisione di intavolare trattative
di pace con i romani, della cui valenza era rimasto particolarmente colpito. Per
dare inizio alle trattative chiese in cambio degli ostaggi tra i quali si
trovava la giovane Clelia. Questa riuscì ad organizzare una fuga attraverso il
Tevere con la quale riportò a Roma, sane e salve, tutte le fanciulle romane.
L’episodio fece molto arrabbiare Porsenna che minacciò di interrompere le
trattative se le ragazze non fossero tornate nel suo accampamento. I romani
decisero per la restituzione delle giovani, un atto particolarmente doloroso
anche per Publicola considerando che tra le ragazze c’era anche sua figlia
Valeria. Ma ancora una volta il comportamento dei romani impressionò Porsenna
che acconsentì alla definitiva liberazione delle giovani che stavolta tornarono
a Roma accompagnate addirittura dai giovani maschi.
La guerra tra Roma e la
lega etrusca guidata da Porsenna terminava, almeno secondo i racconti degli
antichi romani in un modo onorevole ed in fondo indolore. E’ probabile che le
cose non andarono proprio così. Pur dando per assodato che il conflitto si
concluse attraverso una soluzione negoziale è abbastanza probabile che Roma
dovette pagare un pegno, rinunciando a gran parte dei territori conquistati in
precedenza ai danni di città etrusche e rinunciando soprattutto ad ogni velleità
di conquista. In questo senso va interpretata la “legge del ferro” imposta da
Porsenna, una sorta di disarmo unilaterale, per cui a Roma si poteva lavorare il
ferro solamente per costruire attrezzi agricoli. Un altro segnale in questo
senso, potrebbe essere l’accordo stipulato con Cartagine (tradizionale alleata
degli etruschi) sempre nel 508 a.c., per il quale Roma rinunziava ad ogni
pretesa sulle isole della Corsica e della Sardegna. Roma dovette accettare anche
una sorta di protettorato che prevedeva la presenza nell’Urbe di un contingente
etrusco. Di contro Porsenna rinunciò al suo progetto di restaurazione monarchica
e questo mandò su tutte le furie Tarquinio il Superbo che si rifugiò nella città
di Tuscolo presso suo suocero Ottavio Mamilio da dove riuscì nell’intento di
coalizzare le altre città latine (Ariccia, Ardea, Tivoli, Pomezia, Lanuvio …).
Obiettivo di questa nuova Lega Latina era quello di combattere contro questa
forte presenza etrusca nel cuore del Lazio e recuperare molti dei territori che
i romani avevano conquistato nei 244 anni che erano passati dalla sua
fondazione. I rappresentanti della Lega Latina si riunivano nel tempio di Diana
a Nemi e lì prendevano le più importanti decisioni.
Sembra proprio che una
disastrosa sconfitta patita dall’esercito etrusco ai danni della Lega Latina,
convinse Porsenna a tornarsene nella sua città di Chiusi, abbandonando Roma al
suo destino. La battaglia si svolse presso Aricia, ed accanto agli eserciti
della Lega Latina si schierarono anche i greci di Cuma. In questa battaglia
Porsenna perse suo figlio, Arunte, e questo tragico fatto contribuì a far
maturare la scelta del lucomone di ritirarsi nella sua città, determinando in
qualche modo il fatale destino della civiltà etrusca. Secondo la tradizione
etrusca, derivata dalla leggenda di Mastarna, con il quale dovrebbe essere
quindi identificato egli invece, occupata Roma, vi avrebbe dominato a lungo. Per
alcuni infine, Porsenna non sarebbe un nome proprio, ma il titolo corrispondente
a un'alta carica etrusca.
RAVNTHU
Ravnthu appartenne a due delle
più grandi famiglie tarquiniesi: per nascita a quella dei Thefrinai e per
matrimonio a quella ancora più prestigiosa e storica degli Spurinna. Quando morì
fu deposta con gli Spurinna nella regale Tomba dell’Orco, dove ancora
s’intravede dipinta in una nicchia, sullo sfondo di un paesaggio agreste.
Indossa una tunica bianca ed è distesa con meravigliosa scioltezza in banchetto,
accanto al marito Velthur il Grande, l’eroe che al comando di due eserciti
etruschi partecipò come alleato di Atene all’assedio di Siracusa. Le sue
quinquereme combatterono magnificamente nella battaglia di Lisimelia, ma quella
fu l’ultima azione militare di vasta portata in cui, nel meridione, apparvero le
forze navali di Tarquinia. Perché, come era stato scritto inesorabilmente, il
tempo concesso dagli Dei alla nazione etrusca stava per concludersi e nel
silenzio del cielo sereno era già risuonato lo squillo terrificante della tromba
sacra che ne annunciava la fine.
Roma invadeva le terre, atterrava le rocche,
devastava i porti, ma Tarquinia resisteva e contrattaccava. Ogni volta, a
difendere la libertà della città santa al nomen etrusco c’era uno Spurinna,
strettamente legato per vincoli di parentela alla matriarca Ravnthu. Prima scese
in campo suo figlio Velthur il giovane, poi suo nipote Avle, che i romani
chiamavano Aulus. Avle Spurinna spodestò dal trono Orgolnius, re di Cere, liberò
Arezzo dalla rivolta degli schiavi, tolse ai Latini nove città fortificate. Poi
carico di orgoglio, di rancore e di sete di libertà, affrontò Roma in campo
aperto. Tanta era l’ira di entrambe le parti che nessuna iniziò lo scontro con i
giavellotti, gli archi e le altre armi da getto. La battaglia fu subito aperta
con la spada, corpo a corpo, e la già inaudita violenza iniziale si accrebbe
durante la lotta.
I tarquiniesi vinsero e il prezzo che imposero ai vinti fu
durissimo: con un implacabile cerimoniale che si protrasse per giorni e giorni,
in un mare di sangue che inondò il Foro di Tarquinia, trecentosette prigionieri
romani furono giustiziati davanti all’Ara della Regina. Nella seconda battaglia
per la libertà, le truppe etrusche inferiori per numero furono sconfitte. Questa
volta fu Roma a non avere pietà. I tarquiniesi vinti furono passati per le armi
la sera stessa, sul luogo dello scontro. Trecentocinquantotto tra i più nobili
furono invece trascinati nell’Urbe. Qui, in un crescendo di orrore che superò
quello dell’eccidio dell’Ara della Regina, furono pubblicamente massacrati. I
ricchi oliveti, i vigneti, i campi della città vinta furono bruciati e gli
impianti idraulici insabbiati. Tarquinia non morì subito, anzi conobbe altri
anni di effimero splendore. Poi, pian piano, uscì dalla storia.
Mezzo
millennio più tardi, però, un cittadino della Roma Imperiale, che nonostante
l’oblìo dei molti secoli trascorsi voleva onorare il ricordo dei suoi antenati
etruschi, fece incidere in una epigrafe, gli “Elogia Tarquiniensia”, le lodi
degli Spurinna e il racconto delle loro grandi gesta. Tra i nomi degli eroi, con
grandissima dignità e rispetto, volle immortalare anche quello di Ravnthu, la
donna che orgogliosamente fu al centro della loro gente e della loro storia.
L’epigrafe degli Elogia è conservata nel Museo Nazionale Archeologico di
Tarquinia.
SERVIO TULLIO
Secondo la tradizione sesto re di Roma,
che avrebbe regnato dal 578 al 535 a.C. Nato, in base alla leggenda, a palazzo
reale da una prigioniera di guerra Ocresia, e dal lare domestico e allevato con
ogni cura, dopo che un prodigio aveva preannuncato la sua futura grandezza, con
l'aiuto della regina Tanaquilla succedette senza difflcoltà a Tarquinio Prisco,
di cui aveva sposato la figlia.
Il suo nome è associato a due fatti: la
costituzione serviana e il tempio di Diana sull'Aventino. Non pare invece che si
possano attribuire a lui le cosiddette mura serviane, almeno nello stato in cui
sono conservate. Il carattere distintivo del suo regno fu il tentativo di
fondere nativi ed etruschi. Servio venne educato a Roma nel palazzo reale. Sposò
una figlia di Tarquinio. Nel 579 Tarquinio fu ucciso ad opera di persone legate
all'ambiente dei figli di Anco Marcio, quarto re di Roma. Tanaquilla, dapprima
nascose al popolo la morte di Tarquinio, e poi riuscì a far nominare Servio re
di Roma.
L'imperatore Claudio, autore di un storia dell'Etruria, parlando in
senato a favore della concessione della cittadinanza romana agli abitanti della
Gallia Comata, per sottolineare la tradizione romana di apertura all'accoglienza
degli stranieri, narrò un storia diversa. Secondo Claudio, Servio Tullio, con il
nome di Mastarna (vedi paragrafo), avrebbe avuto un ruolo importante nella
storia di Vulci, città etrusca. Amico di Celio e Aulo Vibenna, signori di Vulci,
avrebbe combattuto al loro fianco senza fortuna. Con i resti dell'esercito si
sarebbe posto al servizio di Tarquinio, che per ricompensa gli avrebbe permesso
di abitare con i suoi compagni sulla collina a cui diede il nome di Celio, in
onore del suo capo. Questa versione potrebbe nascondere un fatto più grave: un
esercito, proveniente da Vulci, avrebbe occupato Roma e ne avrebbe cacciato i
Tarquini, che sarebbero rientrati alla morte di Servio Tullio, comandante
dell'esercito invasore. Mastarna è un nome latino etruschizzato, deriva da
magister e significhebbe qualcosa di analogo a "il condottiero". Il termine
servus, non di origine indoeuropea e forse etrusco, significava straniero senza
diritti, apolide.
In sostanza il sesto re di Roma sarebbe stato conosciuto
con un nome etrusco a Roma ed uno latino in Etruria. La costruzione
sull'Aventino del tempio dedicato a Diana, l'Artemide greca, fu un atto di
politica internazionale. Il tempio di Artemide ad Efeso era considerato il
simbolo della federazione delle città della Ionia in Asia Minore. Il culto di
Diana e l'idea di federazione dovevano essere assai vivi nel mediterraneo
occidentale dopo la rifondazione, avvenuta nel 540 a.C., della colonia greca di
Marsiglia. La statua di Diana venne posta nel tempio romano esattamente come
Artemide nel tempio di Marsiglia. Il tempio sull'Aventino, costruito intorno al
540 a.C., mirava a riunire politicamente e religiosamente Roma, il Lazio e
l'Etruria meridionale, a somiglianza del sistema federale etrusco dei Dodici
Popoli. Il tempio venne costruito fuori della città, su di un colle scarsamente
abitato. Solo nel 465 l'Aventino diverrà zona residenziale con una legge
ascritta al tribuno della plebe L. Icilio. La posizione esterna venne prescelta
probabilmente per poter attirare il maggior numero di persone, poveri,
immigranti, schiavi, ecc. La fondazione del tempio veniva festeggiata il 13
agosto.
Servio Tullio eresse i templi gemelli di Mater Matuta e della dea
Fortuna nel Foro Boario, il mercato in riva al Tevere. Mater Matuta è una
divinità italica, con tempio principale a Satrico, città a sud di Roma. La dea
della Fortuna, tradizionale divinità latina, era simboleggiata da una statua
velata, come quelle degli dei etruschi del Fato. La fondazione dei templi
gemelli veniva festeggiata l'11 giugno. Il tempio di Fors Fortuna venne
costruito sull'altra sponda del Tevere, fuori della cinta cittadina e alle
celebrazioni potevano partecipare gli schiavi.
Servio Tullio divise la
popolazione romana in base al territorio, indipendentemente da criteri etnici o
di nascita. La cittadinanza venne a dipendere dal luogo di residenza. In tal
modo molti immigrati, mercanti, agricoltori etruschi o di altra provenienza
poterono divenire cittadini romani, fedeli a Roma prima che alla famiglia o al
gruppo etnico. Vennero definite 4 tribù urbane: Suburana (il Celio), Palatina,
Esquilina, Collina. Il numero delle tribù extra-urbane, inizialmente 16, arrivò
in seguito a 31. L'appartenenza ad una circoscrizione territoriale (tribus),
basata sul domicilio, consentì lo sviluppo di un catasto per valutare i beni
fondiari ed assegnare i cittadini ad una classe e fissare il tributum
relativo.
Il popolo romano fu diviso in cinque classi di cittadini/soldati in
base al censo. Ogni classe forniva all'esercito un certo numero di centurie,
gruppi di cento uomini. Nella prima classe, la più ricca, si reclutavano 18
centurie di cavalieri e 80 di fanti, Nella seconda, terza e quarta 20 centurie e
nella quinta 30. Un sistema di tassazione proporzionale al reddito. Erano
esentati dal servizio militare e dalle spese connesse i cittadini con un reddito
molto basso (i capite censi). Le centurie all'interno di ogni classe si
distinguevano in quelle formate da seniores, la riserva dei cittadini al di
sopra di 46 anni, e quelle formate da iuniores, i combattenti effettivi. Le
centurie di iuniores e di seniores erano in numero pari.
La prima classe era
armata con elmo, scudo tondo, corazza e schinieri, lancia, giavellotto e spada.
La seconda classe era armata come la prima, ma senza corazza. Portava uno scudo
più piccolo e allungato. La terza classe aveva elmo e armi offensive. La quarta
classe aveva lancia e giavellotto. La quinta classe aveva delle fionde.
I
diritti politici erano proporzionali ai servizi che i cittadini fornivano
all'esercito. Ogni centuria, in quanto unità di combattimento era una unità di
voto. I capite censi formavano una sola centuria. Due centurie erano riservate
al genio (carpentieri e fabbri) e votavano con la prima classe. Due centurie
erano riservate ai musici e votavano con la quarta classe. In totale si avevano
193 centurie, con maggioranza assoluta della prima classe (80+18). Il sistema
eliminava i privilegi della nascita o della etnia, e nel contempo evitava gli
inconvenienti della tirannia del numero. I Comizi Centuriati costituirono
l'assemblea dei soldati e si riunirono all'esterno dei sacri confini della
città. Questa assemblea divenne l'entità dominante dopo la caduta della
monarchia, sia dal punto di vista legislativo che elettorale. Sarebbe stato
infine ucciso dal genero, Tarquinio il Superbo, d'accordo con la moglie Tullia,
la quale non esitò poi a passare con il cocchio sul suo corpo nel vicus che dal
fatto prese il nome di sceleratus.
SPURINNA (Gens)
A Tarquinia, nel IV
sec. a.C., la famiglia più potente ed egemone è quella degli Spurinna (Larth,
Velthur, Aulus). I vasti interessi di questa famiglia realizza un' alleanza con
la grande potenza ateniese e trascina appresso numerose città etrusche (si
potrebbe pensare ad una alleanza stipulata o consacrata al Fanum Voltumnae). In
questa alleanza, nel bene e nel male, il popolo etrusco è rappresentato da
Velthur Spurinna praetor di Tarquinia e figlio di Larth Spurinna. La carica di
praetor è la massima magistratura politico-militare, ma non religiosa, della
città stato (simile forse al consul romanus), sembra che Velthur l'abbia
ricoperta per ben tre volte. A lui viene affidato il comando della spedizione di
soccorso ad Atene impegnata nell'assedio della odiata rivale Siracusa nel
414-413 a.C.. Lo scontro definitivo tra Tarquinia, ancora potente e alla testa
della lega delle città etrusche, e Roma, data al 358-351 a.C. e si conclude con
una tregua di 40 anni allo scadere della quale, dopo un nuovo scontro armato
conclusosi nel 308 a.C., la tregua viene rinnovata per un uguale periodo. Di
queste vicende conosciamo la versione romana tramandataci da Tito Livio, ora
integrata con la versione etrusca fornita da alcuni frammenti degli elogia
relativi alle gesta di Aulo Spurinna, figlio o nipote del capostipite
Velthur.
Gli Spurinna ritornano alla ribalta con Giulio Cesare. Il generale
romano aveva al suo seguito un indovino discendente della famiglia tarquiniese
che gli aveva consigliato di non recarsi in Senato la mattina del tragico
eccidio.
TANAQUILLA
Nella splendida Tarquinia del VII secolo a.C.,
Tanaquilla era la donna che più assomigliava alla città. Nobile, ricchissima,
ambiziosa, era ammantata di una sacralità speciale, poiché nessuna come lei era
esperta nelle dottrine tagetiche.
Sapeva leggere i segni attraverso i quali
si manifestavano gli Dei e, come toccata dal divino, aveva il dono di
interpretarli in modo da stornare da essi tutto quello che si opponesse alla
propria volontà e allontanare ogni significato che ostacolasse i suoi progetti,
trasformando così il suo fascino divinatorio in potere personale al quale tutti
finivano per piegarsi.
Sposò Luchmon, figlio di una Tarquiniese e del greco
Demarato che, fuggito da Corinto con un seguito di ceramisti eccellenti e di
pittori squisiti, si era stabilito a Tarquinia, inondandola di bellezza e di
ricchezza. Ma a Luchmon, proprio perché figlio di uno straniero sia pure così
eminente, non era permesso dalle rigorose tradizioni etrusche di percorrere la
carriera politica fino ai massimi livelli. L’esclusione dai giochi del potere
sembrò intollerabile a Tanaquilla, che convinse il suo uomo a trasferirsi a
Roma, città ancora giovane e in cerca di una propria identità dove tutto poteva
accadere a chi era intelligente, intraprendente e ricco. Fu lei, che orgogliosa
e impavida sapeva guidare i veloci carri da corsa degli etruschi, a prendere
personalmente le redini del pilentum a quattro ruote carico di vasi dipinti e di
preziosità di ogni genere con il quale, lasciando Tarquinia insieme al suo
compagno, affrontò un destino che avrebbe cambiato la storia.
Sul Gianicolo,
il primo colle di Roma che si incontra giungendo dall’Etruria, accadde un evento
prodigioso: un’aquila piombando dal cielo ad ali spiegate, ghermì il cappello di
Luchmon e dopo aver volato con alti stridi, glielo ripose in capo, come se solo
per questo fosse venuta. Infine si rialzò in volo e sparì nel cielo altissimo.
Luchmon ritenne infausto il presagio e ne rimase sopraffatto. Tanaquilla, invece
abbracciò con riverenza il marito e vaticinò la gloria che lo attendeva:
l’aquila scesa da altezze così grandi era il messaggero dei Numi e aveva tolto e
rimesso il berretto etrusco sulla sua testa per significare che con lui stava
entrando in città un vero capo che, voluto dagli dei, avrebbe reso Roma più
grande e più potente.
Infatti Luchmon che era saggio e generoso ma che
soprattutto sapeva combattere a cavallo e a piedi più coraggiosamente degli
altri, divenne re con il nome di Lucio (Luchmon) Tarquinio (proveniente da
Tarquinia) Prisco, il primo dei re etruschi. In quel tempo, Roma non era una
vera città: sui colli tiberini esistevano soltanto sparuti gruppi di villaggi e
nei luoghi pianeggianti regnava ancora la palude. Tarquinio la drenò, trasformò
il terreno prosciugato in mercato, il futuro Foro Romano e di qui fece partire
un reticolo di strade lastricate tra le quali la Via Sacra. Poi costruì gli
edifici che sarebbero rimasti per sempre il nucleo monumentale dell’Urbe e gettò
le fondamenta del tempio di Giove Capitolino. Infine, trasmise ai romani tutti i
cerimoniali e i simboli che a Tarquinia significavano l’autorità: i littori con
i fasci di verghe e la scure, le porpore ricamate, le corone d’oro, i troni e
gli scettri d’avorio sormontati dall’aquila e l’uso di trionfare sul carro aureo
a quattro cavalli. Musici, danzatori, atleti, artisti tarquiniesi invasero la
città e riuscirono ad incantarla.
Da allora Roma incominciò a rincorrere un
sogno: diventare nel tempo raffinata come Tarquinia e superarla in grandezza e
splendore. Poi, negarne con crudeltà la dipendenza e cancellarne per sempre il
nome dalla storia.
TARQUINIO Lucio PRISCO
Secondo la tradizione quinto re
di Roma, che avrebbe regnato dal 616 al 578 a.C. Figlio di Demarato, un esule
corinzio stabilitosi a Tarquinia, insieme con la moglie Tanaquilla si sarebbe
trasferito a Roma, dove, mutato il nome Lucumone in Lucio Tarquinio e
accattivatosi il favore di Anco Marcio, alla sua morte sarebbe riuscito a farsi
eleggere re lasciando in disparte i giovani figli del sovrano, che circa 38 anni
dopo lo avrebbero fatto uccidere nel tentativo di riconquistare il trono.
La
tradizione gli attribuì la nomina di cento nuovi senatori, I'istituzione dei
duoviri sacris 1aciundis e dei ludi magni (romani), I'introduzione a Roma di usi
e costumi tipicamenie etruschi (in particolare le insegne regali, quali lo
scettro, la toga purpurea, la sella curalis, i fasci littori, e il rito del
trionfo) I'intrapresa di importanti opere pubbliche (Cloaca massima, circo
Massimo, tempio di Giove sul Campidoglio, ecc.) e vittoriose campagne contro
Sabini e Latini. Figura di indubbia storicità, al di là dei particolari
leggendari e sebbene sia da alcuni storici considerato tutt'uno con Tarquinio il
Superbo, è generalmente identificato con il Cnere Tarchunies Rumach raffigurato
nelle pitture della tomba Francois di Vulci, che rispecchiano una tradizione
diversa (etrusca) da quella ufficiale romana.
TARQUINIO Lucio il SUPERBO
Secondo la tradizione settimo e ultimo re di Roma, che avrebbe regnato
dal 535 al 509 a.C. Figlio o nipote del precedente, si sarebbe impadronito del
trono dopo aver fatto uccidere Servio Tullio, di cui aveva sposato la figlia
Tullia. Astuto e senza scrupoli, per ampliare il proprio dominio si servì più
che delle armi, come contro i Volsci, di spregiudicati stratagemmi, come quelli
escogitati per impadronirsi di Gabi (l'uccisione dei più influenti cittadini cui
avrebbe alluso, tagliando i papaveri di un campo) e per assicurarsi la
supremazia nell'ambito della Lega latina.
Ma con i suoi metodi tirannici e
oppressivi (scarsa considerazione per il senato, arbitraria amministrazione
della giustizia, mantenimento di una guardia del corpo, imposizione di corvées)
avrebbe suscitato sia tra i patrizi sia tra la plebe gravi malcontenti, sfociati
infine in aperta ribellione per la violenza usata da suo figlio Sesto alla
nobile Lucrezia. Cacciato quindi da Roma con tutta la famiglia, avrebbe poi
tentato invano di ritornarvi, con l'aiuto di Porsenna e dei Latini. La
tradizione gli attribuisce inoltre il compimento della Cloaca massima e del
tempio di Giove sul Campidoglio. Considerato da alcuni studiosi moderni
personaggio storico, è da altri ritenuto un semplice sdoppiamento di Tarquinio
Prisco.
TULLIA
Tullia, figlia del sesto re di Roma, era una vera
etrusca. Per sangue, perché nipote di Tanaquilla e di Tarquinio Prisco; per
diritto, perché sposò il più superbo dei Tarquinii; per temperamento, perché
ambiziosa e determinata. Era così sfrenatamente assetata di potere che viene
ricordata come uno dei personaggi più torvi e crudeli della complessa saga che
determinò, nel bene e nel male, la vita di Roma ai tempi della monarchia. In una
cupa atmosfera di complotti di palazzo, uccise il suo primo marito che riteneva
inadeguato a soddisfare le sue ambizioni. Poi eliminò sua sorella che aveva
sposato il nobile Tarquinio, detto il Superbo, un giovane di grande fascino, di
eccezionale intelligenza e di illimitata spregiudicatezza. Con Tarquinio e per
Tarquinio, di cui diventò consorte e complice, Tullia continuò ad ordire sempre
nuove congiure, rivolgendosi infine contro il proprio padre, Servio Tullio, il
re colpevole di aver emanato una Costituzione che limitava la signoria unica ed
assoluta tanto cara alle nobili famiglie etrusche trasferite a Roma. Aveva
imposto anche ai patrizi i tributi da pagare secondo il censo, perché riteneva
“conveniente e vantaggioso per la comunità che chi possieda molto, dia molto,
chi poco, dia poco”.
Per questo la Factio Tarquinia, cioè la fazione degli
aristocratici tarquiniesi che vedevano imbrigliata la loro egemonia su Roma,
ribolliva e Tullia, impaziente di prendere il potere, ne inaspriva gli animi con
furiosa perseveranza.
Finalmente il regicidio si compì, nel Vicolo Ciprio,
dove Tarquinio il Superbo sferrò spietatamente l’attacco da cui il vecchio
Servio Tullio non uscì vivo.
Tullia, fremente, non poté attendere chiusa nel
suo palazzo l’esito della congiura, perciò, scansato l’auriga, si recò sul luogo
del massacro guidando personalmente il suo veloce carro etrusco. Con questo,
come invasata, calpestò più e più volte, il corpo del padre. Poi, grondante di
sangue paterno, prima ancora che qualcun altro parlasse, gridò che Roma ora
aveva un altro re. Finalmente un grande re, suo marito Tarquinio. Lucio
Tarquinio, detto il Superbo, fu davvero grande: sotto di lui Roma divenne una
potenza militare imbattibile e schiere di commercianti, ingegneri, idraulici,
agronomi e di artisti, interi collegi di musici e danzatori scesero dall’Etruria
e vi portarono arte, progresso e benessere.
La stella di Tarquinia che, madre
di Roma, irradiava civiltà raffinatezza e bellezza, non brillò mai così fulgida
come in quel magico tempo.
Ma presto il regno si trasformò in aperta
tirannide: il Superbo, che già disprezzava la plebe, riempì la città di spie e
di provocatori per perseguitare chiunque si opponesse al suo arbitrio, non solo
i romani ma anche i nobili etruschi che gli avevano dato il potere, persino
alcuni Tarquinii suoi familiari. Proprio da questi fu cacciato per sempre da
Roma. Nella vicenda che portò alla repentina caduta della monarchia etrusca che
sembrava incrollabile, giganteggiò ancora una volta una donna. Si chiamava
Lucrezia.
VELIA
E' nota in tutto il mondo come la Fanciulla Velca.
Il suo squisito ritratto è considerato uno dei capolavori dell’arte antica ed è
il frammento più “classico” di tutta la pittura funeraria etrusca. Si chiamava
Velia, Velia Spurinna. Era nipote di Velthur il Grande, che aveva comandato due
eserciti etruschi all’assedio di Siracusa e di Ravnthu Thefrinai: era sorella di
Avle, l’eroe Tarquiniese che affrontò Roma in campo aperto e la vinse. Sposò
Arnth Velcha, appartenente ad un’aristocratica famiglia di magistrati di rango
così alto che avevano il diritto di essere scortati dai littori con i fasci di
verghe e l’ascia bipenne che, prima a Tarquinia e poi a Roma, furono il simbolo
del massimo potere. Dei Velcha conosciamo anche l’aspetto perché molti di essi
furono dipinti nelle pareti della loro grande Tomba degli Scudi, che prende il
nome dalle armi raffigurate in uno dei suoi affreschi. Qui tra gli altri,
appaiono anche i genitori di Arnth che, adagiati sul letto conviviale davanti ad
una tavola imbandita, si scambiano l’uovo dell’eterna fertilità mentre una
giovane ancella muove per loro un ventaglio di foglie e di piume. Arnth e suo
fratello Vel, avvolti in caldi mantelli, stanno invece in piedi vicino ad una
porta. Velia, sposando, assunse dai Velcha il nome con il quale è nota in tutto
il mondo. Eppure portava in sè così impresse la grazia e la dignità degli
Spurinna che questi, straziati dalla sua morte forse precoce, la vollero dipinta
nella loro Tomba dell’Orco.
Ora, basta scendere i ripidi scalini di questo
regale sepolcro, fare pochi passi e cercare con gli occhi: improvvisamente la
fanciulla ci appare in un piccolo affresco sospeso in un mare grigio e
indistinto di colori consunti dai millenni. Si presenta di profilo, quel suo
famoso profilo netto come una scultura che, reso con grande realismo ma
stemperato nella dolcezza dei particolari, ancora suscita stupore e costituisce
l’immagine più nota dell’iconografia etrusca. La ragazza veste una morbida
tunica e un mantello bordato di rosso. Indossa gli ornamenti preziosissimi ma
semplici degni del suo rango: orecchini a grappolo, collane di ambra, la corona
di foglie d’alloro dorato sulla chioma. I capelli castani sono in parte
trattenuti alla nuca da una elegante reticella, in parte ricadono in morbidi
boccoli ai lati del volto. Che è assorto. Il naso è dritto, di linea greca. Le
labbra sono piene e sensuali ed evocano perduti contatti d’amore. Perciò si
piegano in un sorriso doloroso quasi che il richiamare le gioie della vita
appena trascorsa procuri ancora alla ragazza innamorata un rimpianto
insostenibile. Gli occhi invece guardano lontano e sembrano già aver trovato nei
misteri della morte i motivi per accettare senza dolore tutti i distacchi. Come
un’ombra paurosa sta dietro di lei una creatura dalle ali gigantesche. Ha i
capelli pieni di serpi, le orecchie di animale e lo sguardo che lampeggia rosso
sull’orribile naso a becco d’avvoltoio. È Charun, il traghettatore delle anime
nel loro ultimo oscuro viaggio nell’Ade, che brandisce il pesante martello con
il quale spegneva la vita dei mortali. Ma questa volta il Demone Etrusco ha
perduto, perché la fanciulla dei Velcha ancora oggi, nonostante i millenni,
continua ad incantare e a sedurre, sospesa tra la vita che non vuole andarsene e
la morte che ancora non vince.
VIRGILIO Publius Maro
Publius
Virgilius Maro nacque a Pietole [allora: Andes, vicino Mantova] nel 70-, suo
padre era un agiato proprietario terriero, fece i primi studi a Mantova e
Cremona, poi a 15 anni a Milano e infine a Roma. Seguì i corsi del retore
Epidius ma li abbandonò: era goffo e timido, parlava con lentezza e non sapeva
affrontare il pubblico. Andò a Napoli, alla scuola del filosofo epicureo Syro:
si interessò di astronomia botanica zoologia medicina matematica. Scrisse i
primi versi, nel gusto del conterraneo Catullus. Compose a 28 anni le Bucoliche.
In questo periodo, durante la distribuzione di terre italiche ai veterani di
Filippi, perse temporaneamente i poderi (ne parla dolorosamente nei canti
pastorali), poi restituitigli per interessamento di Asinius Pollio che governava
la Cisalpina, e di Alfenus Varo. Abitò però sempre tra Napoli e Roma: qui aveva
una casa presso i giardini di Maecenas, sull'Esquilino.
Nel 39\37 entrò nel
circolo di Maecenate. Sempre discreto e timoroso, quando di rado veniva a Roma a
trovare i suoi amici poeti Cornelius Gallus, Horatius, Varius, Tucca ecc., tutti
del circolo di Maecenas, era già additato dalla gente, famoso per le "Bucoliche"
spesso cantate in teatro da attori di professione. In Campania nel 37\30 compose
le "Georgiche", poi si dedicò tutto all'Eneide. Diversamente da quanto, secondo
la tradizione, era solito fare (cioè alzarsi presto la mattina, buttar giù molti
versi, e poi sillabarseli interiormente durante il giorno) fece prima una
stesura in prosa, divise la trama in dodici libri, poi si mise a comporli uno
per uno seguendo il suo estro e non la successione dei fatti. Nel 24 ne lesse
tre canti alla corte davanti all'imperatore Augusto e a sua moglie
Ottavia.
Dopo 11 anni di lavoro, a opera compiuta, non era ancora
soddisfatto: molti versi provvisori, discordanze tra un libro e l'altro, voleva
visitare i luoghi teatro d'azione della prima parte. A 56 anni partì per Atene:
qui, dopo una giornata a Megara sotto il sole infuocato, si ammalò. Incontrò ad
Atene l'imperatore proveniente dall'oriente, si imbarcò con lui per mare, sbarcò
a Brindisi. Si dice che sul letto di morte volesse avere il manoscritto per
distruggerlo, ma non fu accontentato. Spirò qualche giorno dopo, nel settembre
19. La sua salma fu trasportata a Napoli e sepolta sulla strada di
Pozzuoli.
VULCA
Nell’ambito del rinnovamento dei santuari veienti nel
tardo VI sec. va senz'altro collegato il nome dell'unico artista etrusco
tramandatoci dalle fonti, Vulca di Vulci, al quale la tradizione romana assegna
origini veienti e la creazione della statua acroteriale del tempio di Giove
Capitolino a Roma, all'epoca di Tarquinio il Superbo. La coincidenza tra questi
dati delle fonti e l'emergere a Veio, nell'ultimo decennio del VI sec. a.C., di
una scuola di maestri coroplasti (cioè scultori in terracotta) autori di grandi
statue acroteriali (cioè destinate ad ornare i vertici dei frontoni dei templi)
per il Santuario di Portonaccio (ma un'antefissa è nota anche dal Santuario di
Porta Caere) è tale da autorizzarci a ritenere autentica la tradizione romana, e
ad attribuire a Vulca e alla sua scuola la paternità del celebre Apollo di Veio
e delle altre sculture decoranti il tetto del tempio di
Portonaccio.
Cronologia Etrusca
Secolo X a.C.
Fasi finali della
civiltà del bronzo.
Secolo IX a.C.
Fasi iniziali della civiltà del
ferro; cultura «villanoviana» nei territori dell’Etruria «propria» e sua
espansione verso l’Emilia-Romagna e il Salernitano. Formazione delle comunità di
villaggi.
Secolo VIII a.C.
Navigazione degli Etruschi nel Tirreno
meridionale.
Inizio della colonizzazione greca nella penisola
italiana.
775 ca. Stanziamento dei Greci a Pitecusa, nell’isola
d’Iscbia.
753 Fondazione di Roma, secondo la tradizione
varroniana.
750-725 Fondazione di Cuma.
Inizio della colonizzazione greca
in Sicilia.
Sviluppo del «villanoviano in Etruria — differenziazioni sociali
— fondazione del centri pre-urbani.
710-705 ca. Fondazione di Sibari, di
Crotone e di Taranto. Inizio della cultura «orientalizzante».
Adozione
dell’alfabeto greco e introduzione della scrittura in Etruria (e nel
Lazio).
Secolo VII a.C.
Primo iscrizioni etrusche rinvenute a
Tarquinia e a Cere.
Pieno sviluppo della cultura «orientalizzante».
650
ca. Demarato di Corinto si stabilisce a Tarquinia.
Influenze corinzie in
Etruria.
Fase evolutiva dell’orientalizzazione.
Inizio della civiltà
urbana. Fioritura di Cere.
Thalassocrazia ed espansione commerciale delle
città costiere dell’Etruria meridionale.
616 Inizio della monarchia etrusca
a Roma: regno di Tarquinio Prisco (fino al 578).
Secolo VI
a.C.
Espansione etrusca nella pianura Padana.
580 ca. Gli Etruschi
sconfitti dai coloni greci nel mare di Lipari.
578 Inizio a Roma del regno di
Servio Tullio (fino al 534).
565 ca. I Greci di Focea fondano Alalie in
Corsica.
540 ca. Coalizione cerite-cartaginese contro i Focei: battaglia del
Mare Sardo. Controllo etrusco della Corsica.
534 Inizio a Roma del regno di
Tarquinio il Superbo (fino al 5l0).
Fondazione di Marzabotto e di
Felsina.
525 Spedizione fallita degli Etruschi (con Umbri e Dauni) contro
Cuma.
510 Distruzione di Sibari ad opera di Crotone.
Fioritura di Capua
etrusca.
509 Cacciata di Tarquinio il Superbo e fine della monarchia etrusca
a Roma. Espansione di Chiusi nel Lazio: il re Porsenna a Roma.
505 ca.
L’esercito di Porsenna sconfitto presso Ariccia do Aristodemo di Cuma e dai
Latini. Gli Etruschi sconfitti dai Galli al Ticino.
Secolo V
a.C.
Thefarie Velianas signore di Cere.
Guerra tra Veio e Roma; strage dei
Fabii al Cremera.
474 Gli Etruschi sconfitti nelle acque di Cuma dai
Siracusani; fine della thalassocrazia e crisi delle città etrusche meridionali;
sviluppo delle città dell’Etruria interna e settentrionale; fioritura
dell’Etruria padana e adriatica.
454-453 Incursioni della flotta siracusana
nel Tirreno settentrionale. Inizio della pressione sannitica sulla
Campania.
428 Guerra tra Veio e Roma.
426 La città latina di Fidenae,
alleata di Veio, conquistata dai Romani.
423 Capua occupata dai
Sanniti.
Fine del dominio etrusco in Campania.
414-413 Un contingente
etrusco (forse di Tarquinia) partecipa all’assedio navale ateniese di
Siracusa.
406 Inizio dell’assedio di Veio da parte dei Romani.
Secolo IV a.C.
396 Veio conquistata e distrutta dai Romani: il suo
territorio incorporato nello stato romano.
390-386 Scorrerie dei Galli
nell’Italia centrale: Roma saccheggiata e incendiata.
384 Incursione della
flotta siracusana nel Tirreno e saccheggio del santuario di Pyrgi. I Siracusani
nell’Adriatico settentrionale.
382 Fondazione delle colonie romano-latine di
Nepi e Sutri. Ascesa di Tarquinia e sua egemonia sulla Lega etrusca.
358
Tarquinia (con Cere e Faleri) muove guerra a Roma. Detronizzazione del re di
Cere.
353 Pace separata tra Cere e Roma.
351 Fine della guerra e tregua
quarantennale fra Tarquinia e Roma. Rivolta «servile» ad Arezzo domata con
l’intervento di Tarquinia. Marzabotto e Felsina occupate dai Galli. Spedizioni
dei Galli nell’Italia centrale.
314 Navi etrusche in Sicilia in aiuto di
Agatocle di Siracusa contro i Cartaginesi.
311 Gli Etruschi in guerra contro
Roma. I Romani penetrano nell’Etruria centrale e interna.
307 Gli Etruschi
costretti alla pace con Roma.
302 Roselle assediata e occupata dai Romani.
Intervento di Roma ad Arezzo in appoggio alla famiglia dei Cilnii. Rivolte
«servili» a Volterra e a Roselle.
Completa decadenza di Spina.
Secolo III a.C.
296 Gli Etruschi nella coalizione «italica» contro
Roma.
295 I coalizzati sconfitti dai Romani a Sentino. Vittorie romane sugli
Etruschi.
284 Rivolta «servile» ad Arezzo.
282 Gli Etruschi
definitivamente sconfitti dai Romani al lago Vadimone.
280 Vulci eVo1sini si
arrendono a Roma. Le città etrusche costrette ad allearsi con Roma: l’Etruria
federata. Prefettura romana a Statonia.
273 Colonie romane a Cosa e a
Pyrgi.
265 Rivolta «servile» a Volsinii.
264 Volsinii conquistata e
distrutta dai Romani. Saccheggio del santuario della Lega. Volsinii ricostruita
sulle rive del lago di Bolsena. Colonie di Roma a Castrum Novum, Alsium e
Fregene.
241 Faleri conquistata e distrutta dai Romani. Trasferimento della
città in altra sede.
225 L’Etruria investita da un incursione di Galli
distrutti dai Romani a Talamone. Costruzione della via Clodia.
222 Spedizioni
romane contro i Galli, dalle basi etrusche. Costruzione della via
Flaminia.
217 Annibale, in Etruria, sconfigge i Romani al Trasimeno.
209 I
Romani rinforzano i presidi militari in Etruria.
205 Le città etrusche
contribuiscono alla spedizione africana di Scipione contro Cartagine.
Secolo II a.C.
196 Rivolta di schiavi in Etruria.
189 Fondazione della
colonia romana di Bononia.
186 Repressione del culto «sovversivo» di
Dioniso.
183-180 Fondazione di colonie di Roma a Saturnia, Gradisca e
Pisa.
177 Fondazione di colonie di Roma a Luni e a Lucca. Costruzione della
via Cassia.
Progressiva emancipazione di elementi servili nell’Etruria
settentrionale.
135 Viaggio del tribuno Tiberio Gracco attraverso
l’Etruria.
133-121 Fallimento dei tentativi di riforme sociali dei
Gracchi.
130 L’etrusco Marco Perperna eletto console a Roma.
Secolo I a. C.
91 Marcia su Roma degli Etruschi contro le proposte di
legge riformatrici del tribuno Livio Druso. Secessione e guerra degli alleati
italici contro Roma.
90 Interventi militari romani a Fiesole, Arezzo, Chiusi
e Volsinii.
89 Gli Etruschi ricevono la cittadinanza romana. Le città
etrusche diventano «municipi» dell’Italia romana.
87 Gli Etruschi parteggiano
per Mario.
82 Repressioni di Silla contro Fiesole, Arezzo e Volterra e
deduzione di colonie di veterani romani.
78 Effimere rivolte «popolari» a
Fiesole e in altre città.
63 Catilina si rifugia in Etruria e arruola truppe
a Fiesole e ad Arezzo.
49 Gli Etruschi neutrali nella guerra civile tra
Pompeo e Cesare.
40 Perugia, occupata dai seguaci di Antonio, conquistata e
saccheggiata dalle truppe di Ottaviano.
27 L’etrusco Mecenate tra i
consiglieri e i ministri di Augusto.
7 L’Etruria diventa la regione VII
dell’Italia romana.
Bibliografia
"La civiltà etrusca" Keller 1981,
Garzanti
"Etruscologia" M. Pallottino, Hoepli Milano 1968
“Tarquinia”
Maria Castaldi, Regione Lazio Ass. Cultura , Quasar 1993
“Origini e Storia
Primitiva di Roma” M. Pallottino, Ed. Bompiani 2000
“Guida insolita ai
luoghi, ai monumenti e alle curiosità degli Etruschi” Chiesa, Facchetti, Newton
& Compton Ed. 2002
Schede didattiche - Museo Archeologico Firenze
La
Società
Caratteristiche e sviluppi della società etrusca
L'
organizzazione politica: città-stato e loro associazioni
Il potere e le
forme istituzionali nei singoli stati
Il popolo
Le classi sociali
La classe sacerdotale
La famiglia
La donna
Caratteristiche e sviluppi della società etrusca
Nell'affrontare i problemi dell'organizzazione sociale e politica degli
Etruschi la nostra prima e fondamentale notazione è che non si può procedere ad
una pura e semplice rassegna descrittiva dei fenomeni senza considerarne
l'evoluzione nel tempo che è essenziale per la loro comprensione. Le notizie che
derivano da accenni occasionali e sommari degli scrittori greci e latini si
riferiscono pressoche esclusivamente al quadro delle istituzioni in alcuni dei
loro aspetti esteriori, ed in ogni caso per lo più ai tempi e alle circostanze
dei rapporti con Roma. Assai più vasta è la piattaforma delle testimonianze
epigrafiche che a partire dal VII secolo a.C. e per tutta la durata della
civiltà etrusca ci documentano nomi e formule onomastiche: ci danno cioè, per
quanto è stato finora scoperto (e continua ogni giorno a scoprirsi), una sorta
di radiografia della società etrusca; mentre le indicazioni biografiche delle
iscrizioni funerarie presentano titoli di cariche. C'è poi tutto l'insieme dei
resti archeologici che, per epoche anche più antiche, nella forma e nella
distribuzione delle tombe e nelle caratteristiche della produzione rivelano
consistenza, rapporti, sviluppi dei diversi nuclei e strati
sociali.
Difficilmente potremmo sfuggire all'importanza di due opinioni
correnti sulla società etrusca: cioè in primo luogo che essa si sia costituita
attraverso una progressione da piccole comunità semplici e indifferenziate a
raggruppamenti complessi con articolazioni dinamiche e forti emergenze di poteri
e di ricchezze; in secondo luogo che le oligarchie abbiano esercitato una
funzione dominante e durevole. Ma occorre intendersi sull'una e sull'altra
asserzione. È indubbio che nel periodo villanoviano, vale a dire come sappiamo
nella prima fase della civiltà etrusca, si manifestano ancora forme di vita
proprie delle culture di villaggio preistoriche (quali si riflettono con
evidenza nelle figurine e nelle scene dei bronzi di Vulci, di Bisenzio, di
Vetulonia) e apparenti rapporti egualitari denunciati dalla relativa uniformità
delle tombe: naturalmente in contrasto con quelli che saranno i costumi e gli
sfarzi della successiva fase orientalizzante. È però anche vero che sarebbe un
errore considerare la società villanoviana come una società primitiva. La
moltitudine e profondità di esperienze culturali che si sono succedute nel corso
dei tempi che precedono sul suolo d'Italia e nella stessa terra d'Etruria,
l'inevitabile osmosi con gl'influssi provenienti dall'evoluto Mediterraneo
orientale, la presenza già sottolineata di aggregazioni e di costruzioni evolute
nell'età del bronzo con particolare riguardo al bronzo finale (Luni sul Mignone,
Crostoletto di Lamone, Frattesina) rivelanti tra l'altro segni di spicco
politico-sociale: tutti questi elementi ci convincono che il fenomeno
villanoviano deve esser maturato in un ambito di strutture già evolute e
dinamiche; ne si può escludere che gli addensamenti e la somiglianza reciproca
delle deposizioni funerarie, con particolare riguardo ai pozzetti dei cremati,
ubbidiscano ad esigenze rituali comuni (ma non mancano segni anche piuttosto
evidenti di distinzioni, per esempio nell'uso delle urne a capanna rispetto ai
cinerari biconici, nella presenza degli elmi in funzione di coperchi, delle
armi, di corredi di oggetti di accompagno piuttosto abbondanti).
Le attività
metallurgiche, artigianali, cantieristiche riflettono necessariamente una
specializzazione del lavoro. Le imprese navali a largo raggio già iniziate in
questa età presuppongono e comportano accentramenti di capacità finanziarie e
quindi formazioni di gruppi di potere. Che poi tali gruppi, anche appoggiandosi
ai possessi terrieri e alla loro trasmissione ereditaria, tendano a chiudersi in
una cosciente autorità egemonica di alcune famiglie privilegiate, cioè in un
sistema oligarchico gentilizio analogo a quello della Grecia contemporanea, con
ogni possibile apparato di prestigio e di lusso, questo può considerarsi
veramente il processo che, determinandosi nel corso dell'VIII secolo,
differenzierà dalla società villanoviana la società orientalizzante.
È
probabile, anche se non certo, che su questo processo s'innesti la formazione
del sistema onomastico bimembre, che crediamo di origine etrusca, e si ritrova
anche nel mondo latino e italico, differenziandosi dalle formule in uso presso
altri popoli del mondo antico come i Greci, che indicavano le persone con il
semplice nome e patronimico (Apollonio di Nestore), o anche con un epiteto di
discendenza (Aiace Telamonio), senza tuttavia esprimere con evidenza il concetto
di una continuità familiare. La formula vigente nell'Italia antica è
sistematicamente rappresentata da un doppio elemento, e cioè dal prenome
personale e dal nome di famiglia o gentilizio: in questo senso esso è l'unico
sistema onomastico del mondo antico che anticipi una costumanza affermatasi, per
necessità sociali, culturali e politiche, nell'ambito della civiltà moderna.
Accanto ai due elementi principali appaiono spesso il patronimico e il
metronimico (nomi paterno e materno), talvolta anche i nomi degli avi; al
gentilizio può aggiungersi, raramente e per lo più tardivamente, un terzo
elemento onomastico che i Romani dissero cognomen, forse di origine individuale
ma generalmente adoperato a designare un particolare ramo della gens. È
indubitato che l'elemento più antico è il prenome o nome individuale, che fu in
origine un nome singolo. Si ritiene che i gentilizi siano derivati dal nome
singolo paterno (per intenderci, come il greco Telamonio), mediante l'aggiunta
di un suffisso aggettivale che spesso è -no: così ad esempio Velno da Vel.
Ma poi i gentilizi si formarono anche da nomi di divinità (Velfino), di
luoghi (Sufrina) o in altro modo talvolta non definibile. L'originalità del
sistema sta comunque nel fatto che la nuova formazione resta definitivamente
fissata per tutti i membri della famiglia e loro discendenti. Si discute se
l'apparizione e la diffusione dei gentilizi siano avvenute nel corso del VII
secolo, o già prima, come è possibile. Il numero delle gentes conosciute è
grandissimo, possiamo dire illimitato; constatazione interessante che esclude
l'ipotesi di una contrapposizione tra un ristretta oligarchia dei membri delle
gentes ed una massa di popolazione estranea al sistema gentilizio. A dire il
vero si ha l'impressione che in origine tutti i membri delle nascenti comunità
urbane etrusche, in quanto cittadini liberi, fossero inquadrati nell'ambito del
sistema "gentilizio"; ma non nel senso di una loro aggregazione entro i limiti
di pochi e vasti organismi familiari, bensì nel senso dell'appartenenza a
singoli e numerosi ceppi familiari ciascuno dei quali era contraddistinto da un
particolare nome gentilizio. Si può pensare a qualche cosa di simile a quello
che accade nel mondo moderno verso la fine del medioevo, quando nascono i nomi
di famiglia, e tutta la popolazione, dalle classi elevate alle più umili, finirà
con l'adottare un unico sistema onomastico. È naturalmente possibile -
quantunque non provato - che nell'Etruria arcaica esistessero gentes patrizie e
plebee, come a Roma durante la repubblica. La vera e propria classe inferiore è
rappresentata dai servi, dagli attori e dai giocolieri, dagli stranieri, ecc.,
che nei monumenti appaiono contraddistinti soltanto da un nome personaIe e sono
quindi estranei all'organizzazione gentilizia. Se una società di liberi,
suddivisa in piccoli e numerosi aggregati familiari, poteva conciliarsi con una
costituzione monarchica di tipo arcaicaca, ciò parrebbe più difficile per lo
stato oligarchico attestato dagli accenni degli scrittori antichi per una fase
posteriore della civiltà etrusca.
Tuttavia i monumenti epigrafici continuano
a presentarci famiglie - di cui per questo periodo più tardo si conoscono ormai
complesse genealogie - assai numerose in ciascuna delle città etrusche, e sulla
base di un'apparente parità sociale. Ma è possibile anche intravvedere la
formazione di aggregati familiari più vasti, contraddistinti da un
sologentilizio, ma con numerose ramificazioni anche fuori dell'ambito della
città originaria. E’ il manifestarsi della gens nel senso più propriamente noto
nel mondo romano; e non di rado ai gentilizi si aggiungono cognomi adottati per
distinguere i diversi rami della famiglia. Alle piccole tombe strettamente
familiari del periodo arcaico si sostituiscono i grandiosi ipogei gentilizi con
numerose deposizioni. Si può osservare un più frequente ricorrere di matrimoni
tra membri di alcune gentes, che sono poi quegli stessi che più di frequente
rivestono cariche politiche e sacerdotali. Ciò si spiega abbastanza logicamente
supponendo che nell'ambito dell'originario sistema sociale gentilizio si sia
venuta ulteriormente determinando una netta prevalenza di alcune gentes maggiori
che avrebbero costituito la oligarchia dominante. Di ciò si è già fatto cenno
nella trattazione storica. È evidente che di quelle oligarchie sono esponenti,
ad esempio, a Tarquinia gli Spurina o i Velcha, come ad Arezzo i Cilnii, o a
Volterra i Ceicna (Cecina) dai numerosi rami. Più difficile è stabilire la
posizione delle gentes minori o plebee nell'ambito dello stato oligarchico; come
anche determinare le caratteristiche delle classi proletarie e servili. Sono
abbastanza frequenti, specialmente nell'Etruria settentrionale, iscrizioni
funerarie appartenenti a personaggi designati con i termini lautni, etera,
lautneteri; in alcuni casi essi recano il solo prenome, segno di condizione
servile, o conservano un nome di origine straniera. La parola lautni deriva da
lautn "famiglia" e significa letteralmente "familiare"; ma è adoperata come
corrispondente del latino libertus. Quanto ad etera non si sa precisamente il
valore del termine, che qualcuno traduce come «servo».
Un'affermazione
politico-sociale delle classi inferiori è ricordata dalla tradizione storica per
Arezzo e per Volsinii dove avvenne nella prima metà del III secolo a.C. una vera
e propria rivoluzione proletaria con la conquista del potere e la momentanea
abolizione delle differenze di casta (per esempio il divieto di connubio) con
l'aristocrazia dominante. Resta tuttavia dubbio se e fino a qual punto tali
lotte sociali possano interpretarsi anche come un urto tra genti maggiori e
minori nell' ambito del sistema gentilizio, analogo alla lotta tra patrizi e
plebei nella Roma repubblicana, ovvero debbano intendersi esclusivamente come
una affermazione rivoluzionaria di elementi servili estranei alle gentes.
D'altra parte, come è stato recentemente dimostrato da H. Rix, nelle città
dell'Etruria settentrionale ebbe luogo, al più tardi nel II secolo a.C., una
generale ascesa pacifica di elementi servili, i cui nomi individuali (come Cae,
Tite, Vipi) divennero nomi gentilizi. Trattando della famiglia e del sistema
onomastico degli Etruschi, si può fare un riferimento al cosiddetto
"matriarcato" degli Etruschi. È questa soltanto una leggenda erudita, nata dal
confronto fra usanze dell'Etruria e dell' Asia Minore, quali vengono riportate
da Erodoto (I, 73), e alimentata dalle notizie degli scrittori antichi sulla
libertà della donna etrusca. Il fatto che i fanciulli lidii fossero chiamati con
il nome della madre e non con quello del padre è stato posto a confronto con
l'uso etrusco - attestato nelle iscrizioni - del metronimico. Ma in realtà nelle
iscrizioni etrusche l'elemento prevalente è il patronimico, anche se in molti
epitafi sono riportati il gentilizio e talvolta il prenome della madre.
Non
vi è dubbio che la donna abbia nella società etrusca un posto particolarmente
elevato e certamente diverso da quello della donna greca di età classica. La
partecipazione ai banchetti con gli uomini è indizio esterno di una parità
sociale, che ricollega anche per questo aspetto la società degli antichi
Etruschi a costumi propri del mondo occidentale e moderno. Un ultimissimo cenno
a quel tipo di istituzione sociale che, parzialmente su modelli ellenici, ebbe
particolare importanza nel mondo italico e specialmente romano: ci riferiamo
alle associazioni di giovani, alla iuventus. È possibile e probabile che ciò
esistesse anche nel mondo etrusco. Già in età arcaica appare raffigurato il
giuoco della Troia (Truia), consistente in abili evoluzioni di cavalieri
connesse con la iuventus; e a questa si allude forse con la parola huzrnatre
derivata dalla radice hus, huz- che esprime il concetto di “giovane,
gioventù”.
L' organizzazione politica: città-stato e
loro associazioni
All'epoca dei contatti dell'Etruria con Roma la vita
politica della nazione etrusca poggia essenzialmente sopra un sistema di piccoli
stati indipendenti facenti capo a città preminenti per grandezza e per
ricchezza. Non sappiamo quali fossero le effettive condizioni del periodo
arcaico; ma la coesistenza di diversi centri di grande importanza a poca
distanza l'uno dall'altro, come Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, con propri
poteri, caratteristiche e costumanze, sembra effettivamente ispirarsi al sistema
della città-stato proprio delle contemporanee colonie greche e fenicie
d'occidente. Questa struttura politica - estesa anche nel Lazio etruschizzato -
è designata tecnicamente in latino con il termine populus, di probabile origine
euusca, che appare, in un certo senso, sinonimo di civitas, dell’osco-umbro
touto, toto. In etrusco il concetto è reso, probabilmente con diverse sfumature,
dai termini spur-, mex e forse anche tufi (dall'italico). Il nome ufficiale dei
populi è quello degli abitatori stessi delle città: Veienti, Tarquiniesi,
Ceretani, Chiusini, ecc.
È probabile che con il procedere del tempo le
singole città sovrane si siano aggregate un territorio più o meno vasto,
sottomet- tendo altre città rivali, come vediamo in atto nella più antica storia
di Roma; ma non è escluso che alcune delle città conquistate possano aver
conservato una parziale autonomia o siano state legate da rapporti di alleanza
con i dominatori (ciò che potrebbe spiegare l'esistenza di centri di media
importanza specialmente nell'Etruria interna, come Nepi, Sutri, Blera, Tuscania,
Statonia, Sovana, ecc., nel territorio delle maggiori città, cioè di Veio,
Tarquinia, Vulci). Si consideri inoltre la possibilità di vincoli di dipendenza
delle colonie dalle città di origine: per esempio nella espansione etrusca in
Campania e verso settentrione. Ma in realtà, per quanto ci consta, il principio
dell'autonomia e del frammentismo politico deve aver prevalso anche nella
costituzione dei domini etruschidell'Italia meridionale e settentrionale.
Il
centro della vita politica e culturale dell'Etruria è dunque da ricercare nelle
grandi città dominanti, di cui possediamo gli splendidi resti, e che il computo
tradizionale calcola in numero di dodici (solo in età romana si parla di
quindici popoli). Quali sono queste città? Certamente all'epoca della conquista
romana si contano tra di esse Caere, Tarquinia, Vulci, Roselle, Vetulonia,
Populonia, Volsinii, Chiusi, Perugia, Cortona, Arezzo, Fiesole, Volterra; Veio
era stata annessa al territorio romano già dall'inizio del IV secolo, Alcuni
centri minori dovevano essere ancora autonomi nel IV e III secolo a.C., come
parrebbe risultare da monete con i nomi di Peithesa, Echetia e di altre città
non meglio identificate. Nuclei abitati fiorenti in età arcaica, quali
Acquarossa, Bisenzio, Marsiliana d' Albegna (Caletra?) e la stessa Vetulonia,
decadono più tardi: altre città si svilupperanno soltanto alla fine della
civiltà etrusca, sotto il dominio di Roma, quali Siena, Firenze, Pisa,
Luni.
Una fase anteriore a quella dell'organizzazione urbana non è
documentabile storicamente: ne possiamo quindi conoscere il sistema politico e i
reciproci rapporti dei villaggi protostorici dei quali restano tracce nel
territorio etrusco. Accenni indiretti di scrittori e l'analogia con la
costituzione primitiva di Roma potrebbero far supporre che la popolazione delle
città fosse ripartita in tribù e in curie. Per il resto, cioè per il rapporto
fra queste ripartizioni interne e i nuclei territoriali di aggregazione dai
quali sarebbero sorte le città stesse, nonche i centri minori dipendenti, regna
almeno per ora l'oscurità più completa.
Ogni città-stato o città capitale
(caput) di uno stato costituisce un mondo politicamente ed entro certi limiti
culturalmente a se stante (si pensi ad esempio allaspecializzazione dei prodotti
artistici, per cui tra le altre Tarquinia eccelse soprattutto per la pittura
funeraria, Caere per l'imitazione dell'architettura interna delle tombe, Vulci
per i bronzi e per la scultura, e così di seguito). Gestione interna, commerci,
eventuali imprese navali dovettero essere autonome come nelle poleis della
Grecia arcaica e classica. Le notizie delle fonti storiche ci persuadono a
ritenere che anche la politica estera fosse decisa con sostanziale autonomia da
ciascuna città secondo i propri interessi. Tuttavia esistono altri indizi,
sempre delle fonti, che ci indirizzano verso il ricordo di un tipo di
associazione delle città etrusche per la quale si è usato modernamente il
termine di lega o di federazione. Dobbiamo chiederci quale sia l'effettiva
natura di quest'ultima istituzione, che ha dato luogo a discussioni tra gli
studiosi. L 'esistenza di forme associative tra diverse comunità autonome è un
fatto ben noto nel mondo antico, in Grecia come in Italia, sia pure con diverse
caratteristiche a seconda dei tempi e dei luoghi; ne può quindi destare
meraviglia. Per l'Etruria gli scrittori antichi non usano, a quanto ci consta,
un termine specifico per indicare l'associazione stessa; ma parlano dei duodecim
populi, dei duodecim (o quindecim) populi Etruriae o semplicemente di Etruria,
di omnis Etruria.
Il numero dodici delle grandi città dell'Etruria propria -
alle quali facevano riscontro altrettante della Etruria padana e della Campania
- ha probabilmente un carattere rituale: come in altri casi analoghi del mondo
antico, e forse, ma non necessariamente, per analogia con le dodici città della
lega ionica (considerati gli antichi legami culturali fra Etruria e lonia
asiatica). Che si tratti per altro non soltanto di uno schema ideale, ma di una
reale istituzione politica, può dedursi da quei riferimenti, principalmente di
Livio (IV, 23; V, 1; X, 16, ecc.), nei quali si accenna ad una adunanza di
consultazione annuale o comunque periodica (concilium) tenuta dagli stati
etruschi e dai loro capi (principes) al Fanum Voltumnae. Ha giustamente posto in
rilievo L. Pareti che simili testimonianze non sono sufficienti a provare il
carattere continuativo ed un forte potere soprastatale del supposto istituto
federale etrusco. Accertata l'esistenza di feste e di giochi annuali panetruschi
nel santuario di Voltumna - non altrimenti da ciò che sappiamo relativamente al
mondo greco per Efeso, Olimpia, Delfi, Corinto -, si potrebbe infatti supporre
che soltanto circostanze politiche di carattere eccezionale, come la minaccia di
Roma, possano avere indotto i rappresentanti dei diversi stati etruschi a
concertarsi nel santuario nazionale e financo a coalizzarsi in una lega politica
e militare. Ma esistono d'altra parte riferimenti che paiono indicare una certa
continuità dell'istituto ed una relativa subordinazione ad esso dei singoli
stati: ad esempio il passo di Servio (ad Aen., VIII, 475), nel quale è detto che
l'Etruria aveva dodici lucumoni, o re, dei quali uno era a capo degli altri, o
gli accenni di Livio (l, 8, 2; V, 1) alla elezione di un re da parte dei dodici
popoli, ciascuno dei quali forniva un littore per i fasci, e più tardi alla
elezione di un sacerdote al Fanum Voltumnae in occasione delle adunanze degli
stati etruschi. In sostanza dall'attendibilità delle notizie contenute in questi
riferimenti dipende il nostro giudizio sulla lega etrusca.
È interessante
notare che in due delle testimonianze si parla di re: ci si riferisce cioè
preferibilmente ad epoca arcaica. Ma in altro passo di Livio si parla di un
capoelettivo della comunità degli Etruschi, il quale alla fine del V secolo
(cioè all'epoca del conflitto tra Veio e Roma) era un personaggio designato con
il titolo di sacerdos, e perciò dotato di poteri eminentemente religiosi (o
ridotti alla sola sfera religiosa). In alcune iscrizioni latine di età imperiale
ricorre il titolo praetor Etruriae che appare anche nella forma praetor Etruriae
XV populorum, cioè della comunità nazionale etrusca che in età romana pare
accresciuta di tre città. Ora fra le cariche esercitate da personaggi etruschi e
ricordate da iscrizioni in etrusco conosciamo il titolo zilat? mexl rasnal. Dal
celebre passo di Dionisio (I, 30, 3) in cui gli Etruschi sono designati con il
nome nazionale di Rasenna sappiamo che la parola rasna dovrebbe significare
«etrusco, Etruria». D'altra parte la magistratura indicata con la parola zilat?,
che pare sia la più elevata fra le cariche delle repubbliche etrusche, equivale
assai probabilmente al praetor dei Romani. Per mexl si può pensare ad un
genitivo della parola mex che ricorre nella iscrizione della lamina d'oro lunga
di Pyrgi, e forse tradurre ”dei populi”. Risulterebbe così una corrispondenza
del titolo zilat? mexl rasnal con praetor Etruriae (populorum). Si può discutere
se questa carica si identifichi con la suprema presidenza elettiva dei populi
etruschi, o con una magistratura di rappresentanza dei singoli populi nel
concilio federale, come quella dei principes ricordati da Livio. La prima
ipotesi sembra oggi la più probabile. Se le notizie relative alla supremazia di
uno degli antichi sovrani delle città etrusche non sono del tutto prive di
fondamento, si potrebbe arrischiare l'ipotesi che una forma originaria di legame
unitario esistesse fra gli Etruschi del sud all'inizio dei tempi storici, sotto
la egemonia di una o dell'altra città. Più tardi questa antica unità avrebbe
assunto il carattere di associazione religiosa, commerciale e politica, con
feste e adunanze nazionali nel santuario di Voltumna presso Volsinii. La
elezione di un supremo magistrato annuale è forse il ricordo dell'alta sovranità
di un capo sugli altri. Sappiamo da Livio che verso la fine del V secolo il re
di Veio poneva la sua candidatura alla elezione - il che conferma implicitamente
l'importanza della magistratura nazionale -, ma ne usciva battuto.
Il potere e le forme istituzionali nei singoli stati
Le condizioni di fatto esistenti nelle città etrusche tra il IV e il
II secolo a.C., hanno influito sulla generale interpretazione delle istituzioni
politiche e sociali etrusche quale risulta dai riferimenti degli scrittori
antichi. Le città appaiono dominate da un' oligarchia gentilizia (solo
sporadicamente e per breve tempo soppiantata da altre classi sociali), con
magistrati genericamente designati dalle fonti romane come principes. I
monumenti confermano in parte la tradizione pre- sentandoci grandiose e ricche
tombe gentilizie con numerose deposizioni, iscrizioni riferibili a membri di
alcune famiglie strettamente imparentate e soprattutto epigrafi di personaggi
che portano titoli di cariche temporanee e probabilmente collegiali, secondo un
sistema altrimenti noto nelle costituzioni delle città-stati del mondo antico.
Ma tali condizioni non rispecchiano evidentemente il quadro della vita politica
etrusca nei secoli più antichi della storia nazionale.
Molte fonti ci
parlano dell'esistenza di re nelle città etrusche. Il termine lucumone (lat.
lucumo, lucmo, in etrusco probabilmente lauxume, lauxme, luxume) ricorre
talvolta quale prenome personale di personaggi etruschi, come nel caso del re di
Roma Tarquinio Prisco; ma è generalmente usato come nome comune per designare i
capi etruschi. Il commentatore di Virgilio, Servio, in un caso chiama lucumoni i
magistrati preposti alle curie della città di Mantova (ad Aen, X, 202), altrove
identifica esplicitamente i lucumoni con i sovrani della città (ad Aen, II, 278;
VIII, 65, 465). E’ accertato che i lucumoni equivalessero ai principes,
designando ambedue i termini null'altro che i capi delle famiglie patrizie. È
però probabile che il termine principes indichi, più che una condizione sociale,
le magistrature dello stato repubblicano, e forse anche magistrature supreme;
tutto porta a credere che il titolo lucumone designi i re etruschi di età
arcaica, secondo l'esplicita e ripetuta affermazione di Servio.
Non sembra
quindi necessario ricercare, con S.P. Cortsen, la parola etrusca per re nel
titolo * pursna, * purtsna, purfne, che sarebbe stato considerato come un nome
proprio nel caso del re di Chiusi Porsenna. È d'altro canto probabile che,
analogamente a quanto accadde a Roma per il termine rex (sacrificulus), il
titolo degli antichi monarchi non sia stato abolito con la trasformazione dello
stato in una repubblica aristocratica e si sia conservato accanto alle nuove
magistrature, sostanzialmente svuotato del suo contenuto politico e volto a
funzioni religiose. Nel testo sacro della Mummia di Zagabria si parla di
cerimonie compiute lauxumneti, «nel lauxumna», cioè probabilmente la residenza
del lauxume, il lucumone: qualche cosa di analogo alla Regia, residenza dei
Pontefici, in Roma. Infine il capo elettivo del Fanum Voltumnae, designato da
Livio come sacerdote, non sarà forse stato in origine altro che il re eletto dai
dodici popoli e il lucumone più potente ricordato da Servio: sia pure con
funzioni sminuite e trasformate dal mutare dei tempi e delle concezioni
politiche.
Quale carattere ebbe la monarchia etrusca primitiva? purtroppo ci
mancano gli elementi per determinarlo e soltanto l'analogia con quel poco di
storicamente certo che ci è noto sulla monarchia romana consente qualche
supposizione. Il re doveva avere il potere giudiziario supremo che esercitava, a
detta di Macrobio (Saturn., l, 15, 13), ogni otto giorni in udienze pubbliche.
Doveva essere il capo dell'esercito ed anche della religione dello stato. Meglio
informati siamo sopra alcuni costumi cerimoniali e attributi esteriori della
monarchia, che furono ereditati da Roma e considerati dagli scrittori antichi
come di origine specificamente etrusca: così la corona d'oro, lo scettro, la
toga palmata, il trono (sella curulis), l'accompagno dei fasci e altre insegne
del potere, la presenza di uno scriba che registra gli atti sovrani; così forse
anche la cerimonia del trionfo.
Particolarmente interessante è il problema
delle origini del fascio littorio. La sua origine etrusca è sostenuta
esplicitamente dagli scrittori di età imperiale, come Silio Italico (Puniche,
VIII, 483 sgg.) e Floro (l, 1, 5). La più antica rappresentazione di fasci senza
scure s'incontra in un rilievo chiusino del Museo di Palermo che si data nella
prima metà del V secolo a.C.: cade quindi l'ipotesi che i littori e i fasci al
seguito dei magistrati etruschi nelle città federate siano una imitazione delle
costumanze di Roma. È probabile che in origine il fascio fosse soltanto uno e
che il moltiplicarsi del numero dei littori sia dovuto all'estendersi della
sovranità su più territori o al moltiplicarsi dei per- sonaggi detentori del
potere supremo. Al simbolo materiale dei fasci corrisponde una capacità politica
e religiosa, che i Romani designarono con il nome di imperium. A riprova del
valore dell'ascia come simbolo del potere sovrano sta il fatto che soltanto l'
imperium maius ed alcune particolari circostanze davano diritto al magistrato
romano dì inalberare i fasci con la scure. L' imperium, distinguendosi da una
generica potestas, è la pienezza dei poteri giudiziari e militari: esso è in
sostanza la sovranità degli antichi re di Roma trasmessasi ai magistrati
repubblicani. Il concetto di imperium, con le sue sfumature religiose, deriva
probabilmente dalla monarchia etrusca.
Nello studio del passaggio dallo stato
monarchico allo stato repubblicano in Etruria - passaggio avvenuto tra il VI e
il IV secolo a.C. - va tenuta presente la portata internazionale del fenomeno
che investe, con linee sostanzialmente analoghe, la storia istituzionale dei
Greci, dei Fenici, dei Latini, degli Etruschi, e che dimostra, per certi aspetti
sostanziali della vita pubblica, la profonda unità della civiltà mediterranea
anche in epoca anteriore all'ellenismo e alla romanità.
Dalla monarchia
primitiva a carattere religioso si passa allo stato oligarchico con magistrature
elettive, collegiali e temporanee: talvolta il processo si affianca o si
sviluppa con affermazioni di potere personale (tirannie) e con soluzioni
democratiche. In molte città greche la trasformazione è già in atto in epoca
protostorica, durante e dopo l'età micenea; mentre altre città come Sparta
conservano, almeno formalmente, l'istituto monarchico fino alla fine della loro
storia. Nel mondo greco d'occidente le nuove soluzioni sembrano già in gran
parte affermate sin dagli inizi della colonizzazione; mentre a Roma il mutamento
ha luogo nel VI secolo. Le molte teorie proposte per spiegare il passaggio dalla
monarchia romana alle magistrature repubblicane si orientano da un lato verso il
concetto dell'evoluzione continua e necessaria, da un altro lato verso l'idea di
una innovazione improvvisa. Quest'ultima potrebbe effettivamente ricollegarsi
all'imitazione di istituti stranieri (greci, latini o anche etruschi?). È stata
inoltre affacciata, essenzialmente da S. Mazzarino, la proposta che agli inizi
dello stato repubblicano, prima dell'affermarsi delle magistrature collegiali
sia da ricostruire una fase di magistrature singole o preminenti, a carattere
prevalentemente militare, quasi dittature stabili, sostituitesi alla regalità
arcaica. In tal senso sono state interpretate tradizioni relative a titoli come,
in Roma, quelli del magister populi o del praetor maximus; e si è anche creduto
di poter riconoscere un simile tipo di potere nel personaggio etrusco Mastarna,
il cui nome Macstrna (senza prenome nella tomba Franr;ois di Vulci) sarebbe
null'altro che un titolo derivato dal latino magister: tanto più che Mastarna
era stato da alcune fonti identificato con il re di Roma Servio Tullio, alle cui
riforme costituzionali si faceva risalire l'origine stessa della repubblica
(Livio, I, 60). L'esistenza di forti poteri personali nelle città etrusche e
latine tra la fine del VI e il principio del V secolo s'inquadrerebbe nel
diffuso costume delle tirannie che caratterizza le città greche d'occidente in
quel medesimo periodo (si pensi ad esempio ad Aristodemo di Cuma), per una sorta
di mimetismo politico. Le laminette d'oro in scritte in etrusco e in punico
trovate a Pyrgi recano un nuovo prezioso contributo alla discussione di questo
problema, dato che esse ci presentano la figura del dedicante Thefarie Velianas,
designato in punico come "re di Caere" o "regnante su Caere" (ma in etrusco
probabilmente già come zilac, cioè praetor), con tutte le caratteristiche di un
capo di stato investito di potere unico e personale.
Oltre a ciò va detto che
probabilmente non esiste in Etruria una netta contrapposizione cronologica tra
fase monarchica e fase repubblicana anche per un'altra ragione, e cioè perche la
monarchia, di nome oltre che di fatto (se le fonti non mentono), sopravvive o
riaffiora almeno in due casi posteriori a quella fase tardo-arcaica nella quale
dovrebbero collocarsi i mutamenti istituzionali più o meno nello stesso periodo
delle origini della repubblica romana. Ci riferiamo alla creazione di un re a
Veio sul finire del V secolo e alla menzione di un "redei Ceriti" nell'elogium
di Aulo Spurinna in un contesto cronologico che si riporta verso la metà del IV
secolo. Nell'uno come nell'altro caso c'è una palese ostilità di altri stati
etruschi, che farebbe pensare a fatti eccezionali in un mondo di ormai
prevalenti assuefazioni istituzionali repubblicane.
Il sistema che doveva
essersi generalizzato negli ultimi secoli di vita autonoma delle città etrusche
è, come si è detto, quello delle repubbliche oligarchiche, per la cui conoscenza
abbiamo purtroppo soltanto pochi indizi diretti offerti dalle iscrizioni e
qualche cenno delle fonti storiche, oltreche l'analogia con Roma. Possiamo
dedurne l'esistenza di un senato formato dai capi delle gentes; probabilmente di
assemblee popolari; di una magistratura suprema temporanea, unica o collegiale;
di altre magistrature collegiali a carattere politico e religioso. In ogni caso
si avverte la tendenza a spezzettare il potere, a sminuirlo e a porlo sotto un
costante reciproco controllo, allo scopo di evitare l'affermarsi del potere
personale. Questo irrigidimento delle istituzioni oligarchiche sembra più
accentuato in Etruria che a Roma. Una differenza traspare anche nei riguardi dei
movimenti di rivendicazione pubblica delle classi inferiori, che in Etruria non
hanno generalmente la possibilità di inquadrarsi, come a Roma, in uno sviluppo
progressivo delle istituzioni verso l'avvento al potere della classe plebea; ma
si risolvono, a Volsinii, ad Arezzo e forse altrove, in parentesi di anarchia
popolare. Ciò non esclude tuttavia un progressivo assorbimento di elementi
extragentilizi nel sistema gentilizio specialmente nell'Etruria settentrionale
intorno al II secolo a.C., come si è già accennato: con loro probabile
conseguente accesso almeno ad alcune delle cariche pubbliche.
I titoli delle
magistrature etrusche, nelle loro forme originarie, ci sono noti dai cursus
honorum (cioè dalle elencazioni delle carriere) delle iscrizioni funerarie,
alcune delle quali dovevano esser redatte nella forma di veri e propri elogio
poetici del defunto, come ad esempio le iscrizioni romane degli Scipioni. Non è
facile tuttavia interpretare la natura delle cariche, i loro reciproci rapporti,
la differenza di dignità e la corrispondenza con le magistrature del mondo
latino ed italico. Il titolo più frequente è quello tratto dalla radice zii-, di
origine ancora oscura ed imprecisata (ma già presente a Caere almeno all'inizio
del V secolo), nelle forme zii, zil(a)c o zilx, zilat. Alle forme nominali
corrisponde un verbo zilx- o zilax- che significa «essere zilc o zilat». Già
sappiamo che zilat corrisponde in qualche caso al titolo romano praetor. È
indubbio che si tratta di un'alta carica, forse la più alta dello stato; ma
spesso il titolo appare accompagnato da specificazioni (zilat o zilx parxis;
zilc marunuxva; zilx cexanen) che possono indicare una specializzazione di
funzioni (cfr. il latino praetor peregrinus).
Un'altra carica importante,
che taluno considera il più alto grado di un supposto collegio di zilat, è
indicata dalla radice purt-, che non si è mancato di ricollegare con il titolo
di probabile origine preellenica noto anche nelle città greche dell'occidente e
forse da queste trasmesso alle città etrusche. Frequente è inoltre il titolo
maru, marniu, marunux, i cui richiami sacrali sono resi evidenti dalla sua
connessione cori il titolo sacerdotale cepen e da specificazioni, che contengono
i nomi degli dèi Paxa (Bacco) e Cafa. Appare anche in Umbria con il collegio dei
marones (e fu cognomen del mantovano Virgilio!). Si è supposto che corrisponda
al latino aedilis. Altre cariche amministrative o militari sono espresse dai
termini camfi, macstrev(c) (dal latino magister), ecc.
Trattando degli
ordinamenti dello stato etrusco un ultimo cenno dovrebbe esser fatto alle leggi
e al diritto. Ma purtroppo di questa materia noi possediamo nozioni
limitatissime ed incerte delle fonti letterarie antiche, essenzialmente
collegate con la disciplina etrusca e in particolare con i libri rituali. L
'ipotesi dell'esistenza di un ius terrae Etruriae, cioè di una legislazione
della proprietà terriera, sostenuta da S. Mazzarino, dove comunque sarebbe
nominato un ius Etruriae. L'estrema importanza della normativa riguardante i
confini (molti dei quali contrassegnati da cippi con la parola tular) sembra del
resto confermata anche da altri documenti. Ma siamo in ogni caso, sia per questa
materia civile come per il diritto penale, prevalentemente nella sfera del
sacro, cui si farà riferimento nel capitolo successivo.
Il
popolo
Sotto la classe padronale o gentilizia - la cui ricchezza si
era creata con l’agricoltura, il commercio, la pirateria - si formò col tempo, a
partire dal VII secolo, una sorta di ceto medio anch’esso composto da
agricoltori, artigiani mercanti (non pochi di costoro erano stranieri, che
prendevano fissa dimora nei centri dove li portavano i loro traffici e magari
sposavano donne del posto). Non è pur troppo facile ricostruire l’esistenza di
questa gente e di quella che stava al livello più basso della scala sociale, i
servi. È evidente che questi servi non costituivano un blocco omogeneo, e che
(erano fra loro differenze anche notevoli in relazione alle funzioni che
svolgevano. Certo erano molto numerosi. Le fonti di approvvigionamento del
personale servile furono dapprima le scorrerie piratesche, poi le guerre (i
prigionieri di guerra finivano, come è noto, in schiavitù): e va da sé che
schiavi erano i nati da genitori di condizione servile. Mercati di schiavi
c’erano poi dappertutto (alcuni internazionalmente noti), e c’erano trafficanti
specializzati che facevano soldi a palate trattando questa merce. I prezzi
variavano naturalmente secondo la qualità (caratteristiche etniche, nazionalità,
età, sesso, forza, bellezza, salute, conoscenza di arti e mestieri, cultura,
ecc.).
Pare che le case dei ricchi Etruschi pullulassero di schiavi, adibiti
alle più svariate funzioni, non di rado pretestuose. Fra gli schiavi che
servivano durante i banchetti, c’erano quelli che mischiavano nelle anfore il
vino e l’acqua, quelli che versavano le bevande nelle coppe, quelli che
tagliavano le carni, quelli che distribuivano i cibi, e così via. I servi erano,
come in tutte le società antiche, alla mercé dei padroni. In Etruria erano,
sembra, trattati un po’ più familiarmente e mitemente che a Roma, ma non
mancavano certo i padroni capricciosi e crudeli. Le punizioni - frustate per lo
più, ma si arrivava alla tortura e alla morte - erano all’ordine del giorno. Non
c’erano deterrenti legali contro padroni cattivi o addirittura sadici: si può
supporre tuttavia che valesse come freno la disapprovazione sociale. E poi gli
schiavi rappresentavano un patrimonio e strumenti di lavoro che si aveva
interesse a proteggere e a sfruttare. Lo spettro dei servi era l’ergastolo (il
lavoro cioè nelle miniere, nelle cave di marmo quando si cominciò a sfruttarle
sistematicamente, nelle paludi per opere di prosciugamento), che si svolgeva in
condizioni disumane. Con il costituirsi di grosse ricchezze terriere e
l’estendersi del latifondo si andarono spopolando le campagne. I contadini, che
già prima stentavano la vita, sfruttati e vessati dai proprietari, cercavano
scampo nei centri urbani. A sostituirli erano gli schiavi, che costavano meno
anche se il loro rendimento non era esaltante.
Come dappertutto, gli schiavi
in Etruria potevano emanciparsi, grazie al peculio che riuscivano ad accumulare
o semplicemente grazie ai meriti che acquisivano. L’affrancamento dipendeva
comunque dalla volontà del padrone, nei confronti del quale il liberto (lautni
com’era chiamato in lingua etrusca) conservava obblighi importanti. Il liberto
aggiungeva al suo nome il gentilizio del padrone, faceva pur sempre parte della
famiglia, ma aveva una vita propria, lavorava per sé, poteva sposare una libera
o un libero, arricchire, fare carriera.
Basandoci sulle testimonianze
figurative e letterarie possiamo farci un’idea di com’erano fisicamente gli
Etruschi. Con molta cautela, senza dimenticare il lavoro di idealizzazione degli
artisti e i loro modelli culturali: è dall’Asia Minore e dalla Grecia, per
esempio, che gli scultori avevano preso la fronte sfuggente, il naso dritto,
l’occhio a mandorla e quel sorriso particolarissimo che poi venne assunto a
simbolo dell’arte etrusca. Non parleremo quindi semplicisticamente di un “tipo
etrusco” sulla scorta di un famosissimo sarcofago di terracotta (metà del VI
secolo) proveniente da Cere (Cerveteri), su cui è rappresentata una coppia di
coniugi adagiati fianco a fianco sul letto del banchetto funebre, con un viso
lei da kore attica, lui tendente al triangolare, con occhi obliqui resici
familiari dall’arte egeica.
Catullo e Virgilio hanno parlato rispettivamente
di obesus etruscus e di pinguis tirrhenus, varando un’immagine degli Etruschi
goderecci e mangioni. che trova del resto qualche riscontro nella scultura,
soprattutto in tre sarcofaghi. Uno, proveniente da San Giuliano nei pressi di
Viterbo ci presenta sul coperchio una figura coricata sul dorso con un ventre
spropositato; un altro, di Tarquinia, mostra un vecchio dalle carni piene che
contrastano con guance e collo flaccidi e rugosi; il terzo, conservato nel Museo
di Firenze, ci presenta un panciutissimo individuo coronato di fiori (un
cavaliere, si direbbe dall’anello all’anulare della mano sinistra), dalla testa
semicalva e dagli occhi spalancati, che regge nella mano destra una coppa. Ma
possiamo considerare questi personaggi rappresentativi della media degli
Etruschi o piuttosto del ceto ricco, godereccio, infiacchito dal benessere e
dall’ozio? Prendendo in considerazione un centinaio di iscrizioni comprese fra
il 200 e il 50 a.C. sulle quali figurano le età dei defunti, gli studiosi hanno
ipotizzato (con qualche incertezza per la perdurante difficoltà a interpretare
alcuni numerali che vi compaiono) una durata media della vita degli Etruschi di
40,88 anni, non disprezzabile per i tempi, ma che non tiene conto della
mortalità infantile, allora elevatissima.
Gli Etruschi dovevano essere
piccoletti, se vogliamo credere agli scheletri (circa un metro e mezzo per le
donne, una decina di centimetri in più per gli uomini). Ma lo erano anche i
Romani e molti popoli dell’epoca. Basta guardare nei musei armature ed elmi per
rendersene conto. Da quando si intensificarono i contatti con i Greci, gli
Etruschi si ispirarono alla loro moda per l’abbigliamento, che ci appare nei
documenti figurativi nel complesso piuttosto vivace ed elegante (poche
informazioni ricaviamo dagli autori romani, e solo per gli aspetti
dell’abbigliamento che Roma importò dall’Etruria). È ovviamente difficile
distinguere l’abbigliamento di tutti i giorni da quello festivo e cerimoniale.
Gli uomini, specie i giovani, stavano spesso seminudi, in casa soprattutto ma
anche fuori, accontentandosi del perizoma, un panno annodato intorno ai fianchi
a formare come delle braghette. Oppure mettevano un giubbetto. Le persone mature
indossavano più spesso la tunica leggera lunga fino ai piedi, pieghettata e
ricamata, e quando faceva freddo il mantello di stoffa pesante e colorata. Le
donne si sbizzarrivano di più: tuniche, gonne, corpini, giubbetti, casacche,
mantelli colorati ricamati. Soprattutto le gonne colpiscono per loro grazia, con
le loro pieghettature, increspature, inamidature, e con le forme svasate che
lasciano sospettare cerchi di sostegno. Tutti questi capi di vestiario subirono
una evoluzione le cui tappe non è sempre possibile precisare. Alla metà circa
del VI secolo risale, per esempio, l’introduzione del chitone di lino, indumento
decisamente unisex, anche in una versione corta al ginocchio (più tardi, in
epoca ellenistica, si impose fra gli eleganti il chitone attillato con cintura).
Vivace fu anche l’evoluzione del mantello: quello classico, di derivazione
greca, era rettangolare, ma andò molto di moda anche uno semicircolare che si
portava di traverso lasciando una spalla scoperta. Uno dei capi di vestiario più
famosi e di più lunga vita è il tebennos. che possiamo ammirare su delle piastre
di terracotta provenienti da Cere e conservate nel Louvre (VI secolo): vi è
raffigurato un re seduto su una sedia curule che indossa sopra una corta tunica
bianca orlata di rosso un mantello purpureo che gli lascia scoperta la spalla
destra. Adottato a Roma dai sacerdoti e dai militari, il tebennos evolvette
nella toga.
Nella tomba bolognese degli Ori si è trovato un tintinnabulum di
bronzo su cui sono raffigurate fasi della lavorazione dei tessuti (cardatura
filatura tessitura). Le fibre più usate erano la lana e il lino. Gli Etruschi
amavano i colori intensi e le decorazioni, incorporate o applicate. Ai piedi
sandali con suole leggere e cinghie incrociate (ce n’erano con suole di legno
anche molto alte, montature metalliche e lacci dorati; altri, semplicissimi,
avevano suole di legno basse, fasce a semicerchio e un cordone fra l’alluce e le
altre dita). C’erano zoccoli, c’erano stivaletti del tipo che oggi diremmo alla
polacca. Derivarono da calzature etrusche gli stivali indossati dai senatori
romani (calcei senatorii), con linguette e corregge, che vedono in molte statue
romane ma già nella statua dell’Arringatore. Le più tipiche calzature etrusche
erano però quelle che i Romani chiamarono calcei repandi, babbucce curve e
colorate, forse di panno, con le punte volte in su e la parte posteriore anche
molto rialzata. Sta di fatto che i calzolai etruschi godevano di gran fama anche
fuori del paese. I copricapi erano molto in uso in Etruria, più che in Grecia
dove si andava prevalentemente a testa scoperta. Ne conosciamo alcuni: a larghe
falde adatti a proteggere dalle intemperie, ad ampia tesa con la parte superiore
conica (qualcosa di simile al sombrero). E poi berretti, di lana e pelle. Risale
all’età arcaica il cappello conico femminile chiamato tutulus, nome un po’
impreciso, applicato anche a un berretto di lana degli auguri e a una
pettinatura femminile (capelli avvolti intorno a un nastro). Per le donne tutta
la gamma, in pratica, delle pettinature odierne - nodi, trecce, chignons,
riccioli - e dei marchingegni per tenerle insieme (reti, spil loni e così via).
Farsi i capelli biondi faceva fino.
Sempre dai Greci gli uomini presero
l’abitudine della barba rasa e dei capelli corti. Chi poteva permetterselo si
adornava con ogni sorta di gioielli e monili (spille, diademi, collane,
pettorali, bracciali, braccialetti, anelli ciondoli). In guerra gli uomini si
vestivano e armavano come quelli degli altri paesi. Le armi erano lance,
giavellotti, spade lunghe e corte, sciabole ricurve, pugnali, asce (magari a
doppio taglio), mazze, archi, fionde. Per proteggersi elmi e scudi di varia
forma, corazze (dapprima in tela con borchie bronzee tonde o quadrate, poi
interamente in bronzo), schinieri. Un periodo cruciale dell’evoluzione
dell’armamento fu il VI secolo, con il passaggio dalla tecnica di combattimento
di tipo eroico (corpo a corpo) a quella che implicava l’uso di masse (fanteria
oplitica e cavalleria). I modelli greci allora prevalsero nettamente su quelli
centroeuropei: elmo conico di tipo ionico o calcidese: scudo rotondo in lamina
bronzea; schinieri di bronzo a proteggere le gambe spadoni di ferro a
scimitarra. Nei secoli successivi la tecnica di combattimento della falange e
della cavalleria si consolidò, e le armi si perfezionarono: si diffuse l’elmo a
calotta con paranuca e paraguance, le corazze adottarono la forma anatomica e
gli spallacci (bretelle), lo scudo mantenne la forma rotonda ma aumentò di
dimensioni.
Quanto al carattere degli Etruschi, non possiamo non registrare
le testimonianze degli antichi scrittori, tenendo però presente l’invidia che la
potenza e il benessere degli Etruschi potevano suscitare e lo sconcerto
suscitato da alcuni aspetti singolarmente liberi e spregiudicati del loro
costume. Li si considerava, e probabilmente erano, crudeli: ma la crudeltà era
di casa nel mondo antico. Certo non contribuivano a migliorare la fama degli
Etruschi, sotto questo profilo, l’avere essi esercitato su larga scala e molto
fruttuosamente la pirateria e fatti come quello che abbiamo riferito, la
lapidazione in massa dei Focesi catturati nella battaglia di Alalia. Virgilio
dice peste del re di Cere, Mesenzio, che si divertiva a legare faccia contro
faccia uomini vivi a cadaveri lasciandoli morire nel fetore e nella putredine.
Crudeltà insomma spinta al sadismo. Oltre che crudeli, gli Etruschi erano
accusati in antico d’essere goderecci, lussuriosi, ghiottoni. Una delle fonti
più citate in questo senso è Teopompo (IV secolo a.C.) - riportato da Ateneo
(II-III secolo d.C.) nel suo Dipnosofisti - considerato peraltro anche
anticamente una solenne malalingua. Ciò che sembra particolarmente colpirlo è la
condotta delle donne, liberissima.
Avevano grande cura del corpo, sfoggiavano
seminudità o nudità, bevevano a più non posso. Quanto agli uomini, erano
donnaioli sfrenati e accettavano la promiscuità sessuale, non disdegnavano i
ragazzetti, facevano l’amore in pubblico senza pensarci due volte, si
depilavano. Il filosofo Posidonio di Apamea (II secolo a.C.) - riportato da
Diodoro Siculo (I secolo d.c.) nella sua Biblioteca storica - dà un giudizio
degli Etruschi un po’ più equilibrato. Anch’egli tuttavia parla di lusso
eccessivo e di mollezza di costumi: si fanno imbandire due volte al giorno
tavole sontuose, si fanno servire da nugoli di schiavi, alcuni bellissimi e
vestiti con sconveniente eleganza. Questo infiacchimento dei costumi è secondo
Teopompo imputabile alla illimitata feracità del territorio etrusco. È da
Posidonio che apprendiamo l’origine etrusca della tromba (detta “tirrenica”),
del fascio littorio, della sedia d’avorio, della toga con orlo purpureo, e la
perizia degli Etruschi nelle scienze naturali e nella teologia. La famiglia
etrusca non differiva sostanzialmente dalla romana e dalla greca (più simile
semmai alla romana per l’indiscussa autorità del pater familias), tranne per la
posizione delle donne. Era questo che stupiva e scandalizzava (abbiamo citato in
proposito Teopompo) le altre nazioni. Si desume, l’importanza maggiore delle
donne dal fatto che sempre nelle iscrizioni il loro nome è preceduto dal prenome
e per tutti, maschi e femmine, si dà non solo la paternità, ma la
maternità.
Certo è che le donne etrusche non stavano chiuse nel gineceo, la
loro virtù non era misurata solo sulla pudicizia, sulla bravura nell’accudire
alla casa e nel filare. Partecipavano a tutti gli aspetti della vita privata e
pubblica (ai banchetti, ai giochi, alle cerimonie), e attivamente alle carriere
dei mariti. Tito Livio racconta per esempio il ruolo che ebbe Tanaquilla, donna
di nobile famiglia, nella fortuna del marito Lucumone (figlio di un greco
immigrato). Lucumone divenne, niente meno, re di Roma, con il nome di Lucio
Tarquinio Prisco. Ma ancora dopo la morte di Tarquinio, Tanaquilla ebbe parte
determinante nell’elezione a re del proprio genero, Servio Tullio. Un’altra di
queste donne energiche e influenti, Urgulanilla, moglie di un certo Plauzio di
cui non sappiamo nulla, frequentò la corte di Augusto sfruttando la grande
amicizia con l’imperatrice Livia. Una sua nipote sposò un nipote di Livia,
Claudio, un giovane infelice (miisellus lo definiva preoccupato l’imperatore),
considerato più o meno l’idiota della famiglia. Questo misellus però mise a
frutto i rapporti che grazie al matrimonio stabilì con l’ambiente
dell’aristocrazia etrusca, ebbe accesso agli archivi di molte famiglie
importanti, e divenne, oltre che imperatore, un valente etruscologo. Se ci fosse
rimasta la sua storia degli Etruschi in venti libri - purtroppo andata perduta -
il mondo etrusco presenterebbe per noi molti meno misteri.
Le classi sociali
Agli albori della storia di questo popolo, nel
periodo Protovillanoviano (età del Bronzo) e nel successivo Villanoviano
iniziale (età del Ferro), non si notano segni di una distinzione in classi
all’interno della società; essa invece appare evidente nel Villanoviano evoluto,
nella seconda metà dell’VIII secolo a.C., quando i corredi funerari cominciano a
mostrare netti segni di differenziazione: aumentano gli oggetti di corredo in
quantità e qualità, appaiono vasi ed ornamenti d’importazione. Qualcosa è
cambiato nella società etrusca e lo si vedrà amplificato alla fine dell’VIII
secolo a.C. e nel successivo, quando appare lo splendore della società
Orientalizzante, con all’apice le ricche aristocrazie dalle grandi tombe a
tumulo e dai sontuosi corredi, che basavano il proprio potere e prestigio sul
controllo dei commerci con l’Oriente e delle attività agricole e
pastorali.
La nascita di un ceto “medio” avviene nel’età Arcaica, nel VI
secolo a.C., quando artigiani e mercanti iniziano a prendere coscienza delle
proprie capacità, operando per proprio conto e non più per i ricchi principi.
Fanno parte della stratificazione sociale anche i lautni, gli schiavi, importati
come merce da paesi lontani o catturati durante le numerose battaglie per il
predominio sul commercio tirrenico: a volte si rinvengono i luoghi di sepoltura
di questi esponenti della classe servile, cremati e posti in recipienti di
terracotta, tumulati in piccole nicchie scavate nelle strutture sepolcrali dei
padroni.
La classe sacerdotale
Il ruolo della
classe sacerdotale comincia a definirsi più chiaramente nella città-stato
etrusca a partire dal VI sec. a.C. Attributo distintivo del sacerdote era il
lituo, un bastone di piccole dimensioni e ricurvo a un' estremità, del quale si
ha testimonianza fin dalla prima metà del VI sec. a.C. Si tratta di un'insegna
già conosciuta dagli storici degli Annales: l'augure che accompagnò a Roma il re
Numa Pompilio stringeva nella mano destra, secondo la descrizione che ne viene
fatta, proprio questo "bastone". Personaggi così raffigurati si trovano di
frequente in Etruria a cominciare dalla fine del VI sec. a.C., riprodotti sia in
bronzetti votivi che sulle stele funerarie. Nelle lastre architettoniche della
"dimora" di Murlo (SI) il lituo è un attributo distintivo del capo-signore, che
evidentemente era investito - oltre che del potere politico- anche di quello
religioso.
Possiamo formulare l'ipotesi che questo nuovo "ceto sociale"
(sacerdotale) sia venuto fonnandosi nelle città quando il potere del "re"
cominciava a sgretolarsi, come diretta emanazione quindi della classe
aristocratica. Possiamo inoltre supporre che, col tempo, si sia costituita anche
una gerarchia all'interno del sacerdozio. Nel III sec. a.C. compare una serie di
monete che recano, sul diritto, l'immagine di una testa di aruspice (netsvis)
con berretto conico (tùtulus) e, sul rovescio, la scure e il coltello, ossia gli
strumenti sacrificali. I sacerdoti addetti al culto erano chiamati cepen: è
probabile che fra di loro vi fosse una gerarchia dotata di cariche specifiche
(spurana cepen: sacerdote pubblico). Come a Roma i sacerdoti erano depositari di
varie fonne di scienza, così presumibilmente accadeva anche per quelli etruschi.
Sappiamo infatti da Censorino, erudito latino del III sec. d.C., che nei Libri
rituali era contenuta anche una dottrina specifica per il computo del tempo
(saecula) non solo degli esseri viventi, ma anche degli stati: il massimo tempo
concesso all'Etruria sarebbe stato di dieci saecula. Il numero di anni compreso
in un saeculum non era fisso, ma stabilito da prodigi spesso astronomici. La
ninfa Vegoia aveva profetizzato che nell'VIII secolo qualcuno, per avidità,
avrebbe cercato di aumentare i propri possedimenti; tale "secolo" sembrerebbe
corrispondere agli inizi del I sec. a.C.: i sacerdoti etruschi avrebbero dunque
previsto la fine dell'Etruria con poco margine di errore.
La famiglia
La struttura della famiglia etrusca non è dissimile
da quella delle società greca e romana. Era cioè composta dalla coppia maritale,
padre e madre, spesso conviventi con i figli ed i nipoti e, tale struttura è
riflessa dalla dislocazione dei letti e delle eventuali camere della maggior
parte delle tombe. Conosciamo alcuni gradi di parentela in lingua etrusca grazie
alle iscrizioni, come papa (nonno), ati nacna (nonna), clan (figlio), sec
(figlia), tusurhtir (sposi), puia (sposa), thuva (fratello) e papacs
(nipote).
La donna
Merita un cenno la condizione
sociale della donna che, a differenza del mondo latino e greco, godeva di una
maggiore considerazione e libertà: se per i latini la donna doveva essere
lanifica et domiseda, cioè seduta in casa a filare la lana, e su cui, nelle età
più antiche, il pater familias (il capofamiglia) aveva il diritto di morte
qualora fosse stata sorpresa a bere del vino, per gli Etruschi ella poteva
partecipare persino ai banchetti conviviali, sdraiata sulla stessa kline (letto)
del suo uomo, o assistere ai giochi sportivi ed agli spettacoli. Questo era
scandaloso per i Romani che non esitarono a bollare questa eguaglianza come
indice di licenziosità e scarsa moralità da parte delle donne etrusche:
addirittura dire “etrusca” era sinonimo di “prostituta”. Ma la condizione
sociale della donna nella civiltà etrusca era veramente unica nel panorama del
mondo mediterraneo, e forse ciò derivava dalla diversa stirpe dei popoli, pre
indoeuropei gli etruschi, indoeuropei latini e greci.
La donna poteva
trasmettere il proprio cognome ai figli, soprattutto nelle classi più elevate
della società. Nelle epigrafi talvolta il nome (oggi diremmo il cognome) della
donna appare preceduto da un prenome (il nome personale), segno del desiderio di
mostrarne l’individualità all’interno del gruppo familiare a differenza dei
Romani che ne ricordavano solo il nome della gens, della stirpe. Tra i nomi
propri di donna più frequenti troviamo Ati, Culni, Fasti, Larthia, Ramtha,
Tanaquilla, Veilia, Velia, Velka, i cui nomi appaiono incisi sul vasellame
migliore di casa od accanto alle pitture funerarie.
Le
Attività
L’alimentazione
La cucina etrusca
Il vino
Fornelli,
stoviglie e altri utensili per cucina
La filatura e la tessitura
Aspetti
della vita, economia e tecnica
Le armi e l’abbigliamento
La
medicina
L’alimentazione
Le fonti letterarie
conservateci che trattino questi soggetti risultano davvero scarse; le notizie
che abbiamo ci sono infatti riportate da autori greci e latini, i quali -colpiti
in modo negativo dal "lusso" dell'aristocrazia etrusca - non possono
considerarsi una fonte attendibile, anche perche risultano di molto posteriori
al periodo di fioritura della civiltà etrusca. Posidonio di Apamea, per esempio,
racconta che gli Etruschi apparecchiavano le loro tavole "ben" due volte al
giorno: del resto, anche i Greci consumavano due pasti al giorno, ma il pranzo
era molto frugale. Il dato archeologico, che in genere è così importante, nel
caso dell'alimentazione non è direttamente determinante; infatti, solo
recentemente gli scavi degli abitati sono stati affiancati da indagini
paleonutrizionali; oltre a ciò, relativamente rari risultano gli avanzi di pasto
rinvenuti. Comunque utili notizie possono essere dedotte dagli utensili
ritrovati negli ambienti adibiti a cucina, ma soprattutto dagli affreschi che
decorano le pareti di alcune tombe, soprattutto quelli della "Tomba Golini I" di
Orvieto, che mostrano immagini relative alla preparazione del banchetto.
Da
un famoso brano dello storico Tito Livio (Historiae XXXVIII, 45) sappiamo che in
Etruria si coltivavano copiosissime messi (in particolare grano e farro); esse
dovevano costituire l'alimento-base sulla mensa di tutti i giorni, sia sotto
forma di pani e focacce, che di minestre e zuppe. Dalla citata notizia di Livio,
inoltre, possiamo indurre che i bovini fossero allevati non solo per la carne,
ma anche perche necessari per il lavoro dei campi, soprattutto per l'aratura.
Gli avanzi di pasto rinvenuti durante gli scavi ci testimoniano, d'altra parte,
la presenza sulla tavola etrusca di altri animali domestici quali ovini, caprini
e suini, in proporzioni diverse a seconda del tempo o luogo in cui ci si
trovasse; altra fonte di alimentazione, inoltre, era la selvaggina, come ci
testimoniano gli autori antichi e alcuni famosi affreschi (la citata "Tomba
Golini I" di Orvieto o la "Tomba della Caccia e della Pesca" di Tarquinia). Per
quanto riguarda l'alimentazione ittica, ancora più rari risultano (dalla ricerca
archeologica) gli avanzi di pasto, a causa della deperibilità degli scheletri
dei pesci e del guscio dei molluschi; rimangono, comunque, come testimonianza
archeologica, ami da pesca, aghi e pesi da rete. Gli Etruschi dovevano conoscere
diverse varietà ittiche diffuse nel Mediterraneo, come mostrano i cosiddetti
"piatti da pesce" in cui appaiono raffigurate, sulla superficie esterna,
numerose specie manne.
L’alimentazione del mondo mediterraneo antico è
condizionata, ovviamente, dai prodotti che la natura offre e le condizioni
climatiche simili nel mondo greco, latino ed etrusco, hanno generato una dieta
ed una cucina per molti versi assai simili tra loro. Per l’età preistorica si
hanno dati scientificamente molto interessanti per il villaggio del Gran Carro
di Bolsena, scoperto sotto le acque del bacino lacustre e databile attorno al IX
secolo a.C, nella fase di passaggio dunque tra l’età del Bronzo e l’età del
Ferro.
Il setacciamento dei fanghi che ricoprivano le antiche strutture,
eseguito nel 1974, portò alla luce una rilevante quantità di noccioli di frutta
selvatica tra cui corniolo (Cornus mas), prugna selvatica (Prunus spinosa) e
prugna damascena (Prunus insititia), nocciolo (Corylus avellana) e ghiande
(Quercus sp.), ed anche vite (Vitis vinifera) che presto, grazie alle conoscenze
trasmesse dai navigatori provenienti dall’Egeo, sarebbe stata trasformata in
vino e non consumata solo come frutta. Tra i cereali sono presenti cariossidi di
farro (Triticum dicoccum), tra i legumi resti di fave (Vicia faba). I cereali ed
i legumi potevano essere consumati abbrustoliti o macinati per farne frittelle e
minestre; la frutta poteva essere consumata fresca o fermentata in bevande a
scarso tenore alcolico. Tra i resti faunistici (scavi 1980) ricordiamo la
presenza di numerose specie domestiche (68 % del totale dei resti ossei
rinvenuti) e selvatiche (32 %). Sono stati segnalati resti di caprovini, suini,
bovini, equini, cani; tra i selvatici cervo, cinghiale, capriolo ed orso
bruno.
I dati disponibili dagli scavi condotti dall’Istituto Svedese di Roma
a San Giovenale (Blera) abbracciano un arco cronologico molto ampio che va
dall’età del Bronzo all’età romana: essi rivelano come attraverso i secoli il
principale alimento siano stati i suini, gli ovini ed i bovini, talvolta
integrati da esemplari cacciati come il cervo, il capriolo e la lepre. Se
cerchiamo analogie con il mondo romano di cui si possiedono numerose notizie in
più rispetto all’etrusco, apprendiamo che si tendeva al consumo soprattutto di
suini, mentre i caprovini erano destinati alla produzione di latte e lana, i
bovini al lavoro nei campi. La carne era arrostita su lunghi spiedi (in greco
obeloi) che, in epoche premonetali, cioè quando ancora non si usavano monete e
si ricorreva allo scambio di prodotti e di metalli a peso, costituivano nel
Mediterraneo un elemento di scambi assai frequente. Ma poteva essere anche
bollita in grandi calderoni da cui veniva estratta con uncini.
A San
Giovenale sono stati rinvenuti fornelli e pentole di terracotta che testimoniano
la quotidiana vita dell’abitato: molti dei materiali archeologici provenienti
soprattutto dagli abitati arcaici della Tuscia (San Giovenale ed Acquarossa)
sono esposti in un'interessantissima mostra permanente presso il Museo
Archeologico Nazionale di Viterbo (Rocca Albornoz). Lo scavo di un insediamento
agricolo etrusco del IV - III secolo a.C. condotto dalla Soprintendenza
Archeologica per l’Etruria Meridionale a Blera in località Le Pozze (scavi
1986-87), ha permesso il rinvenimento di 570 semi e noccioli di frutta, tra cui
segnaliamo corniolo, nocciolo, ghiande di quercia, olivo (Olea europaea), vite,
fico (Ficus carica), pero (Pyrus sp.) ed orzo (Hordeum sp.). Tra i resti di
animali, presenti i suini, la capra, i bovini, le galline. Indagini
paleonutrizionali, cioè sulle modalità alimentari del passato, condotte sulla
popolazione etrusca, hanno rivelato che dal VII secolo a.C. all’età romana
l’economia alimentare sia rimasta a base agricola; un consumo maggiore di carne
e latticini, rilevabile dall’aumento di Zinco nelle ossa, si ha nell’età arcaica
(VI secolo a.C.-inizio V secolo a.C.): con il passaggio all’età classica ed
all’ellenistica si nota una graduale diminuizione del consumo di prodotti di
origine animale, forse conseguenza di quella forte crisi economica che avrà il
suo inizio nel V secolo a.C. e che si protrarrà con la conquista
romana.
La cucina etrusca
Le raffigurazioni
pittoriche della tomba Golini I di Orvieto (l'antica Volsinii) databili alla
seconda metà del IV secolo a.C., ci offrono una visione interessante delle
attività di cucina di un'importante famiglia dell'aristocrazia: sulle pareti
sono rappresentati i servi che fanno a pezzi la carne con una piccola ascia,
altri che preparano i cibi sotto lo sguardo attento di una donna: preparano
focacce, cuociono le cibarie nel forno, mesciono le bevande nelle brocche. Nelle
altre pareti appaiono i loro padroni, seduti o sdraiati sulle klinai, i letti
tricliniari del banchetto, in compagnia delle proprie donne dalle ricche vesti,
illuminati da alti candelieri di bronzo lucente, serviti da schiavi nudi ed
allietati da suonatori di lira e tibicines (flauti doppi).
Ma cosa si
mangiava nell'antica Etruria? Oltre alla frutta e verdura di cui abbiamo fatto
cenno, quali erano le pietanze, i cibi preparati ? Nei tempi più antichi erano
frequenti le minestre di cereali e legumi, come le gustose zuppe di verdura: ne
è un ricordo eccezionale l'acquacotta, uno dei piatti della tradizione culinaria
viterbese. Le sfarinate di cereali erano utilizzate per fare frittelle e
focacce. La carne era bollita ed arrostita: sono frequenti nei corredi delle
tombe gli alari, gli spiedi e le pinze per maneggiare i tizzoni di brace.
Condimento ideale per ogni cibo era l'olio d'oliva, di qualità eccellente,
esportato in tutto il Mediterraneo come testimonia il rinvenimento di anfore
etrusche: anche oggi la qualità dell’olio viterbese lo denota come prodotto
tipico, così come il vino. La mancanza di una letteratura specifica non ci aiuta
nella conoscenza di ricette e preparazioni tipiche, lontane dalla raffinata e
forse confusionaria cucina d’età romana: ma non è difficile immaginare che i
piatti più tipici della tradizione gastronomica toscana e viterbese, così legati
alla sana e semplice cultura contadina, siano il perpetuarsi della cucina
etrusca.
Il vino
Già nel VII secolo a.C. la vite e
l'olivo erano coltivati intensivamente in Etruria ma, per quest'ultimo, la
produzione non fu mai considerata importante dagli autori antichi; del vino
etrusco, invece (anche se in senso talvolta negativo), scrivono sia Orazio che
Marziale. Il vino bevuto nell'antichità era molto diverso da quello d'oggi:
denso, fortemente aromatico, ad elevata gradazione alcolica. Il primo mosto
ottenuto dalla vendemmia veniva in genere consumato subito, mentre il restante
veniva versato in contenitori di terracotta con le pareti interne coperte di
pece o di resina. Il liquido veniva lasciato riposare, schiumato per circa sei
mesi e a primavera, infine, poteva essere filtrato e versato nelle anfore da
trasporto. Il liquido così ottenuto non veniva bevuto schietto ma mescolato,
all'interno di crateri, con acqua e miele, e travasato nelle coppe dei
cornrnensali, servendosi di attingitoi e sìmpula. Sulla mensa, il vino era
contenuto in brocche e vasi a doppia ansa (stàmnoi), mentre per l'acqua si
utilizzavano spesso piccoli secchi, denominati sìtule.
Non potevano mancare,
in una cucina ben attrezzata, i colini. Questi instrumenta sono presenti in
tutta l'area mediterranea, dall'Egeo alla Gallia Meridionale, a iniziare dal VI
secolo a.C. fino all'età romana imperiale. Gli esemplari più antichi (II
millennio a.C.) sono stati trovati in Grecia, nell' isola cicladica di
Santorino, realizzati in terracotta. Potevano essere ottenuti anche in altro
materiale (argento, bronzo, rame, ceramica) e diverse risultano le varianti
della forma a seconda dell'uso. Alcuni colini appaiono provvisti di un imbuto
(nome latino infundìbulum), collegato al colino stesso, altri ne sono privi,
altri infine si denotano semplicemente per un "bulbo" ricavato al centro della
vasca. Alcuni di essi rivelano, sul lato opposto al manico, un sostegno
rettangolare orizzontale destinato a reggere il colino stesso sull'imboccatura
del vaso in cui veniva versato il liquido; in un secondo momento, il colum
poteva essere lasciato appeso all'orlo del recipiente, pure tramite questa sorta
di gancio. I colini provvisti di imbuto venivano usati per filtrare il vino e
altri liquidi in tipi di recipiente contraddistinti da strette
imboccature.
Fornelli, stoviglie e altri utensili per
cucina
Gli Etruschi, di solito, non avevano, all'interno delle loro
abitazioni, un vano adibito a cucina quale lo intendiamo oggi; spesso si cuoceva
all'aperto, ma comunque esistevano sistemi di cottura che utilizzavano dei
particolari "fornelli". Ne esistono sostanzialmente di tre tipi, provvisti
ognuno di relative varianti: il tipo più antico è di forma cilindrica e munito
sulla superficie superiore di una piastra forata e, sulla parte inferiore, di
un' apertura per l'alimentazione del fuoco; verso la fine del VII sec. a.C.
compare un secondo fornello semicilindrico, a forma di ferro d cavallo, con tre
parti sporgenti verso l'interno per sostenere la pentola; c’è infine un ultimo
modello, simile a una piccola botte aperta per appoggiarvi il recipiente per la
cottura e, in quella inferiore, per il carico del combustibile.
Il secondo
tipo era già conosciuto nella Magna Grecia e doveva risultare migliore del primo
modello, in quanto permetteva una cottura più veloce. In diverse zone
dell'Etruria, per esempio a Poggio Civitate, Murlo (SI), sono state trovate
specie di campane di terracotta provviste di un 'ansa alla sommità, sotto le
quali venivano posti i cibi da cuocere; intorno veniva messa la brace per
consentire la cottura, simile dunque a quella sub testo dei Romani. Altri
utensili per cuocere i cibi sono gli spiedi (in greco obelòi), usati per
arrostire la carne. Li troviamo talvolta conservati nelle tombe, forgiati in
bronzo o ferro, lunghi anche 1 m e associati a graffioni. Quest’ultimo tipo di
strumento ha più volte attirato l’attenzione degli studiosi, che hanno tentato
di definirne l'uso. Prevalgono oggi due interpretazioni: la prima tende a
identificare questo oggetto con un porta-fiaccole, i cui rebbi sarebbero stati
destinati a sostenere materiale combustibile; la seconda, avvalorata anche da
fonti letterarie (strumenti simili sono infatti descritti, con tale uso, dalle
testimonianze romane, contraddistinti dal nome latinizzato di hàrpago), lo
considera un utensile domestico, anzi culinario, usato per infilzare e cuocere
pezzi di carne, recuperarli dai calderoni e togliere pietanze "dal fuoco". Nel
medioevo, per es., si usavano uncini per impedire che i cibi in cottura
venissero a galla.
Tra gli instrumenta domestica vanno anche annoverate le
"teglie" (simili nella forma alle odierne padelle), alcune del tipo monoansato,
in bronzo. Si tratta di utensili domestici adibiti a contenere i cibi in fase di
cottura e chiamati anche pàtere o bacinelle, di cui esistono diverse varianti a
seconda del modo in cui risultino forgiati orlo e ansa. La medesima classe di
recipiente si trova replicata, nel corso del III secolo a.C., nella cosiddetta
"Ceramica a Vernice Nera" di produzione volterrana, che ispira le sue fonne a
prototipi di vasi in metallo, ottenendo così contenitori a un costo inferiore di
quello raggiunto dagli originali. Un altro oggetto d'uso domestico che compare
tra le suppellettili da cucina è la grattugia, in genere ricavata in bronzo, ma
talvolta anche in metallo pregiato. Il termine latino ràdula è usato da
Columella (De re rust. XII, 15,5) per un oggetto che doveva servire a raschiare
la vecchia pegola dai vasi, prima di spalmarvela nuovamente. Non siamo certi,
tuttavia, che si tratti del medesimo oggetto, in quanto Columella non lo
descrive. Omero già la menziona (Iliade XI, 638), usata per grattugiare il
fonnaggio; era infatti usata per fare il kykèion, bevanda composta da vino
forte, orzo, miele e fonnaggio grattugiato, bevuta dagli eroi omerici. Non
sappiamo se anche gli Etruschi avessero una bevanda simile.
La filatura e la tessitura
A parte la preparazione e la cottura
dei cibi, le attività domestiche peculiari della donna etrusca (anche di elevato
ceto sociale) erano la filatura e la tessitura della lana e delle fibre vegetali
(lino). Già in epoca villanoviana, i corredi delle tombe femminili contengono
frequentemente rocchetti e fuseruole di ceramica e, talvolta, fusi di bronzo.
L'attività della tessitura, del resto, è documentata negli scavi degli abitati
da numerosi pesi da telaio, di norma realizzati in terracotta in forma
troncopiramidale, oppure costituiti da semplici ciottoli (il telaio vero e
proprio era invece interamente di legno). Alcune antiche scene figurate, per
esempio sul tintinnàbulo di bronzo di Bologna (VII sec. a.C.), riproducono le
diverse fasi di lavorazione delle fibre tessili, in particolare della lana. Dopo
essere stata cardata, cioè pulita e pettinata, quest'ultima veniva attorcigliata
in fili grezzi e poi filata con il fuso (in legno, osso o bronzo); il filo così
ottenuto, avvolto sui rocchetti, era quindi utilizzato per la tessitura,
eseguita per lo più mediante telai verticali, nei quali i fili erano tenuti in
tensione, a gruppi, dagli appositi pesi.
Aspetti della
vita, economia e tecnica
La ricostruzione della vita che si svolgeva
nelle case dei ricchi non presenta eccessive difficoltà. Si è già accennato alla
posizione della donna che partecipa ai conviti e alle feste con perfetta parità
di fronte all'uomo. In età arcaica le donne e gli uomini banchettano distesi
sullo stesso letto: ed è probabilmente a questa usanza che risale l'affermazione
di Aristotele (in Ateneo, 1,23 d) che “gli Etruschi mangiano insieme con le
donne giacendo sotto lo stesso manto”. Si è anche supposto che Aristotele si
riferisca ad una falsa interpretazione di alcuni sarcofagi sui quali appaiono i
due coniugi giacenti sotto un manto simbolo di nozze. La cerimonia nuziale
presso gli Etruschi comprendeva infatti il rito (conservato tuttora dagli Ebrei)
della copertura degli sposi con un velo: come attesta il rilievo, di non dubbia
interpretazione, di una umetta di Chiusi. Ma è possibile che l'uso del velo
esistesse in realtà anche per i letti conviviali. Si presume comunque che i
Greci, per un atteggiamento di incomprensione e di ostilità verso gli Etruschi
forse risalente ad antiche rivalità politiche, trovassero argomento di scandalo
nella libertà formale della donna etrusca, così diversa dalla segregazione della
donna greca almeno nel periodo classico: e fosse quindi facile e quasi naturale
attribuire alle etrusche i caratteri e il comportamento delle etère, le sole
donne che ad Atene partecipassero ai banchetti con gli uomini. Nascevano così e
si diffondevano - con quella facilità nell'accettare e ripetere notizie anche
incontrollate specialmente sui costumi dei "barbari", quasi come motivi
letterari, che è propria del mondo classico - le dicerie sulla scostumatezza
degli Etruschi, sulle quali insiste Ateneo (IV, 153 d; VII, 516 sgg.) e di cui
si fa eco perfino Plauto (Cistellaria, Il, 3, 20 sgg.). A partire dal V-IV
secolo le donne etrusche non partecipano più ai conviti distese sopra il letto
come gli uomini, ma sedute, secondo l'usanza che resterà poi stabilmente diffusa
nel mondo romano. Raffigurazioni di banchetti con più letti (generalmente tre,
donde il romano triclinio), come quelle delle tombe tarquiniesi dei Leopardi o
del Triclinio, ci presentano quadri pieni di naturalezza e di gioiosa
semplicità. Non mancano cqnviti all'uso greco, con la presenza di soli uomini,
culminanti anche in orge piuttosto sfrenate, con abbondanti libazioni e balli
(tomba delle Iscrizioni a Tarquinia). I banchetti solenni, come del resto anche
altre feste (giuochi, funerali, ecc.), sono regolarmente accompagnati dalla
musica e dalla danza. Le pitture della tomba Golini di Orvieto ci portano anche
nell 'interno delle cucine dove si preparano i cibi per il banchetto, anche con
la presenza del suono forse magico-propiziatorio di un suonatore di doppio
flauto.
Una notevole serie di rappresentazioni si riferisce a giochi e a
spettacoli (tombe tarquiniesi degli Auguri, delle Olimpiadi, delle Bighe, del
Letto Funebre, ecc., tombe dipinte e rilievi di Chiusi). È evidente che
l'influsso ellenico domina su questo aspetto della vita etrusca; ma si ha
l'impressione che il carattere agonistico e professionale dei giuochi e delle
gare greche tenda a trasformarsi nel mondo etrusco in un divertimento
spettacolare. Niente è più suggestivo ed interessante, a questo proposito, del
piccolo fregio della tomba delle Bighe a Tarquinia, nel quale il pittore ha
immaginato un grande campo sportivo o circo, visto spaccato secondo i due assi
lungo e corto, con l'arena e le tribune lignee sulle quali trovano posto gli
spettatori; nell'arena sono corridori con le bighe, cavalieri, coppie di
lottatori e pugilatori, un saltatore semplice e con l'asta, un corridore armato
(oplitodromo), giudici di gara ed altri personaggi vari; sulle tribune
spettatori dei due sessi s'interessano nel modo più vivace all'esito delle gare,
come mostra chiaramente la loro mimica concitata. Non è escluso che ad agoni
sportivi partecipassero anche i membri delle famiglie più illustri. Va ricordato
a tal proposito il gioco etrusco della Truia (ludus Troiae), che consisteva in
una gara di corsa a cavallo lungo una pista intricata in forma di labirinto:
esso è riprodotto nel graffito di un vaso etrusco arcaico e sappiamo che era
ancora in uso al principio dell'impero come esercizio della gioventù romana. A
gare equestri partecipavano assai probabilmente i giovani membri della stessa
nobile famiglia proprietaria della tomba tarquiniese delle Iscrizioni. Il
rapporto dei giochi agonistici con il mondo funerario è documentato, oltre che
dall'evidenza delle tombe, dal passo di Erodoto (I, 167) relativo alle cerimonie
espiatorie compiute dai Ceretani per il massacro dei prigionieri
focei.
Accanto agli spettacoli di natura agonistica debbono esser ricordati
anche quelli mimici, musicali, acrobatici e farseschi che erano specificamente
attribuiti ad attori etruschi ricordati con il nome di histriones o ludiones (la
forma etrusca corrispondente sarebbe tanasa(r), fhanasa) e che furono introdotti
a Roma dall'Etruria nel 364 a.C. come «ludi scenici» (Livio, VII, 2-3). Di fatto
esistono non poche testimonianze figurate di pitture, vasi dipinti. bronzetti,
che raffigurano personaggi in costumi particolari, talvolta mascherati, che
partecipano a vere e proprie rappresentazioni: le quali sembrano essere per
altro di carattere assai vario, dall'esibizione popolaresca di saltimbanchi ed
equilibristi (come nelle tombe dei Giocolieri di Tarquinia e della Scimmia di
Chiusi), a qualcosa che può ricordare il dramma satiresco e porsi al limite di
un'azione drammatica (ben diversa in ogni caso dal genere della tragedia di
imitazione greca, senza dubbi tardivo, di cui si è già fatto cenno). Va poi
ricordato un genere di giochi più cruento, nel quale è forse da riconoscere
un'anticipazione dei combattimenti gladiatorii, che del resto la tradizione
antica considerava di origine etrusca (Ateneo, IV, 153) e comunque provengono in
Roma dalla Campania anticamente etruschizzata. Può darsi che i giochi in
questione nascano dall'uso funerario, come attenuazione dei sacrifici umani che
in molte civiltà primitive accompagnano la morte di principi o di personaggi
illustri; giacche nella lotta cruenta è lasciata al più forte o al più abile dei
contendenti la possibilità di scampare alla propria sorte. Un combattimento di
tal genere sembra rappresentato nella tomba degli Auguri di Tarquinia: un
personaggio mascherato e barbato, designato con il nome fhersu (corrispondente
al latino persona, da maschera»), con un cappuccio, un giubbetto maculato ed un
feroce cane al guinzaglio, assale un avversario seminudo e con il capo avvolto
in un sacco e armato di una clava.
Quest'ultimo è presumibilmente un
condannato che lotta in condizioni di inferiorità; ma è anche possibile che egli
riesca a colpire il cane con la clava e abbia quindi alla sua mercè
l'assalitore. Sulla natura e sulla funzione del personaggio con cappuccio, barba
e giubbetto maculato - sicuramente un essere umano e non un dèmone come si
credette in passato - esistono tuttavia notevoli incertezze dal momento che egli
ritorna più volte altrove in figurazioni pittoriche (tombe del Pulcinella, delle
Olimpiadi, del Gallo, forse della Scimmia: un nano o un bambino) in
atteggiamenti o in contesti che nulla hanno a che vedere con la gara mortale
della tomba degli Auguri. Sembra veramente che si tratti piuttosto di una
caratterizzazione generica, e che possa addirittura parlarsi della più antica
«maschera» della storia dello spettacolo italiano. Passando ora a considerare i
problemi della vita economica e produttiva dell'Etruria antica, diremo che è da
supporre che in origine le risorse degli abitanti del paese fossero di natura
prevalentemente agricola e pastorale (a parte, ovviamente, la raccolta, la
caccia e la pesca); ma presto esse dovettero esser rivoluzionate, almeno in
alcune zone, dallo sfruttamento delle ricchezze minerarie, ed ulteriormente
integrate dall'attività dei traffici terrestri e marittimi.
Un quadro
sufficientemente esatto della produzione etrusca nell'ultima fase della storia
della nazione ci è offerto dal noto passo di Livio (XXVIII, 45) sui contributi
offerti a Roma dalle principali città etrusche annesse o federate per l'impresa
oltremarina di Scipione l'Africano durante la seconda guerra punica. Ecco
l'elenco delle prestazioni fatte secondo le principali risorse di ciascun
distretto in materie prime e prodotti:
Caere grano ed altri
viveri
Tarquinia tela per le vele delle navi
Roselle legname per la
costruzione delle navi e grano Populonia ferro
Chiusi legname e grano
Perugia legname e grano
Arezzo armi varie in grande quantità, utensili
e grano
Volterra scafi di navi e grano
Vediamo definirsi chiaramente
nelle zone meridionali e centrali i di- stretti agricoli (Caere, Roselle,
Chiusi, Perugia, Arezzo, Volterra), alcuni dei quali avvantaggiati anche dallo
sfruttamento dei residui grandi boschi, mentre Populonia appare esplicitamente
indicata come centro siderurgico ed Arezzo come città industriale. La zona
mineraria etrusca abbraccia prevalentemente i territori di Vetulonia (con le
colline metallifere) e di Populonia (con l'isola d'Elba); ma ad essa dobbiamo
aggiungere anche il massiccio dei Monti della Tolfa, dove si hanno tracce di
antiche miniere non più sfruttate. L 'estrazione dei metalli (rame, ferro, in
minor grado piombo e argento) da questi territori risale forse anche in parte
alla preistoria, ma fu praticata sistematicamente a partire dall'inizio dell'età
del ferro. La sua importanza per la storia dell'Etruria arcaica è grandissima e
in un certo senso determinante, come già sappiamo. Alla valorizzazione di queste
ricchezze naturali si ricollega presumibilmente lo sviluppo stesso delle città
tirreniche; mentre la minaccia e la pressione continua dei Greci sulle coste
dell'Etruria è un segno dell'importanza che si annetteva al possesso,
all'influenza o soltanto alla vicinanza delle zone minerarie. Non ci sono noti
gli aspetti tecnici dell'estrazione e della prima lavorazione dei minerali, se
non da pochi indizi di natura archeologica - quali gallerie scavate in alcune
località delle colline metallifere e strumenti in esse rinvenute, forni, scorie
della fusione del ferro nella zona di Populonia - e da poche notizie antiche,
dalle quali ricaviamo ad esempio che Populonia era il primo centro di fusione
del metallo grezzo estratto dalle miniere dell'Elba e luogo del suo smistamento
e diffusione, ma probabilmente non di lavorazione ulteriore.
La produzione
etrusca è in gran parte influenzata della ricchezza di metalli del territorio:
ce ne accorgiamo dalle armi, dagli strumenti, dalle suppellettili di bronzo e di
ferro che abbondano nelle tombe. Soprattutto notevoli sono le opere di
metallotecnica artistica trovate a Vetulonia, a Vulci, a Bisenzio, nei dintorni
di Perugia, a Cortona; la fonte di Livio già ricordata designa inoltre Arezzo
(da cui proviene la famosa Chimera). Il ferro e il bronzo etrusco erano anche
lavorati in Campania, donde probabilmente minerale grezzo e prodotti si
diffondevano verso il mondo greco (Diodoro Siculo, v, 13). In Grecia erano
rinomate le trombe etrusche di bronzo; un frammento di tripode del tipo di Vulci
si rinvenne sull'acropoli di Atenen. Non debbono essere trascurati altri aspetti
della produzione artigianale ed industriale, come la tessitura e la lavorazione
del cuoio, specialmente per le calzature che erano note e certo largamente
esportate nel mondo mediterraneo (Polluce, VII, 22, 86). La produzione corrente
di stoffe, oggetti lignei, ceramiche (e soltanto di queste ultime ci resta nel
nostro clima la totalità delle testimonianze, come già detto) fu inizialmente
limitata ad un circuito familiare o di villaggio. Gli scambi si estesero con il
progresso del lavoro artigianale specializzato e con la conseguente necessità di
reciproche acquisizioni tra ambienti e centri diversi. Si passò quindi ai
commerci esterni, terrestri e soprattutto marittimi, favoriti dalla domanda di
oggetti di lusso e di prestigio e dall'offerta delle maggiori fonti di
potenzialità economica, cioè dei metalli nell'ambito di una società
aristocratica. Ma nel periodo aureo dei grandi traffici internazionali, cioè in
età arcaica, la massa degli scambi avveniva, come già in precedenza accennato,
essenzialmente per baratto di merci. Pezzi di rame grezzo (aes rude) e poi
contrassegnato (aes signatum), come anche oggetti o spezzoni di oggetti
lavorati, specialmente asce, poterono costituirsi quali intermediari di scambio;
si aggiunga l'argento pesato secondo un piede ponderale originario del
Mediterraneo orientale (detto, impropriamente, «piede persiano», di circa grammi
5,70), che rimarrà poi tipico del sistema ponderale delle monete etrusche.
La coniazione di monete, che nel mondo greco risale al VII secolo, resterà
fondamentalmente estranea alla concezione dell'economia etrusca: ciò che può
considerarsi, se si vuole, un altro segno di primitivismo o di arcaismo. Di
fatto le monete greche circolarono precocemente, insieme con gli altri più rozzi
strumenti di scambio locali; e di esse si ebbe qualche imitazione, in oro
(dubitativamente) e argento, in età arcaica. Ma di una vera e propria
monetazione etrusca d'argento e d'oro non si può parlare se non a partire dalla
metà del V secolo (cioè nell'età della relativa recessione economica)
specialmente a Populonia, sotto l'influenza della monetazione greca dell'Italia
meridionale e seguendo i sistemi ponderali etrusco e calcidese. Di fatto è la
zona mineraria che sembra comporre in Etruria la moneta, per comprensibili
ragioni di accelerazione e moltiplicazione di scambio. Soltanto più tardi, e non
prima dell'affermarsi dell'egemonia romana alla fine del IV secolo, appariranno
monete di bronzo fuse (aes grave) e coniate.
Sappiamo che gli Etruschi
avevano una tecnica progredita nel campo della ricerca, dello sfruttamento, del
convogliamento delle acque. La ricerca delle acque era fatta dagli aquilices:
specie di rabdomanti. Plinio (Nat. Hist. ,III, 20, 120) parla dei canali scavati
dagli Etruschi nel basso Po: ed effettivamente in diverse zone dell'Etruria
tirrenica si riscontrano sistemi di cunicoli di drenaggio che risalgono all'età
preromana e dimostrano un'intensa applicazione di opere idrauliche a scopo di
bonifica e di irrigazione. La vita nelle zone paludose della maremma e del basso
Po non si spiegherebbe d'altro canto se fosse già stata diffusa, durante il
periodo aureo della civiltà etrusca, l'infezione malarica: la quale dovette
appunto cooperare, durante la tarda età ellenistica, ad affrettare la decadenza
di molte città etrusche costiere. Al denso manto boschivo che copriva tanta
parte dell'Etruria si suppone dovuto lo sviluppo di una tecnica che abbiamo
ragione di ritenere caratteristica del mondo etrusco (anche se le fonti
letterarie sono meno esplicite che per altre peculiarità): vogliamo dire l'arte
della lavorazione del legno per la grande carpenteria architettonica e per
l'ingegneria navale. Anche a questo proposito sarebbe errato trascurare i
precedenti orientali e greci. Ma la facilità della materia prima deve pure aver
avuto la sua importanza. In ogni caso le tombe scavate nella roccia ad
imitazione di interni di case, specialmente quelle della necropoli di Cerveteri,
suggeriscono le più varie e ardite soluzioni nell'impiego del legno per le
costruzioni, soppiantato solo tardivamente dalla pietra. Va però tenuto conto
della diffusione dei mattoni crudi nell'alzato delle pareti, in concomitanza con
gli elementi lignei dei pilastri, delle porte e delle coperture. Un altro
impiego fondamentale del legno è per le navi, da guerra ed onerarie, che
costituirono lo strumento della potenza commerciale e politica etrusca, e che
appaiono rappresentate in un grande numero di figurazioni di ogni età.
Significativo, a proposito della tecnica costruttiva, è il ricordo degli scafi
(interamenta) forniti da Volterra a Scipione come già si è visto, evidentemente
fabbricati in uno degli scali marittimi volterrani. Per le forme evidentemente,
come desumiamo dalle immagini, non ci si dovette scostare dai modelli greci;
leggendaria è la notizia dell'invenzione dei rostri da parte di un Piseo figlio
di Tirreno (Plinio, Nat. Hist.. VII, 56, 209); ma è curioso, ed unico nel suo
genere, il modello di nave con prora a testa di pesce dalle cui fauci fuoriesce
una lancia.
Le armi e l’abbigliamento
Immagini di guerrieri singoli e scene di parate, duelli e battaglie sono
frequentissime nei vasi e nei rilievi dell'Etruria arcaica. Insieme con le armi
reali superstiti essi costituiscono una vasta documentazione della guerra e
dell'armamento. Sull'arte etrusca della guerra assai poco si rileva dalla
tradizione, che tuttavia suggerisce che l'organizzazione militare primitiva. dei
Romani debba molto all'Etruria. Ma anche per questa materia - soprattutto ove si
considerino le testimonianze figurate - l'influenza della tattica e
dell'armamento dei Greci sembra essersi affermata in modo dominante soprattutto
per quel che riguarda la presenza della fanteria oplitica, cioè dei guerrieri
con armi pesanti, che costituì verisimilmente il nerbo dello stato cittadino
arcaico. In origine si combatteva sui carri, forse più a lungo che in Grecia, se
non c'inganna il carattere mitologico di molte figurazioni; comunque già a
partire dal VII secolo appare operante la cavalleria. Tutto ciò premesso, non
può trascurarsi l'esistenza di fenomeni che ricollegano il mondo etrusco
specialmente nella sua fase più antica a tipi di armamenti presenti piuttosto
nell'area europeo- continentale che in Grecia.
Armi offensive sono l'asta
pesante con la punta e il saurocter di bronzo o di ferro, l'asta leggera o
giavellotto, la spada lunga - il cui uso sembra cessare già in epoca arcaica, e
che è soltanto una sopravvivenza dell'armamento della tarda età del bronzo - ,
la spada corta o gladio, la sciabola ricurva (machaira) in uso a partire dal VI
secolo, il pugnale, l'ascia che in epoca antichissima è a due lame e, come già
si è accennato, appartiene forse all'armamento dei capi. Armi difensive sono
l'elmo di bronzo, lo scudo, la corazza, gli schinieri. Gli elmi primitivi hanno
una forma ad apice o a calotta sormontata da cresta, o a semplice calotta, o con
apice a bottone; assai per tempo si diffondono gli elmi di tipo greco corinzio.
Ma la forma classica di elmo etrusco di bronzo è una sorta di morione talvolta
sormontato da penne, di cui molti esemplari si sono rinvenuti nelle tombe
etrusche (tipico uno degli elmi apparsi tra gli oggetti votivi del santuario
ellenico di Olimpia, con l'iscrizione dedicatoria a Zeus del tiranno di Siracusa
Gerone che li dedicò come bottino di guerra dopo la vittoria navale dei Greci
sugli Etruschi presso Cuma nel 474 a.C.); con il termine moderno di elmo tipo
Negau lo si incontra, con varianti, diffuso largamente anche nell'Italia
adriatica e settentrionale e nell'area alpina e slovena. Le corazze erano in
origine di tela, con borchie rotonde o quadrangolari di metallo laminato; ma poi
furono lavorate interamente di bronzo, del tipo ad elementi staccati o tutte di
un pezzo riproducenti a sbalzo la muscolatura del tronco virile. Scudi rotondi
di bronzo appaiono così in epoca arcaica come nel periodo più recente; ma alcune
figurazioni ci rivelano anche forme di scudi ellittici o tendenti al quadrato,
probabilmente di legno o di cuoio. Un cenno va fatto ai bastoni offensivi e
difensivi, nei quali è forse da vedere un ricordo delle antiche clave usate
nelle culture primitive: di essi appare qualche testimonianza nei monumenti
arcaici, mentre il tipo del bastone ricurvo all'estremità, detto lituo, tende
successivamente a diventare in modo sempre più esclusivo un'insegna sacerdotale,
e come tale passa al mondo romano.
Per quel che riguarda l'abbigliamento
maschile e femminile e le acconciature, in mancanza di materiale direttamente
conservato, dobbiamo servirci essenzialmente dei monumenti figurati, del resto
abbondanti e ricchi di particolari. Naturalmente il clima influisce sul
vestiario non meno delle tradizioni locali; ma la moda dei prototipi diffusi dal
mondo greco ebbe anche in questo campo un'azione determinante. La consuetudine
prettamente mediterranea della seminudità maschile è ancora viva nell'Etruria
arcaica; le piccole figurazioni plastiche del periodo villanoviano ci mostrano
anzi addirittura numerosi esempi di nudità completa maschile e femminile, ma non
sappiamo fino a che punto essa risponda alla realtà della vita quotidiana
(nell'arte essa è assai meno frequente che in Grecia).
Comunque ancora in
piena civiltà del VI e V secolo gli uomini, specie nell'intimità domestica,
andavano a torso nudo; e quest'uso tradizionale si riflette nel costume "eroico"
del defunto banchettante delle figure scolpite sui coperchi dei sarcofagi e
delle urne di età ellenistica. Completamente nudi appaiono soltanto servi ed
atleti, ma neppur sempre. Un ampliamento dell'originario perizoma bordato che
copriva i fianchi è costituito dal giubbettino che riveste anche il petto, ed è
di moda negli ultimi anni del VI secolo. Ad esso poi si sostituirà la tunica,
imitata dal chitone dei Greci. Ma il secondo elemento tipico del costume
maschile è il manto di stoffa più pesante e colorata, già diffuso in epoca
arcaica. Con l'accrescersi dell'entità del vestiario il manto acquisterà un
'importanza sempre maggiore, fino ad aumentare di ampiezza e ad arricchirsi di
decorazioni dipinte o ricamate, diventando la veste nazionale degli Etruschi, la
tèbennos, dalla quale discende in via diretta la toga romana. Le donne e le
persone anziane vestono fin dai tempi arcaici una tunica in forma di camicia
lunga fino ai piedi di stoffa leggera pieghettata o decorata sui bordi, alla
quale si sovrappone il manto dipinto di stoffa più pesante. È da notare, per un
periodo che va dalla fine del VII al principio del V secolo, l'uso di stoffe con
un disegno a rete che si suppone lavorato a ricamo e che s'incontra sui
monumenti così nelle tuniche (statuetta di Caere al Campidoglio, vasi cinerari
chiusini) come nei mantelli (situla della Certosa).
Fin dall'epoca più antica
si osservano una cura ed un interesse particolare degli Etruschi per le
calzature. Le tombe arcaiche di Bisenzio hanno restituito sandali in forma di
zoccolo ligneo snodato con rinforzi di bronzo. I calzari potevano essere di
cuoio e di stoffa ricamata. La forma tipica in uso nel VI secolo è quella
allungata in alto dietro il polpaccio e con punta rialzata davanti, cioè i così
detti calcei repandi di origine greco-orientale, dei quali alcune caratteristi-
che sopravvivono ancora nelle ciocie dei montanari dell'Italia centrale. Anche
più tardi, accanto ai sandali bassi, sono in uso gli alti stivaletti: queste
diverse fogge passano, quasi senza mutamenti, al costume romano.
Sul capo era
portato nel VI secolo un tipo di berretto o sacchetto a cupola di stoffa
ricamata, comune così agli uomini come alle donne, e con diverse varianti, il
così detto tutulus, anch'esso di origine orientale, ionica, ma divenuto
caratteristico del costume etrusco; Altre forme di copricapi sono il berretto a
punta rigida o a cappuccio di alcuni speciali personaggi (ad esempio il già
citato persu della tomba degli Auguri), sacerdoti e divinità; il berretto di
lana o di pelle con base larga e punta cilindrica portato dagli aruspici ed
attestato in diversi monumenti; e infine il cappello a larghe falde alla greca
(pètasos) che sembra particolarmente diffuso nell'Etruria settentrionale (figure
di terracotta della decorazione architettonica di Poggio Civitate di Murlo,
flautista della tomba della Scimmia di Chiusi), come del resto nell'Italia del
nord (arte delle situle). Ma generalmente così gli uomini come le donne andavano
a capo scoperto; e questa è l'usanza che diviene predominante a partire dal V
secolo.
Dapprima gli uomini sono barbati e portano i capelli lunghi spioventi
sulle spalle; ma già dalla fine del VI secolo i giovani vanno rasi e con i
capelli corti, secondo la moda greca. La barba scompare quasi del tutto a
partire dal III secolo a.C. (e non tornerà di moda in Italia se non quattrocento
anni più tardi, ai tempi dell'imperatore Adriano). Le donne nei tempi più
antichi (VIII-VI secolo) recano i capelli lunghi pioventi a coda annodati o
intrecciati dietro le spalle: successivamente li lasciano cadere a boccoli sulle
spalle e infine (VI-V secolo) li annodano a corona sul capo o li raccolgono in
reticelle o cuffie. È notevole la probabile moda di sbiondire le chiome, che
parrebbe attestata dalle pitture della tomba dei Leopardi di Tarquinia. Nel IV
secolo prevale una pettinatura a riccioli cadenti ai lati del volto. Più tardi,
in piena età ellenistica, si preferisce il ciuffo annodato sulla nuca, alla
greca. Grande importanza nel costume etrusco hanno i gioielli. Alla fine
dell'età del bronzo si diffonde largamente per tutto il mondo mediterraneo l'uso
delle spille di sicurezza, le fibule, che sono fra gli oggetti più
caratteristici delle tombe dell'età del ferro. Quelle usate dagli uomini si
distinguono da quelle femminili per l'arco spezzato e serpeggiante. Le fibule si
confezionano generalmente di bronzo, ma anche di metalli preziosi e riccamente
adorne con pezzi di pasta vitrea e d'ambra: alcuni esemplari di età
orientalizzante, come la fibula aurea a disco della tomba Regolini-Galassi, sono
di proporzioni colossali e sfarzosamente decorate.
L'uso delle fibule si
attenua nel VI secolo e cessa quasi del tutto dopo il V: si conserva soltanto in
costumi tradizionali, come quello dei sacerdoti aruspici. Altri tipi di gioielli
sono i diademi, gli orecchini, le collane, i braccialetti, gli anelli. Nel
periodo orientalizzante lo sfarzo del loro impiego ha un aspetto barbarico: e lo
stesso si può dire per l'età ellenistica. Il solo periodo in cui i gioielli
furono impiegati dagli Etruschi, e specialmente dalle donne, con parsimoniosa
eleganza è la fase aurea del VI-V secolo: ad essa si attribuiscono magnifici
esemplari di collane con bulle o ghiande ed orecchini lavorati con la raffinata
tecnica della granulazione.
La medicina
La
perizia degli Etruschi nell'Arte Medica era celebre e gli antichi scrittori
Greci e Romani ne parlano soprattutto riguardo alla conoscenza delle proprietà
officinali delle piante. Per conoscere il grado di preparazione raggiunto dai
“medici” etruschi ci viene in aiuto l'Archeologia: il rinvenimento di numerosi
ex voto in terracotta o bronzo raffiguranti anche organi interni del corpo umano
denota chiaramente l’estrema abilità anatomica di questo popolo; così come la
presenza di numerosi ferri da chirurgo e da dentista nel corredo di alcune
tombe. Nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia è conservato un teschio
umano che reca una protesi dentaria in oro, prova dell’abilità dei dentisti.
Grande importanza avevano poi le acque termominerali, di cui la Tuscia è ancora
oggi ricchissima: gli Etruschi conoscevano bene le proprietà medicamentose di
ogni sorgente, sacra e dedicata a divinità diverse, così come i Romani i quali,
con la conquista di queste terre, eressero spesso grandi impianti termali
alimentati dalle preziose acque di queste sorgenti.
L'Arte
La letteratura
ed i libri
Le musiche e la danza
La scultura
La pittura
Finalità,
condizionamenti e tendenze
Arte profana
I monumenti architettonici
Il
problema dell' «arte etrusca»
La letteratura ed i
libri
Per molti aspetti la civiltà degli Etruschi, pur appartenendo ad
un'età pienamente storica, deve essere considerata e studiata alla stregua di
una civiltà preistorica, vale a dire essenzialmente nelle sue testimonianze
esteriori e materiali. Manca infatti la luce diretta di una grande tradizione
letteraria originale che ci consenta di penetrare profondamente nel pensiero,
nei sentimenti e nelle concezioni di vita di questo popolo, come invece è
possibile per altre genti del mondo classico. Le notizie indirette, collaterali
o tardive, che scrittori greci e romani ci hanno lasciato sull'Etruria antica e
gli stessi documenti scritti etruschi (che consistono per lo più di brevi
iscrizioni, non tutte facilmente interpretabili) offrono senza dubbio preziosi
elementi di informazione: lo si è visto a proposito dell'organizzazione
politico-sociale e della religione. Ma essi non possono in nessun modo
compensarci della mancanza di una letteratura nazionale con opere poetiche,
storiche, filosofiche, quali ci sono state conservate per la Grecia e per
Roma.
Ciò per altro non significa che gli Etruschi non abbiano avuto una loro
propria letteratura. Il fatto che essa non sia giunta fino a noi non è un
argomento valido per escluderla. Noi possediamo la letteratura greca e quella
latina quasi esclusivamente perche esse ci furono tramandate attraverso una
tradizione ininterrotta, di copista in copista, durante i secoli del medioevo (i
testi antichi su papiri dissotterrati dagli archeologi e i documenti epigrafici
hanno una importanza relativamente secondaria). Ma se le opere degli scrittori
classici furono copiate e trasmesse fino ai tempi moderni, ciò si deve al fatto
che esse erano scritte in lingue universalmente note e vive (a parte ogni altra
considerazione sull'importanza essenziale di queste opere per la costruzione
stessa della cultura del mondo occidentale). Viceversa gli scritti originali dei
popoli dell'ltalia preromana, tra cui gli Etruschi, avevano perduto ogni
interesse sin dall'età romana imperiale, essendo redatti in lingue non più
parlate e presumibilmente incomprensibili a tutti, fatta forse eccezione per
qualche erudito. È chiaro che a nessuno poteva venire in mente di ricopiarli e
conservarli per le generazioni future.
Una certa forma di attività letteraria
degli Etruschi è, in vero, testimoniata positivamente, per quanto in modo
indiretto, dal ricordo che ne sopravvive nelle fonti greco-latine. Si tratta di
notizie frammentarie che riguardano soprattutto I' esistenza di libri a
contenuto religioso, conosciuti attraverso traduzioni o compendi negli ambienti
sacerdotali ed eruditi romani. Sappiamo che essi erano classificati in tre
fondamentali raggruppamenti, sotto il nome di Libri Haruspicini, Libri
Fulgurales e Libri Rituales. I primi trattavano della divinazione mediante
l'esame delle viscere degli animali; i secondi contenevano la dottrina dei
fulmini. Quanto ai Libri Rituali, sembra che essi abbracciassero una materia
assai più vasta e complessa, riguardante le norme del culto, le modalità per la
consacrazione dei santuari, per la fondazione delle città, per la divisione dei
campi, gli ordinamenti civili e militari, ecc.; comprendevano inoltre scritti
speciali sulla divisione del tempo e sui limiti della vita degli uomini e dei
popoli (Libri Fatales), sul mondo dell'oltretomba e sui riti di salvazione
(Libri Acherontici) e infine sulla interpretazione dei prodigi (Ostentaria).
La tradizione etrusco-romana tende ad attribuire a queste opere una origine
antichissima e veneranda: tanto che una parte di esse era addirittura riferita
agli insegnamenti del genietto Tagete (Libri Tagetici: corrispondenti, per
quanto sappiamo, ai Libri Aruspicini e agli Acherontici) o a quelli della ninfa
Vego(n)ia o Begoe, cui si assegnavano i Libri Fulgurali e gli scritti di
agrimensura contenuti nei Libri Rituali. In sostanza si credeva in una loro
ispirazione divina, facendone risalire l'origine ad una specie di primordiale
"rivelazione" che si identificava con le origini stesse della civiltà etrusca. E
non è da escludere che la raccolta dei libri sacri, quale si conosceva neg.i
ultimi secoli della vita del popolo etrusco e quale fu, almeno parzialmente,
tradotta in latino, comprendesse elementi di formazione assai antica. Ma nel
complesso il carattere essenzialmente normativo degli scritti sembra riflettere
piuttosto una fase evoluta e forse finale dello sviluppo spirituale e religioso
della società etrusca. Si può immaginare che la loro elaborazione definitiva e,
per così dire, "canonica" abbia avuto luogo nell'ambito di ristrette cerchie
sacerdotali, come l'ordine dei sessanta aruspici fiorente ancora a Tarquinia in
età romana: un mondo al quale senza dubbio appartenne quel Tarquitius Priscus (o
Tuscus ?), al quale la tradizione romana attribuiva la composizione, la
volgarizzazione e la traduzione in latino di diversi libri sacri. Con questo
siamo portati a considerare la natura stessa della letteratura religiosa
etrusca. Essa aveva probabilmente un aspetto vario ed eterogeneo, con parti
poetiche o almeno redatte metricamente (carmina) ed altre minuziosamente rituali
e prescrittive: delle quali ultime è possibile formarsi direttamente un'idea
considerando testi originali etruschi superstiti, quali il manoscritto della
mummia di Zagabria o la tegola di Capua.
Si è già, anzi, accennato ad un'
eventuale connessione fra il rituale funerario di Capua e i Libri Acherontici.
Nel suo complesso il corpo dei libri sacri doveva avere una ispirazione
fondamentale religiosa, ma nello stesso tempo anche un certo carattere
giuridico. Era un trattato di dottrine sacrali e insieme una costituzione ed una
collezione di leggi, anche profane (ius Etruriae). Carattere del tutto
particolare, profetico e insieme etico-giuridico, ha il frammento di testo
tramandato dai gromatici latini con l'insegnamento della ninfa Vegoia (cioè la
Lasa Vecui) ad Arunte Veltimno (che sarà stato in etrusco un Arnth Veltimna,
presumibilmente di Chiusi o di Perugia), in cui si parla di punizioni per
appropriazioni di terre altrui mediante lo spostamento dei segnali di confine,
da parte di servi o anche con l'acquiescenza dei loro padroni: punizioni
consistenti nell'insorgere di morbi e in catastrofi naturali, minacciate verso
la fine dell'VIII secolo (naturalmente etrusco, che secondo attendibili computi
di altre fonti sarebbe da collocare nell'anno 88 a.C.). Il passo termina con
l'esortazione: Disciplinam pone in corde tuo (metti nel tuo cuore la
disciplina). Si suppone che lo scritto sia stato ispirato in età sillana da
ambienti conservatori etruschi di fronte al pericolo di riforme agrarie e di
sovvertimenti sociali.
Resta il problema se gli Etruschi abbiano avuto
altre forme di attività letteraria e sino a qual punto tali manifestazioni si
siano svolte in modo autonomo rispetto alla letteratura sacra. L'esistenza di
documenti annalistici o storici sembra accertata dal ricordo di Tuscae historiae
citate da Varrone (Censorino, de die nat., 17, 6). Mancano invece del tutto
riferimenti ad una narrativa epica o mitologica: pur non escludendosi la
possibilità che questo genere sia stato coltivato in Etruria, giova rilevare che
la mentalità degli Etruschi non sembra portata alla feconda inventiva
mitografica propria dei Greci. Salvo rare eccezioni, l'arte figurata imita e
rielabora soltanto le saghe divine ed eroiche accolte dal mondo greco. Che i
carmi conviviali e le satire fescennine (la cui origine si riportava alla città
falisca di Fescennio) avessero paralleli in Etruria è possibile, ma non
documentabile con certezza. Di elogi cantati in onore di personalità defunte
s'intravvedono invece riflessi in alcune iscrizioni funerarie più lunghe e forse
a struttura metrica o ritmica. La poesia drammatica, cui si riporta il ricordo
di una certo Volnio autore di tragedie etrusche, nasce probabilmente soltanto in
epoca tarda come imitazione del teatro greco.
Le musiche e
la danza
Si è più volte rilevata, nei testi etruschi, la presenza di
raggruppamenti regolari di parole e di sillabe, ripetizioni, allitterazioni,
rime, ecc. , che denunciano una forte disposizione alla forma ritmica. Non
abbiamo invece finora dati sicuri per la individuazione di una metrica
quantitativa, come nei versi greci e latini. Ma è in ogni caso assai probabile
che le iscrizioni dedicatorie, specialmente arcaiche, ed alcune iscrizioni
funerarie fossero verseggiate, come era uso frequente presso i Greci e i
Romani.
danzatrice etrusca Ovviamente metrici e cantati erano i carmi
sacri, inni o preghiere, e forse anche quelli di contenuto profano. La musica
accompagnata dal canto, ma specialmente quella senza canto, deve aver avuto
grandissima importanza nelle cerimonie e nella vita pubblica e privata degli
Etruschi, a giudicare dalla testimonianza concorde delle fonti letterarie e dei
monumenti figurati.
Gli strumenti (e di conseguenza anche il ritmo,
l'armonia, le disposizioni melodiche) sono manifestamente gli stessi che
troviamo nel mondo musicale dei Greci: una identità che non sorprende, se si
tien conto degli stretti rapporti di dipendenza che legano le città etrusche
alla civiltà ellenica per tanti altri aspetti.
Fra gli strumenti a corda,
rappresentati o ricordati, sono la cetra, la lira, il barbiton; fra gli
strumenti a fiato, il doppio flauto (tibiae) e la tromba diritta (salpinx, tuba)
o ricurva (cornu); fra quelli a percussione, i crotali delle danzatrici. Il duo
del suonatore di cetra (o lira, o barbiton) e del suonatore di doppio flauto
costituisce, come in Grecia, un accoppiamento normale: lo vediamo rappresentato
con particolare frequenza nelle scene di banchetto o di danza delle pitture
funerarie. Eppure, nell'ambito di una comune civiltà musicale l'Etruria deve
aver avuto, così nei generi come nella pratica, certe sue particolari tendenze e
tradizioni. Non può trascurarsi l'insistenza con la quale gli scrittori antichi
parlano dell'impiego del doppio flauto presso gli Etruschi, quasi di uno
strumento nazionale derivato dalla Lidia e poi trasmesso dagli Etruschi ai
Romani: il flautista o auleta si chiamava a Roma, con nome derivato
dall'etrusco, subulo. In verità l'auletica è un genere largamente diffuso in
Grecia, ma attribuito originariamente ai Frigi ed ai Lidi: esso risponde ad un
gusto musicale per il patetico e per l' orgiastico.
Anche in questo caso,
come in altre manifestazioni della civiltà artistica, gli Etruschi avrebbero
accolto dalla complessa esperienza ellenica certi elementi più vicini alla loro
sensibilità, orientandosi specialmente verso le forme elaborate nelle città
greco-orientali dell'Asia Minore. Logicamente dobbiamo supporre che la musica
etrusca preferisse quei «modi» che i teorici greci definivano lidio, ipolidio,
frigio e ipofrigio, con i relativi sistemi tonali, in contrapposizione con la
grave e solenne musica dorica. D'altro canto la tradizione greca, antica e
concorde (Eschilo, Eumen., 567 sgg.; Sofocle, Aiace, 17; Euripide, Fen., 1377
sgg., ecc.), attribuisce agli Etruschi la tromba: salpinx. Pur non significando
che questo antico strumento sia stato inventato realmente in Etruria, ciò vuol
dire che esso era caratteristico delle costumanze militari e forse anche
religiose etrusche, ed eventualmente fabbricato ed esportato da botteghe di
bronzisti etruschi (ma i monumenti figurati rappresentano di preferenza la
tromba ricurva, il corno, o diritta con la sua estremità ricurva come il lituo).
In ogni caso il favore accordato agli strumenti a fiato corrisponde ad un
notevole sviluppo delle pratiche musicali distaccate dal canto.
La musica non
soltanto si collega con la danza e con la mimica nelle grandi celebrazioni
religiose e nelle manifestazioni sceniche, ma sovente accompagna singoli momenti
del rito ed azioni della vita pubblica e privata, come le gare sportive, la
caccia, la preparazione dei banchetti e persino la fustigazione degli schiavi.
Questo rapporto della musica piuttosto con il gesto che con la parola trova il
suo parallelo nelle forme peculiari degli spettacoli scenici etruschi, che
avevano, per quanto sappiamo (Livio, VII, 2, 4 sgg.), carattere di mimo ed erano
rappresentati da attori-danzatori mascherati (histriones o ludiones), talvolta
anche con allusioni buffonesche e satiriche. Ciò non esclude la possibilità di
vere azioni drammatiche dialogate, certamente favorite, a partire dal IV secolo,
dall'influsso delle forme del teatro greco (come attestano i frequenti modellini
di maschere comiche trovati nelle tombe etrusche).
La danza ci è nota
soprattutto dalle figurazioni funerarie del VI e del V secolo. Sembra di regola
eseguita da ballerini professionali: danzatrici singole accompagnate da un
suonatore di doppio flauto; danzatori a coppia; ma soprattutto cori di uomini e
donne procedenti in fila distaccati e con movimenti individuali, guidati da
musici (suonatori di cetra o lira e flautisti) forse in funzione di corifei. I
musici partecipano ai passi della danza. Qualche volta si colgono nell'atto di
ballare anche personaggi della classe gentilizia alla quale apparteneva la
famiglia del defunto. I movimenti saltellanti delle gambe e i gesti accentuati e
presumibilmente rapidi delle braccia e della testa rivelano un genere di danza
fortemente scandito, agitato se non addirittura orgiastico, che si ispira
presumibilmente alla greca sikinnis di origine dionisiaca. Ma i documenti
limitati nel tempo e nell'ambito dell'arte funeraria non sono sufficienti a
provare che questo genere sia stato il solo coltivato in Etruria. Esso,
comunque, si accorda con i «modi» musicali che abbiamo supposto dominanti nel
mondo etrusco.
La scultura
Primi e assai
caratteristici documenti della plastica etrusca sono, già a partire dal VII
sec., i canopi, ossia vasi cinerari di bronzo e di argilla dal corpo panciuto,
con il coperchio interamente a foggia di testa umana. Talvolta al vaso erano
applicate due braccia, in luogo delle anse, ed il tutto era collocato su di una
sorta di tronetto circolare. Abbiamo poi i grandi sarcofaghi fittili, in forma
di letto conviviale, sul quale si trovano una o due persone recumbenti, in atto
di partecipare al proprio banchetto funebre. Nel Sarcofago degli Sposi sono
visibili alcuni elementi di derivazione ionica: l'acconciatura dei capelli, la
finezza dei volti, la levigatezza delle superfici. Ma tutto è interpretato in
maniera anticlassica.
La posizione stessa della coppia sposta il peso verso
destra, rompendo l'equilibrio della composizione. Tutto è spigoloso: i volti
triangolari, i menti aguzzi, gli occhi a mandorla. Il sorriso, invece
dell'impertubabile serenità greca, esprime piuttosto qualcosa di ironico. Anche
l'Apollo di Veio mostra rapporti con la scultura ionica, non solo
nell'acconciatura dei capelli e nel sorriso, ma anche nella veste
pieghettata.
Apollo di Veio
Lupa Capitolina
Ma le somiglianze
sono solo esteriori. La veste, a pieghe larghe e pesanti aderisce al corpo,
sembra frenare il passo veloce del dio, il quale nel volgersi, compie, con la
gamba sinistra uno sforzo muscolare tale che il polpaccio si avvolge come una
molla pronta a scattare. La linea ionica, persa la sua eleganza raffinata,
diventa mezzo per esprimere violenza. Lo stesso sorriso, per lo spessore delle
labbra taglienti, si trasforma in un ghigno beffardo. Una delle opere di più
alto valore della scultura bronzea etrusca è la Lupa Capitolina. In essa,
l'animale, ferocemente ringhiante, è rappresentato saldamente poggiato sulle
quattro zampe, con la testa rivolta verso lo spettatore. Sono poche le
somiglianze con una lupa autentica, non soltanto per la forma anatomica, ma
perfino per l'assenza quasi totale del manto peloso, che permette di far
risaltare la potente struttura ossea, lo smagrimento del ventre, la vena gonfia
sul muso, le mammelle. Il pelo, limitato a una striscia che riveste il collo
possente, non è morbido, ma bensì squamoso e duro ed esalta perciò l'asprezza
che emana da tutta la statua.
Chimera di Arezzo
Bruto
Capitolino
Vaso Canopo
Un'altra scultura bronzea di grande
importanza è la Chimera di Arezzo, il mitico mostro con il corpo di leone, la
coda anguiforme e, sporgente dal dorso, una testa di capra ferita. La bestia è
rappresentata con il muso minaccioso rivolto in alto, verso l'avversario. Tutti
i muscoli sono tesi, le costole sporgono dal torace, le unghie, allungate come
artigli, fuoriescono dalle dita. I peli, anche qui limitati a rivestire solo
alcune zone del corpo, si drizzano come aculei. Tra la ritrattistica scultorea
abbiamo il Bruto Capitolino, che per alcuni è etrusco, per altri romano.,Il
ritratto è fortemente tipizzato ed esprime la severità morale del personaggio.
Il movimento delle ciocche ineguali dei capelli e della barba non curata, i
piani facciali irregolari e chiaroscurati per le forti sporgenze e rientranze e,
soprattutto la terribile intensità degli occhi fissi, rendono la complessa
psicologia dell'uomo. Accanto al Bruto Capitolino, di cui ci è pervenuto solo il
busto, l'unico esempio intero di ritratto bronzeo etrusco è il cosiddetto
Arringatore del Trasimeno. Egli non è il giovane armonicamente strutturato dei
greci. Le rughe che solcano il volto sulla fronte e alle estremità degli occhi,
indicano un uomo di mezza età. Il viso, relativamente piccolo e sostenuto dal
collo robusto e lungo, è sobrio, concentrato nel pensiero e nell'esposizione
verbale. Il braccio alzato e la mano proporzionalmente più grande del naturale
sottolineano l'importanza di un passo del discorso: l'oratore parla a un vasto
uditorio che, attraverso il suo gesto, deve intuire i concetti, prima ancora che
comprenderli con la ragione.
La pittura
La
pittura etrusca è il completamento dell'architettura delle tombe. La tecnica
usata è una specie di affresco, con colori disciolti nell'acqua che vengono
assorbiti dallo strato sottile dell'intonaco. La pittura è planimetrica: pochi
colori, privi di chiaroscuro, distesi in superficie, staccati dal fondo, con la
conseguente prevalenza della linea che li campisce, quasi come se fosse una
decorazione vascolare. Quanto ai temi, poiché lo scopo delle figurazioni è
quello di circondare il morto con le immagini della vita, prevalgono le scene di
costume, con musicanti, danzatori, ginnasti, partite di caccia e di pesca. Non
mancano tuttavia le figurazioni mitologiche, derivate dalla pittura vascolare
greca o dovute ad artisti greci immigrati. Tra queste i più antichi affreschi
sono quelli della Tomba dei Tori a Tarquinia, con l'agguato teso da Achille al
giovane troiano Troilo presso la fontana sacra ad Apollo; tra le figure,
definite linearisticamente e campite con chiari colori, compaiono fiori
stilizzati, ed altri elementi paesistici, quali alberelli e cespugli spinosi.
Nella tomba della caccia e della pesca a Tarquinia le figure dei pescatori,
rappresentate con grafia semplificata e leggera, assumono un carattere
squisitamente decorativo al pari degli uccelli e dei pesci che popolano
sparsamente gli ampi spazi celesti e marini. Il fascino di queste ed altre
consimili figurazioni consiste in buona parte nella disposizione irrealistica
dei colori: secondo una convenzione derivata dalla pittura vascolare le figure
sono tinteggiate in rosso se maschili, in bianco se femminili: nè mancano
talvolta audaci invenzioni e arbitrii cromatici, come cavalli rossi ed
azzurri.
Altre pitture interessanti sono quelle della Tomba del
Barone.
Sulle pareti della piccola camera funeraria sono cavalli e figure
umane, intervallate da arboscelli. I colori (nero, rosso, grigio, verde,
bruno-violaceo) sono stesi su un sottile velo di preparazione. Il rapporto fra i
pieni e i vuoti è perfettamente bilanciato, così come sono calcolati gli
equilibri fra le immagini di un lato e quelle dell'altro, le proporzioni delle
figure fra loro e delle singole parti con tutto il complesso. Il disegno è
sottile, raffinato, adeguato all'eleganza delle figure. Nel IV sec. si stringono
nuovi contatti con la civiltà greca.
Lo confermano le pitture della Tomba
dell'Orco a Tarquinia fra le quali emerge la testa di una fanciulla della
famiglia Velcha, partecipante a un banchetto funebre. Il fondo verde scuro, dai
contorni irregolari, rappresenta forse una nuvola nera, richiamo all'oltretomba.
Questo piano di fondo dal colore compatto fa risaltare il profilo puro della
giovane e permette di evitare la tradizionale linea di contorno. Manca però il
chiaroscuro. Il valore dell'immagine si affida al rapporto fra i due colori
fondamentali: quello del fondo e il bianco-rosa del bel volto di profilo, le
labbra lievemente dischiuse, il grande occhio aperto a contemplare la scena
infernale, i capelli inghirlanditi, il collo ornato da una doppia collana. La
visione dell'oltretomba si va facendo drammatica. A contrasto con la fanciulla
Velcha sta l'immagine paurosa del demone Charu (Caronte), dal colorito
verdastro, il naso adunco, la barbetta irsuta, i capelli anguiformi, le grandi
ali, il bastone. L'aldilà non è più il luogo dove prosegue tranquilla la vita,
ma bensì il luogo di tormenti per tutti gli uomini.
Tomba dei
Tori:
L'agguato di Achille a Troilo
Tomba della Caccia e della
Pesca:
Scena di pesca
Tomba del Barone:
Fregio con persone e
cavalli
Tomba dell'Orco:
Testa di fanciulla
Finalità, condizionamenti e tendenze
L’arte
etrusca nacque dalla vita quotidiana e rimase sempre sostanzialmente vincolata
al soddisfacimento delle esigenze da quella proposte. Essa fu pertanto
strettamente legata, da un lato, alla struttura sociale, dall’altro, alla sfera
delle concezioni religiose e dell’ideologia funeraria. Non a caso, cioè non
soltanto per le fortuite circostanze della loro conservazione e della loro
riscoperta, le testimonianze che essa ha lasciato provengono nella stragrande
maggioranza dalle aree dei santuari e da quelle cimiteriali. Questo significa
che, tranne poche eccezioni, si trattò di un’arte dalle caratteristiche di tipo
artigianale (o di artigianato artistico), con tutto quello che ciò comporta e
pur tenendo presente che la distinzione tra arte e artigianato non sempre trova
valida rispondenza nel mondo antico. In ogni caso, non si può parlare per l’arte
etrusca di un fenomeno autonomo né di finalità estetiche, e solo raramente ci si
trova di fronte a manifestazioni che si potrebbero dire di “grande arte”, frutto
meditato del lavoro di particolari individualità e opera personale di artisti
consapevoli o di scuole ben definite e caratterizzate come tali.
Si aggiunga
il condizionamento dell’arte greca che fu sempre presente nella maggior parte
dei temi, dei tipi, degli schemi compositivi e dei canoni stilistici. Al punto
che, una volta superata la fase dei primordi ancora legata alle tradizioni
d’origine preistorica o alle suggestioni ornamentalistiche del periodo
orientalizzante, le successive fasi di sviluppo, a partire dal primo arcaismo e
fino alla tarda età ellenistica, cioè dalla fine del VII secolo a quasi tutto il
I secolo a.C., ripeterono praticamente quelle dell’arte greca. Il
condizionamento fu tuttavia di natura prevalentemente formale ed esteriore.
Essenzialmente decorativa, attenta al particolare e generalmente di sapore
incolto e popolaresco; tesa alla spontaneità e all’immediatezza, disorganica ed
espressiva, portata all’enfatizzazione e alla tensione drammatica; conservatrice
ma anche incostante, discontinua e incoerente: proprio per queste sue naturali
tendenze (oltre che per la necessità di selezionare i modelli onde adattarli ai
propri scopi), l’arte etrusca seppe trovare una sua via di fronte
all’insegnamento dei Greci. Sicché il confronto, più che soffermarsi sulla
qualità, riguarda la diversità degli atteggiamenti e delle realizzazioni, cioè
il modo di reagire degli artisti etruschi alle sollecitazioni e ai modelli che
giungevano dal mondo greco. A seconda delle necessità e delle epoche, e quindi
in relazione alle caratteristiche delle varie fasi dell’arte greca. Così, dei
modelli via via disponibili, gli Etruschi alcuni li ignorarono altri li
assunsero facendoli propri e talvolta rielaborandoli, magari insistendo su
motivi che nella stessa Grecia ebbero scarso rilievo o furono presto superati.
Quanto ai canoni stilistici, ci furono momenti di consonanza e di
partecipazione, come nel periodo arcaico (e specialmente nei confronti dell’arte
ionica) del VI secolo a.C.: momenti di ripulsa e di rigetto o, più
semplicemente, d’incomprensione, come nel periodo classico, tra il V e il IV
secolo a.C.; momenti di sudditanza e di pedissequa imitazione, come nel periodo
ellenistico, dal III al I secolo a.C.
Non mancarono tuttavia atteggiamenti
estranei, se non antitetici, alle concezioni figurative greche, soprattutto
quando queste non erano congeniali alle tendenze espressive etrusche e quindi
non sentite e incomprese. E furono proprio quelle tendenze, insieme alle
finalità pratiche del quotidiano, che indussero gli Etruschi a trascurare, o a
relegare in secondo piano, certe forme d’espressione artistica, come
l’architettura e la statuaria, e a privilegiarne altre, come la coroplastica,
ossia l’arte della creta, la bronzistica, a quella connessa, e le cosiddette
arti minori, come la piccola plastica, la ceramica, l’oreficeria, la toreutica.
Con risultati spesso di notevole perfezione tecnica e non dirado d’elevato
valore formale.
Arte profana
E' proprio nelle
arti "minori", nella vastissima produzione di suppellettili, piccoli bronzi fusi
e piccole terracotte con funzioni ornamentali, gemme incise e avori intagliati,
che si espresse al meglio l'originalità e la creatività degli artisti etruschi.
Particolare attenzione meritano gli specchi, trovati a centinaia nelle
necropoli. Il modello più comune era quello tondo con il manico. Il retro della
suprficie di bronzo era inciso, solitamente con soggetti mitologici provenienti
dall'arte greca, oppure coperto di iscrizioni. Ricchissima e meritatamente
famosa anche la produzione di monili ed oggetti in oro, nella quale gli etruschi
dimostrarono un elevato grado di elaborazione tecnica, capace di sfruttare le
possibilità espressive del metallo. Il periodo di massima fioritura fu tra la
metà del VII e la fine del VI secolo a.C., a Vetulonia e Vulci. Nella tomba
Regolini- Galassi, scoperta a Cere nel 1832, gli archeologi si trovarono davanti
ad un gran numero di gioielli; grandi bracciali lavorati, fibule incise, un
pettorale in oro sbalzato di 42 cm. conservato ai musei
Vaticani.
Specchio riproducente la cerimonia del chiodo Anche
nell'orificeria trionfò il gusto per il sovraccarico e gli effetti enfatici, sia
con l'incontro di motivi ornamentali vegetali, figurati e geometrici, sia con
l'impiego delle diverse tecniche di lavorazione, spesso combinate
insieme.
Tali tecniche comprendevano l'incisione, lo sbalzo, la fusione la
filigrana e, soprattutto, la granulazione, consistente nell'applicare sulla
superficie del metallo piccoli granelli d'oro saldati tra loro, moltiplicando
così l'effetto dell'incidenza della luce.
Gioielli (V-VI sec)
Collare con teste di Sileno, VI-V sec.
I
monumenti architettonici
Ben altra ricchezza di testimonianze dirette
ci si offre per l'architettura e per le arti figurative: si tratta infatti degli
stessi monumenti superstiti e dei resti materiali recuperati attraverso le
scoperte archeologiche. Nonostante la distruzione di tante opere e manufatti
antichi, questi documenti sono tali da offrirci una visione sufficientemente
ampia dell'attività artistica degli antichi Etruschi nelle sue tendenze e nei
suoi sviluppi.
L'edilizia monumentale non può naturalmente valutarsi sul
metro di quella dei Greci o dei Romani. L'impiego esclusivo di strutture murarie
a blocchi di pietra s'incontra soltanto nelle opere militari e nelle tombe: per
il resto, e cioè per gli edifici sacri e civili, esso appare limitato alle
fondazioni, mentre per le parti elevate si adoperavano materiali più leggeri,
quali il legno, il pietrame, i mattoni crudi, la terracotta. Ciò significa che
di questi edifici non possediamo più che le piante e qualche elemento di
decorazione; ma nonostante tutto è possibile raffigurarcene l'aspetto
originario, sulla base dei modelli offerti dai sepolcri rupestri e dalle urne
che ne imitano le forme o da piccole riproduzioni di destinazione votiva. Le
strutture murarie offrono, a seconda dei tempi, dei luoghi e della qualità dei
monumenti, una notevole diversità di materiale e di tecnica. Le pietre di più
largo impiego sono i calcari, il travertino, le arenarie, il tufo, tutte di
estrazione locale: l'assenza del marmo che ha tanta importanza nell'architettura
greca, si deve al fatto che lo sfruttamento delle cave di Carrara non avrà
inizio se non con l'età romana. Il genere delle murature varia dalla tecnica dei
grandi blocchi semilavorati ed irregolari, quale si mostra, ad esempio, nella
cinta di Vetulonia, a quella dei fini paramenti con piccoli blocchi squadrati
che si riscontra nelle mura urbane delle Città dell'Etruria meridionale ed in
altre costruzioni, specialmente funerarie. Ma non c'è in generale un'evoluzione
delle strutture più rozze e primitive alle più raffinate: la muratura quadrata
regolare si conosce e si impiega sin dalle fasi iniziali della civiltà etrusca;
e le differenze paiono dovute piuttosto a particolari condizioni di materiale,
di capacità delle maestranze, di fretta nella costruzione, ecc. Contrariamente a
certe opinioni già diffuse tra gli archeologi, la tecnica poligonale vera e
propria deve considerarsi estranea agli usi costruttivi degli Etruschi e
tardivamente introdotta, dai primi coloni militari romani, nelle piazzeforti di
Pyrgi, di Cosa, di Saturnia.
L 'uso, almeno parziale, dei mattoni crudi non
soltanto nell'edilizia domestica ma anche nell'architettura militare sembra
attestato a Roselle sin dalla fine del VII secolo; ciò rientra nel quadro di una
tradizione struttiva che si va sempre più rivelando diffusa nel mondo
mediterraneo sotto l'influenza greca; ed è probabile che a questa tecnica si
riferiscano anche le notizie sulla cinta di mattoni della città di
Arezzo.
Notevole diffusione ha in Etruria il sistema delle coperture a
falsa volta ed a falsa cupola con filari di blocchi sovrapposti in aggetto, di
universale diffusione mediterranea; al quale si sovrappone, nelle fasi più
recenti, la tecnica della volta reale a spinte, che appare in porte di città
(Volterra, Perugia) ed in monumenti sepolcrali, preludendo alle strutture
dominanti dell'architettura romana. In questa predilezione per la copertura a
volta l'architettura etrusca continua, perfeziona e trasferisce in sede
monumentale motivi di antica origine orientale che l'architettura greca classica
tende invece generalmente a respingere come elementi estranei alla sua rigorosa
concezione rettilinea, basata sulla struttura ad architravi. Fra i monumenti più
notevoli dell'architettura militare ricordiamo le cinte di Tarquinia (e tratti
superstiti di quelle, simili, di Veio, Caere, Vulci, ecc.), Volsinii, Roselle,
Vetulonia, Volterra, Chiusi, Cortona, Perugia, Fiesole, Arezzo. Queste opere si
datano generalmente tra il VI ed il III secolo, con ampliamenti e rifacimenti
posteriori, dato che in generale rimasero efficienti durante i tempi romani e in
qualche caso anche più tardi. Nonostante la diversità delle strutture, hanno in
comune il carattere di muraglie continue, originariamente non intrammezzate da
torri: avancorpi e rientranze si osservano soltanto in corrispondenza delle
porte.
Queste erano forse da principio architravate; ma nei grandiosi esempi
superstiti della Porta dell' Arco di Volterra e della Porta Marzia e della Porta
"di Augusto" di Perugia appaiono coperte a volta e presentano in facciata
elementi di decorazione architettonica o figurata a rilievo. L'aspetto antico di
cinte urbane merlate e con porte ad arco ci è testimoniato anche da figurazioni
di urne e sarcofagi. L'architettura funeraria si presenta con manifestazioni
piuttosto eterogenee, per il fatto che essa rappresenta l'occasionale
complemento o sviluppo costruttivo di tipi di sepolcri di origine od ispirazione
diversa. La maggior parte delle tombe, anche a carattere monumentale, risulta
infatti lavorata direttamente nella roccia sia che si tratti di vani scavati
(che vanno dalle più modeste forme dei pozzetti e delle fosse primitive sino ai
grandiosi e complessi ipogei con molti ambienti dell'età più matura), sia che si
tratti di adattamenti esterni aventi l'aspetto di tumuli rotondi o corpi
quadrangolari con terra sovrapposta o di facciate scolpite nella fronte di
declivi rupestri. Tali opere, pur non avendo un carattere architettonico, si
ricollegano strettamente all'architettura in quanto imitano spesso fedelmente le
forme di edifici reali nel loro aspetto esteriore ed interiore, negli elementi
decorativi e talvolta persino nelle rifiniture d'arredo e nelle
suppellettili.
Frequente è però anche la presenza di opere murarie, talvolta
aggiunte ad integrazione delle pareti e delle coperture di roccia, altre volte
costituenti per intero il monumento. Le camere sepolcrali costruite della fase
più antica presentano coperture a falsa volta ed eccezionalmente a falsa cupola
(come nella tomba di Casal Marittimo nel territorio di Volterra, o in quella
recentemente scavata presso Quinto Fiorentino). In età più recente si hanno
tombe con volta a botte di bella struttura (per es. la tomba del Granduca a
Chiusi e l'Ipogeo di San Mannopresso Perugia). Il tipo monumentale del tumulo
rotondo (con tamburo generalmente ricavato nella roccia come a Cerveteri e
costruito come a Populonia) diviene a partire dal V secolo assai meno frequente,
ma evolve, forse anche in contatto con l'architettura funeraria ellenistica,
verso lo schema dei grandi mausolei circolari romani di età imperiale quali
l'Augusteo e il Mausoleo di Adriano (per es. la così detta "Tanella di Pitagora"
di Cortona). Non mancano sepolcri quadrangolari informa di tempietti, per
esempio a Populonia. E va ricordato infine anche il tipo di tomba con basamento
a zoccolo sormontato da grandi cippi troncoconici o da obelischi, noto
soprattutto attraverso le figurazioni dei rilievi delle urne sepolcrali, ma
attestato direttamente fuori d'Etruria, nel così detto sepolcro degli Orazi e
Curiazi presso Albano Laziale. Un grandioso monumento di questo tipo con più
obelischi adorni di campane è ricordato dalle fonti antiche come esistente a
Chiusi, e identificato con la tomba del re Porsenna. I cippi funerari imitano in
piccolo queste forme.
L'architettura domestica e quella religiosa hanno
origini e caratteristiche comuni. Delle forme assunte dalla casa si tratterà più
avanti parlando della vita etrusca. Il tempio che da principio si identifica,
come nel mondo paleo-ellenico, con la casa rettangolare con tetto a spioventi e
senza portico (documentata da modellini votivi e dai resti di un edificio
scoperto sull'acropoli di Veio) assume poi forme più complesse parzialmente
parallele a quelle del tempio greco. Il tipo che Vitruvio (de archit. IV, 7)
attribuisce agli Etruschi è caratterizzato da una pianta di larghezza poco
inferiore alla lunghezza, con la metà anteriore occupata dal portico colonnato e
la metà posteriore costituita da tre celle, per tre diverse divinità, o da una
sola cella fiancheggiata da due alae o ambulacri aperti. Resti di monumenti
scavati a Veio, a Pyrgi, ad Orvieto, a Fiesole, a Marzabotto dimostrano che
questo schema ebbe effettivamente una vasta e durevole diffusione in Etruria
dall'età arcaica sino a quella ellenistica: esso appare anche a Roma nel tempio
di Giove Capitolino, la cui prima edificazione risale ai tempi della dinastia
etrusca dei Tarquini.
Ma senza dubbio si costruivano anche edifici sacri più
vicini, nel loro schema, al tempio greco, e cioè con pianta rettangolare
allungata e colonne in facciata (prostilo) o addirittura con colonnato continuo
su tutti i quattro lati (periptero): esempi cospicui ne sono il tempio più
antico di Pyrgi e quello dell'Ara della Regina a Tarquinia. L' originalità dei
templi etruschi non consiste comunque tanto nella loro concezione planimetrica
quanto piuttosto nel materiale, nelle proporzioni e nelle forme dell'alzato, nel
genere della decorazione.
Si è già detto che, all'infuori delle fondazioni,
essi dovevano essere costruiti di materiali leggeri, con impiego del legno per
le ossature portanti e per la travatura. Ciò comporta uno sviluppo relativamente
limitato in altezza (quale appunto risulta dalle misure del tempio "tuscanico"
secondo Vitruvio), larghi intercolumni, tetto ampio con notevole sporgenza
laterale delle gronde. La travatura lignea esige una protezione con elementi
compatti ma leggeri: donde l'uso universale di rivestimenti di terracotta
policroma, che si sviluppano in vivaci sistemi decorativi geometrici e figurati
con placche di copertura longitudinale o terminale delle travi, cornici, ornati
della estremità dei coppi (antefisse) e delle sovrastrutture del tetto
(acroteri). Il frontone era in origine aperto, lasciando visibili in facciata le
strutture della gabbia del tetto; solo più tardi si adottò il tipo del frontone
chiuso, decorato con una composizione figurata come nei templi greci. Queste
varie caratteristiche del tempio etrusco trovano indubbi riscontri nella
primitiva architettura greca e, come si è detto, parziali paralleli nel tempio
greco arcaico e classico.
La differenza sta nel fatto che il tempio greco sin
dal VII secolo a;C. tende a trasformarsi in un edificio monumentale pressoche
interamente costruito di pietra, con una sua propria ed inconfondibile
evoluzione delle forme architettoniche; mentre il tempio etrusco resta
sostanzialmente fedele alle tradizioni dell'architettura lignea sino alla piena
età ellenistica, accentuando, se mai, l'esuberanza decorativa dei rivestimenti
di terracotta. I quali offrono, specialmente nel VI e V secolo, varietà di
concezioni e sviluppi: per esempio nel tipo delle lastre di copertura
longitudiriale dei travi che possono formare fregi figurati continui a rilievo
di ispirazione greco-orientale (così detta “prima fase” o “fase ionica”) o
possono invece presentare una semplice ornamentazione dipinta con forte sviluppo
della sovrastante cornice in aggetto, come nei sistemi decorativi fittili della
Grecia propria e delle colonie dell'Italia Meridionale e della Sicilia ("seconda
fase" o "fase arcaica"). Quest'ultimo tipo si afferma a partire dalla fine del
VI secolo, in coincidenza con il momento di maggiore splendore dello sviluppo
dei templi etruschi, caratterizzato anche dalle antefisse a conchiglia, dalle
decorazioni frontonali a rilievo distribuite sulle placche di rivestimento delle
testate dei travi lunghi, dai grandi acroteri figurati: esempi caratteristici il
tempio di Veio e i templi di Pyrgi. Lo schema decorativo così formato sarà poi
seguito con poche modificazioni nei secoli successivi.
La sola
novità rilevante è l'introduzione del frontone chiuso decorato con una
composizione figurata unica alla maniera greca, di terracotta e in altorilievo;
esso appare già forse nel V secolo, ma ci è noto soprattutto a partire dal IV
secolo a Tarquinia, a Talamone, a Luni ("terza fase" o "fase ellenistica").
Parlando delle forme e dei rivestimenti del tempio etrusco, non si può
trascurare il fatto fondamentale che i medesimi caratteri e sviluppi si
riscontrano nei templi del territorio falisco e laziale e, sia pure con qualche
differenza, in Campania: può parlarsi di una comune civiltà architettonica
dell'Italia tirrenica a settentrione dell'area direttamente toccata dalla
colonizzazione greca. L'affermarsi del tipo del tempio di pietra, in
sostituzione delle tradizionali strutture lignee (sotto l'influsso greco, ma pur
sempre con forme peculiari), avrà luogo progressivamente, sotto l'influsso dei
modelli greci, nel corso del IV secolo e dell'età ellenistica.
Il predominio
di elementi di ispirazione arcaica anche in opere di età molto recente si
osserva del resto in tutti i motivi della decorazione architettonica etrusca,
quali appaiono nelle costruzioni di pietra ed in quelle di legno e terracotta, e
nelle loro innumerevoli riproduzioni ed imitazioni dell'arte funeraria e votiva.
Vitruvio parla di un "ordine tuscanico" distinto dagli ordini dorici, ionici e
corinzio dell'architettura greca. Esso era caratterizzato da un tipo di colonna
che si vede effettivamente impiegato nei monumenti romani e rappresenta una
variante della colonna dorica, con la stessa forma di capitello ma con il fusto
liscio e con un basamento. La sua origine etrusca è provata da testimonianze che
risalgono all'età arcaica: di questa forma era, verisimilmente, la maggior parte
delle colonne lignee dei templi e degli edifici civili. Si tratta in realtà di
una sopravvivenza ed elaborazione del tipo detto "protodorico" (fornito di
plinto sagomato, con fusto senza scanalature e sensibilmente rigonfio, con
capitello a cuscino bombato), che nel mondo greco primitivo era stato
prestissimo sostituito dalla colonna dorica vera e propria. Ma accanto a questo
tipo vediamo diffuso in Etruria anche un genere di colonne e di pilastri con
capitello a volute floreali, semplici e composite, che trova la sua ispirazione
nei capitelli orientali siro-ciprioti e nei capitelli così detti "eolici" della
Grecia orientale: genere, anch'esso, precocemente scomparso nel mondo greco, con
l'affermarsi del capitello ionico.
Modanature di impronta arcaica, con
dadi, cordoni, “campane”, “gole”, appaiono dominanti nella sagoma di basamenti e
coronamenti di edifici, altari, cippi, ecc. ; mentre la incorniciatura di porte
e di finestre sottolinea gli stipiti sui lati del vano rastremato verso l'alto e
il sovrapposto architrave sporgente che, in epoca più evoluta, si piega alle
estremità nelle caratteristiche “orecchiette”. L'ornamentazione non figurata
delle cornici, dei coronamenti e degli altri elementi delle sovrastrutture degli
edifici appare domi!lata da motivi a foglie stilizzate, trecce, palmette e fiori
di loto, spirali, meandri, ecc., di prevalente ispirazione ionica. Il sistema
del fregio dorico con metope alternate a triglifi sembra diffondersi soltanto
dopo il IV secolo; ma spesso, in luogo dei triglifi, s'incontrano veri e propri
pilastrini.
Il problema dell' «arte etrusca»
Considerate le diverse categorie di monumenti artistici, resta da affrontare
il problema più grosso, il «problema» per eccellenza: quello del loro
significato estetico e storico. Gran parte delle opere che possediamo non ha,
ovviamente, il carattere di creazione originale: rientra nel solco di tradizioni
artigianali e riflette soltanto alla lontana le grandi linee di sviluppo della
storia dell'arte. Ma esistono alcuni monumenti e gruppi di monumenti, nei quali
si può ritenere presente l'impronta di una certa personalità artistica, più o
meno spiccata. Si tratta di stabilire fino a che punto questa possibilità
risponda a realtà, e cioè se veramente ci si trovi, in questi casi, di fronte a
piccole o grandi creazioni; o invece si abbia pur sempre a fare con semplici
imitazioni di modelli; ed in quale ambiente debbano eventualmente ricercarsi
questi modelli.
Il fatto più evidente è che la stragrande maggioranza dei
temi, dei tipi, degli schemi compositivi della produzione artistica etrusca
trova i suoi precedenti e la sua ispirazione nel mondo greco; e che tale
dipendenza si estende normalmente anche alle forme stilistiche; cosicche lo
sviluppo dell'arte in Etruria, dal primo arcaismo sino alla tarda età
ellenistica, ripete sostanzialmente le fasi di sviluppo dell'arte greca. Però si
notano anche differenze: nel senso che l'Etruria ignora certi motivi della
produzione ellenica ed elabora invece diffusamente altri che in Grecia hanno
scarso rilievo o appartengono a fasi stilistiche già superate; ne mancano indizi
di atteggiamenti estranei, se non addirittura antitetici, alle concezioni
figurative greche.
C'è da chiedersi se e fino a che punto gli artisti
etruschi abbiano inteso reagire e di fatto abbiano reagito, con soluzioni
originali, alle dominanti formule greche. C'è da chiedersi poi se, realizzando
una loro propria visione artistica, essi abbiano creato le premesse al formarsi
di tradizioni locali distinte dall'arte greca; e su quale ampiezza e per quale
durata queste tradizioni abbiano avuto la possibilità di imporsi. In altre
parole, posta l'esistenza di spunti autonomi nella produzione-etrusca, ci
domandiamo se tali spunti siano fatti effimeri e slegati o se esista tra loro
una connessione; e se un'ipotetica «costante» nelle tendenze del gusto in
Etruria attraverso i secoli debba attribuirsi a continuità storica o piuttosto
ubbidisca ad una profonda predisposizione del popolo etrusco verso orientamenti
espres- sivi differenti da quelli del popolo greco. Questi diversi interrogativi
si riassumono, tutto sommato, in uno solo: fino a che punto ed in che senso
possiamo parlare della esistenza di un' , 'arte etrusca"?.
La posizione
della critica nel secolo XIX fu, in proposito, negativa. La produzione etrusca
era da considerare come un fenomeno provinciale dell'arte greca, con opere rozze
e senza valore; mentre ogni trovamento di un qualche pregio artistico fatto in
Etruria si attribuiva senz'altro a mano greca. Ma i nuovi orientamenti della
critica e della storia dell'arte, affermatisi col principio del nostro secolo
specie a seguito degli studi di A. Riegl, riconoscendo piena validità di
espressione ad esperienze artistiche diverse da quella classica, aprirono la
strada ad una comprensione di fenomeni stilistici del mondo antico per l'innanzi
sottovalutati, quale appunto l'etrusco. Dall'analisi di singole opere d'arte di
recente scoperta (come l'Apollo di Veio, come il "Bruto Capitolino") si arrivò,
più o meno cautamente, ad affermare l'originalità e l'autonomia dell'arte
etrusca rispetto alla greca, per una sua diversa ed inconfondibile visione della
forma. che trasoarirebbe evidente anche nell'imitazione degli schemi e dei tipi
ellenici. Si parlò, in vero, addirittura di una peculiare disposizione dei
popoli italici (non soltanto, quindi, degli Etruschi, ma più tardi anche dei
Romani) a concepire la realtà secondo una immagine «illusionistica»,
«inorganica», immediata e fortemente individualizzata, di contro alla visione
«naturalistica», «organica», «tipica» dell'arte greca. A questi punti di vista
non sono mancate obiezioni critiche di un certo peso. Più di recente si è
tornati anzi ad affermare che non esistono in Etruria vere opere d'arte se non
sotto la diretta influenza delle forme greche; e che la «originalità»
etrusco-italica si riduce a manifestazioni effimere di colorita abilità
artigiana e popolaresca, incapaci di dar vita ad una tradizione (R. Bianchi
Bandinelli).
Il problema, dunque, resta ancora sostanzialmente aperto. Ma
forse esso fu male impostato così dai negatori come dai sostenitori della
originalità dell'arte etrusca. Si considerò infatti generalmente questo fenomeno
in blocco, senza tener conto che esso abbraccia manifestazioni quanto mai varie,
per la durata di almeno sette secoli, e che le trasformazioni avvenute nel corso
di un così lungo periodo non riguardano soltanto l'Etruria e la Grecia, ma hanno
una portata decisiva per tutto lo sviluppo dell'arte antica. È evidente che le
prospettive mutano a seconda dei tempi; e parrebbe quindi logico esaminare il
problema dell'«arte etrusca» riportandoci alla situazione di ciascun periodo,
piuttosto che cercarne astrattamente una soluzione complessiva.
Risulterà
così che alle origini, più o meno tra il IX e il VII secolo, l'attività
artistica dei centri etruschi si svolge parallela a quella di altri paesi
mediterranei, compresa la Grecia, in un fluido e complicato accavallarsi di
motivi di tradizione preistorica (specialmente evidenti nel vivace realismo
della piccola plastica) e di influenze orientali che caratterizzano quella fase
del gusto decorativo che chiamiamo appunto orientalizzante. È chiaro che per
questi periodi non è ancora il caso di parlare di subordinazione all'arte greca.
Diremo piuttosto che l'Etruria partecipa, nella sua posizione periferica verso
occidente, alla estrema elaborazione di un'antica esperienza artistica
mediterranea, pa!allelamente alla Grecia. Ma fatta eccezione per qualche spunto
di originalità nella plastica funeraria (per esempio nelle espressive teste dei
canopi di Chiusi), non vi è nessun accenno al formarsi di una valida tradizione
artistica locale, o nazionale. Qui appunto sta la differenza decisiva, gravida
di sviluppi futuri, rispetto alla Grecia che, precisamente in questa età
cruciale, andava superando con vigoroso impeto creativo le formule del vecchio
mondo ed aprendo una nuova pagina nella storia dell'arte universale.
Non
sorretta da una propria tradizione, fatalmente l'Etruria era destinata a cadere
nell' orbita della esperienza artistica greca, la cui capacità di attrazione,
oltreche nel fascino innovatore e nella intrinseca superiorità di valori
estetici, consisteva anche nella sua amplissima diffusione territoriale dalla
madrepatria alle colonie d'Italia e di Sicilia. Ciò avvenne effettivamente
almeno dagli inizi del VI secolo; e dobbiamo ritenere che le influenze
dell'arcaismo greco sull'Etruria nel campo artistico non consistessero soltanto
nella importazione di oggetti e di modelli, ma anche nella diretta attività di
artefici greci nelle città etrusche. Eppure proprio in questo periodo, nel VI e
nei primi decenni del V secolo, la produzione d'arte in Etruria si manifesta con
un rigoglio meraviglioso e, per certi aspetti, insuperato, nell'architettura
templare, nella plastica, nella bronzistica, nella pittura, negli oggetti
«minori» decorati: con opere numerosissime, di tecnica raffinata e di alto
livello stilistico, non prive di un certo «carattere» peculiare che le rende
sovente riconoscibili come prodotti etruschi o di ambiente etrusco. Il dilemma
originario (dipendenza o autonomia ?) si propone qui ora con aspetti tanto più
delicati, quanto più i fatti sembrano condurre verso un giudizio apparentemente
contraddittorio, che giustifica le incertezze dei critici moderni: nel senso che
queste opere pur essendo «etrusche» non cessano per ciò stesso di esser
«greche». Affermazione che potrebbe sembrare paradossale; ma non lo è, purche ci
si sforzi di sbarazzarci dello schema mentale di «arte nazionale», che nel caso
particolare non è applicabile.
Dobbiamo in verità tener presente che l'arte
greca arcaica non rappresenta un fenomeno rigidamente unitario e stilisticamente
conseguente; bensì piuttosto il risultato della elaborazione locale di centri
quanto mai vari, numerosi e dispersi nello spazio, con correnti vivaci,
multiformi, mutevoli che si diffondono, si trasmettono, s'intersecano. In questo
quadro, essenzialmente regionalistico, trovano posto anche territori
parzialmente ellenizzati o non greci ma sotto l'influenza della civiltà greca:
quali, ad esempio, in oriente Cipro, la Licia, la Caria, la Lidia, la Frigia, a
settentrione la Macedonia e la Tracia, in occidente l'Etruria. Questi paesi non
sono soltanto «province» recettive che subiscono passivamente l'impronta delle
creazioni del genio greco; ma partecipano essi stessi, come «regioni» di una
vasta comunità civile, alla elaborazione dell'arte arcaica, secondo le
circostanze, le particolari esigenze, le capacità: e pertanto con proprie
caratteristiche nell'ambito della più vasta unità periellenica. Nel caso
dell'Etruria le peculiarità «regionali» della produzione d'arte arcaica
potrebbero indicarsi nei seguenti motivi principali:
1) esigenze
religiose e funerarie che predispongono l'attività figurativa ad una
rappresentazione concreta, immediata, veristica della realtà;
2)
sensibili persistenze di schemi, tecniche e tradizioni formali della precedente
fase «mediterranea» ed orientalizzante;
3) relazioni dirette e
fortissime con le esperienze artistiche del mondo greco-orientale, e cioè dei
centri eolici e ionici delle coste e delle isole dell' Asia Minore occidentale:
tali da determinare per molti decenni (fra la metà del VI e il principio del V
secolo) quella impronta, sostanzialmente unitaria, della cultura figurativa in
Etruria che suoI definirsi appunto come arte ionico-etrusca;
4)
manifestarsi, nell'ambito dell'attività artistica locale, di rilevanti
personalità, di artisti greci e locali e di scuole di alto livello (bronzisti di
Vulci e di Perugia, pittori come il maestro della Tomba del Barone a Tarquinia,
modellatori in terracotta di Veio come l'artefice dell'«Apollo» e i suoi
seguaci, ecc.), cui difficilmente potremmo negare una autentica, origi- nale ed
a volte vigorosissima genialità creativa.
La prospettiva storica muta
completamente nella prima metà del V secolo. La Grecia passa dall'arte arcaica
all'arte classica con un processo di fondamentale importanza per la storia della
civiltà umana. Ma l'attività dei grandi maestri greci tende a farsi
stilisticamente più serrata, acquista un carattere più «nazionale», si concentra
specialmente attorno ad Atene e alle città del Peloponneso. Anche per motivi
d'ordine politico-economico le regioni periferiche declinano. L'Etruria resta
isolata. Lo spirito della classicità, in quanto realtà di un momento creativo
irripetibile ed inimitabile, non trova rispondenza del mondo etrusco, dove, tra
l'altro, le felici condizioni storiche che avevano favorito la fioritura
artistica dell'arcaismo sono venute a cessare, con l'inizio di un lungo periodo
di depressione e di decadenza. Vediamo così per tutta la durata del Ve fino
all'inoltrato IV secolo perdurare motivi e formule di tradizione arcaica o
ispirate all'arte greca di "stile severo", cioè della fase di passaggio
dall'arcaismo alle forme classiche. Il fenomeno dell'attardamento proprio dei
paesi marginali (come, ad esempio, nella contemporanea arte «subarcaica» di
Cipro) si manifesta con una certa evidenza. La penetrazione delle influenze
classiche è parziale e stentata. In questo ambiente privo di una tradizione
unitaria ed accreditata, come già nella fase delle origini, la vitalità
artistica si palesa soltanto in qualche effimero spunto di originalità
espressiva; mentre nel campo della tecnica artigiana continua, particolarmente
attiva, la produzione dei bronzisti.
Una intensa ripresa di contatti
artistici fra Grecia ed Etruria ha luogo a partire dal IV secolo e si continua
per tutta l'età ellenistica, confondendosi alla fine con il fenomeno, altrimenti
ben noto, del trionfo dell'ellenismo nell'Italia romana della fine della
repubblica e del principio dell'impero. Ma l'atteggiamento dei figuratori
etruschi rispetto all'arte greca non sembra più quello dei tempi arcaici. Non si
può più parlare della elaborazione, in qualche modo originale di un patrimonio
comune: si tratta piuttosto della imitazione, più o meno fedele e riuscita, di
modelli «stranieri». Non si accolgono soltanto forme e singoli motivi
tipologici, ma si riproducono intere composizioni, specialmente da prototipi
della grande pittura, ad ornamento di edifici e di oggetti. Per quest'ultima
fase di produzione potrebbe giustificarsi il concetto dell'Etruria come
«provincia» del mondo greco (ciò che equivale alla negazione di una sua
originalità artistica).
Occorre però tener conto di un altro aspetto,
completamente diverso e di gran lunga più importante, dell'attività figurativa
etrusca di età ellenistica. In singoli monumenti o in gruppi di opere,
specialmente dell'arte funeraria, vediamo aparire motivi e soluzioni stilistiche
decisamente contrastanti con il gusto classico: strutture compatte e
geometrizzanti, forme «.incompiute», sproporzioni, esasperazioni di particolari
espressivi, ecc. Ci si può chiedere se e fino a che punto queste manifestazioni
siano da spiegare come sopravvivenze artigianali di remote formule arcaiche,
favorite dall'immobilismo rituale del mondo religioso etrusco, o come
improvvisazioni popolaresche senza conseguenze, o addirittura come casuali
effetti di una tecnica manuale scadente. Ma si può anche pensare a riflessi
seppure indiretti dell'attività di artisti che, accogliendo antichissime
assuefazioni locali e reagendo ai modelli greci secondo il proprio temperamento,
abbiano tentato nuove forme di espressione. Questa ipotesi diventa certezza nel
campo della ritrattistica, che ci si rivela con au- tentiche ed originali opere
d'arte (grandi bronzi, pitture, ecc.) e con innumerevoli prodotti secondari
(coperchi di sarcofagi, terrecotte), i quali mostrano a loro volta il formarsi
di una salda tradizione locale attorno all'attività dei maestri maggiori.
In
contrasto con il ritratto greco, al quale pure originariamente si ispira (nel IV
secolo) e talvolta si richiama (nel corso dell'età ellenistica), il ritratto
etrusco tende a realizzare il massimo della concretezza espressiva per ciò che
concerne le fattezze e, in un certo senso, anche il «carattere» individuale,
prescindendo dalla coerenza organica delle forme naturali, ma accentuando gli
elementi essenziali attraverso l'impiego semplice, rude, discontinuo e a volte
violento delle linee o delle masse.
Con questo possiamo dire che è nato un
nuovo stile, una nuova tradizione artistica, effettivamente definita ed autonoma
rispetto al mondo greco: una tradizione che è «etrusca», ma anche, più
genericamente «italica», perchè il suo sviluppo si continua, di là dal tramonto
dell'Etruria come nazione, nell'arte dell'ltalia romana e del mondo occidentale
sotto l'impero. Tale visione «espressionistica» della realtà, specialmente nel
ritratto, ma anche in altri temi d'arte, perdurerà vitale nelle correnti di
produzione popolare dei primi secoli dell'impero, si diffonderà nell'arte
provinciale europea, riaffiorerà impetuosamente nella grande arte romana aulica
della fine del II e del III secolo d.C., costituirà una delle componenti più
significative della civiltà artistica della tarda antichità e del
medioevo.
La Religione
Introduzione
Il pantheon etrusco
Lo
spazio sacro
L 'al di là
Forme del culto
Il culto degli dei e dei
defunti
La ''disciplina etrusca"
L’interpretazione dei fulmini e delle
viscere
L’osservazione dei prodigi
Libri Fulgurales
L'arte della
divinazione
Il rito di fondazione
Le pratiche rituali
Il rituale
funerario
Il culto dei morti
Introduzione
Gli autori
latini erano concordi nel definire gli etruschi un popolo religiosissimo esperto
nell'arte divinatoria. Ebbero infatti un'articolata letteratura religiosa, oggi
purtroppo irrimediabilmente perduta. Esistevano una serie di rigide regole che
determinavano il rapporto tra gli dèi e gli uomini (quella che costituiva la
''disciplina etrusca", ossia scienza etrusca), quindi sul rito e
sull'interpretazione della volontà divina. Di queste norme possiamo farci solo
un'idea attraverso alcuni passi di Cicerone, Plinio il Vecchio, Livio o Seneca
(che si rifacevano a traduzioni che non ci sono pervenute) e tramite rarissimi
documenti etruschi come la "mummia di Zagabria" o il "fegato di Piacenza".
Sappiamo inoltre che quella etrusca fu una religione rivelata attraverso le
profezie di esseri superiori come il fanciullo Tagete e la ninfa Vegoe o
Vegonia. Fra gli etruschi delle origini la divinità appare sempre in modo molto
impreciso, sia nell'aspetto che nelle mansioni ed è ragionevole pensare che in
principio vi fosse un'unica entità divina che si manifestava in molteplici modi,
assumendo connotati diversi. Tra l'VIII e il VI secolo a.C. si assiste alla
trasformazione della religione etrusca. Dalla Grecia vennero importate in
Etruria nuove divinità; quelle indigene assunsero figura umana e col tempo
ereditarono le caratteristiche e le mansioni degli dèi dell'Olimpo
classico.
Il pantheon etrusco
Le più antichità
divinità degli etruschi rappresentavano le forze della natura, distruttrici e
creatrici al tempo stesso: Tarconte era il dio della tempesta, distruttore ma
anche dispensatore di benefica pioggia; Velka era il dio del fuoco e, insieme,
della vegetazione. Sommo dio dell'Etruria - dice Varrone - era Velthune (in
latino Vertumnus o Voltumna), il multiforme, che rappresentava l'eterno mutare
della stagioni ed era adorato nel santuario federale di Volsinii. All'antico
pantheon appartenevano anche gli dèi Selvans (Silvano) e Ani (poi Giano) e la
dea Northia, divinità probabilmente del fato. Dal VII secolo a.C. molte divinità
di fondo originariamente etrusco vennero assimilate agli dèi olimpici: la
divinità superiore Tinia (o Tin), rappresentata sempre col fulmine, fu
l'equivalente di Zeus ossia Juppiter (Giove); lo stesso avvenne con Uni,
compagna di Tinia, che divenne Hera, ossia la Iuno latina (Giunone). Turan, la
dea dell'amore, fu assimilata ad Afrodite e quindi alla Venus (Venere) latina;
Menerva ad Athena (Minerva); Maris ad Ares (Marte); Nethuns a Poseidon
(Nettuno); Turms a Hermes (Mercurio); Fufluns a Dionisio (Bacco); Sethlans a
Efesto (Vulcano); di Castor e Pollux (Castore e Polluce, i Dioscuri) diventati
Castur e Pultuce, ecc.. Ci furono anche dèi nuovi, importati direttamente dal
mondo greco, che conservarono il loro nome appena etruschizzato: Artemis (ossia
Diana) divenne Aritimi, Apollon (Apollo) fu chiamato Apulu, Heracles (Ercole)
cambiò in Hercle. Controversa è l'origine etrusca delle ''triadi" che conosciamo
con certezza soltanto nel mondo romano: non è chiaro se la triade capitolina
Giove-Giunone-Minerva corrisponda a Tinia-Uni-Menerva. Di sicura origine greca
sono invece le coppie (''diadi"), come quella degli dèi infernali Ade e
Persefone (in etrusco Aita e Phersipnai).
Gli Etruschi credevano
nell’ineluttabilità del destino, al limite potevano solo rendere più piacevole
la loro permanenza terrena, per questo motivo compivano feste e riti magici.
Credevano nell’aldilà, in particolare nell’inferno, che aveva una porta di
accesso, detta mundus, sorvegliato dalla terribile figura del demone Tuchulcha,
mostro con orecchie d’asino, il muso di avvoltoio e i capelli fatti da serpenti.
Questa figura fa maggiormente la sua presenza nella fase di declino della
cultura etrusca, caratterizzata dalla presenza di morte e persecuzioni.
Il
demone degli inferi era Charun, che accompagna i morti nell’aldilà, da cui si
rievoca la figura di Caronte, portava indosso un mantello ed aveva in mano un
martello, simile a quello impiegato oggi per la sepoltura del Papa, con il quale
si tocca tre volte la tempia del pontefice defunto. Un gioco funebre
caratteristico è quello legato al mito di Phersu, da cui ha origine la parola
"persona", che aizza un cane contro una persona con la testa coperta da un
sacco, che lentamente viene legata. Il cane sbrana la persona e sta a
testimoniare l’ineluttabilità del destino. Le tombe rappresentavano le scene di
vita quotidiana: gioia, feste, pranzi e, negli ultimi anni, dolore e terrore.
Adottarono un calendario introdotto dai Tarquini, con influenze mesopotamiche, e
poi modificato da Cesare, con l’aiuto sempre di tirreni. In esso si ricordavano
feste e appuntamenti sacri. Suddivisero la loro era in dieci saeculum dopo dei
quali ci sarebbe stata la fine della civiltà tirrenica, come in realtà fu
confermato dalla storia.
Lo spazio sacro
Lo
spazio “sacro”, orientato e suddiviso, risponde ad un concetto che in latino si
esprime con la parola templum. Esso riguarda il cielo, o un'area terrestre
consacrata - come il recinto di un santuario, di una città, di un'acropoli, ecc.
-, ovvero anche una superficie assai più piccola (ad esempio il fegato di un
animale utilizzato per le pratiche divinatorie), purchè sussistano le condizioni
dell'orientamento e della partizione secondo il modello celeste. L'orientamento
è determinato dai quattro punti cardinali. congiunti da due rette incrociate, di
cui quella nord-sud era chiamata cardo (con vocabolo prelatino) e quella
est-ovest decumanus nella terminologia dell'urbanistica e dell'agrimensura
romana che sappiamo strettamente collegate alla dottrina
etrusco-italica.
Posto idealmente lo spettatore nel punto d'incrocio
delle due rette, con le spalle a settentrione, egli ha dietro di se tutto lo
spazio situato a nord del decumanus. Questa metà dello spazio totale si chiama
appunto «parte posteriore» (pars postica). L'altra metà che egli ha dinnanzi
agli occhi, verso mezzogiorno, costituisce la «parte anteriore» (pars antica).
Una analoga bipartizione dello spazio si ha nel senso longitudinale del cardo: a
sinistra il settore orientale, di buon auspicio (pars sinistra o jamiliaris); a
destra il settore occidentale, sfavorevole (pars d extra o hostilis). La volta
celeste, così orientata e divisa, s'immaginava ulteriormente suddivisa in sedici
parti minori, nelle quali erano le abitazioni di diverse divinità. Questo schema
appare riflesso nelle caselle del bordo esterno (appunto in numero di sedici) e
nelle caselle interne (ad esse corrispondenti, seppure in maniera non del tutto
chiara) del fegato di Piacenza. Tra i numi dei sedici campi celesti, citati da
M. Cappella, e i nomi divini in scritti sul fegato esistono indubbie
concordanze, ma non una corrispondenza assoluta, perche l'originaria tradizione
etrusca pervenne presumibilmente alterata nelle fonti del tardo scrittore
romano, con qualche spostamento nelle sequenze. Ciò nonostante è possibile
ricostruire un quadro approssimativo del sistema di ubicazione cosmica degli dèi
secondo la dottrina etrusca. Esso ci mostra che le grandi divinità superiori,
fortemente personalizzate e tendenzialmente favorevoli, si localizzavano nelle
plaghe orientali del cielo, specie nel settore nord-est; le divinità della terra
e della natura si collocavano verso mezzogiorno; le divinità infernali e del
fato, paurose ed inesorabili, si supponevano abitare nelle tristi regioni
dell'occaso, segnatamente nel settore nord-ovest, considerato come il più
nefasto.
La posizione dei segni che si manifestano in cielo (fulmini, volo di
uccelli, apparizioni prodigiose) indica da qual nume proviene agli uomini il
messaggio e se esso è di buono o di cattivo augurio. Indipendentemente dal punto
di origine, una complicata casistica riguardante le caratteristiche del segnale
(per esempio la forma, il colore, l'effetto del fulmine, o il giorno della sua
caduta) aiuta a precisarne la natura: se si tratti cioè di un richiamo
amichevole, o di un ordine, o di un annuncio senza speranza e così via. Lo
stesso valore esortativo o profetico hanno le speciali caratteristiche
presentate dal fegato di un animale sacrificato, preso in esame dall'aruspice,
secondo una corrispondenza delle sue singole parti con i settori celesti. Così
l'«arte fulguratoria» e l'aruspicina, le due forme tipiche della divinazione
etrusca, appaiono strettamente collegate; ne fa meraviglia che esse possano
essere state esercitate da un medesimo personaggio, come quel L. Cafatius di cui
si rinvenne a Pesaro l'epitafio bilingue e che fu appunto haruspex (in etrusco
netsvis) e fulguriator (cioè inrerprete dei fulmini: in etrusco trutnvt frontac
o trutnvt?). Uguali norme devono aver presieduto all'osservazione divinatoria
del volo degli uccelli, come intravvediamo specialmente da fonti umbre (Tavole
di Gubbio) e latine. A tal proposito ha speciale importanza lo spazio terrestre
d'osservazione, e cioè il templum augurale, con il suo orientamento e le sue
partizioni, cui senza dubbio si ricollega la disposizione non soltanto dei
recinti sacri, ma dello stesso tempio vero e proprio, cioè l'edificio sacro
contenente il simulacro divino, che in Etruria appare di regola orientato verso
sud o sud-est, con una pars antica che corrisponde alla facciata ed al colonnato
ed una pars postica rappresentata dalla cella o dalle celle. E del pari le
regole sacre dell'orientamento si osservano (almeno idealmente) nella
planimetria delle città (concreto esempio monumentale è Marzabotto in Emilia), e
nella partizione dei campi.
In tutte queste concezioni e queste pratiche,
come in generale nelle manifestazioni rituali etrusche, si ha l'impressione,
come già accennato, di un abbandono, quasi di una abdicazione dell'attività
spirituale umana di fronte alla divinità: che si rivela nella duplice ossessione
della conoscenza e dell'attuazione della volontà divina, e cioè da un lato nello
sviluppo delle pratiche divinatorie, da un altro lato nella rigida minuziosità
del culto. Così anche l'adempimento o la violazione delle leggi divine, nonche
le riparazioni attuate attraverso i riti espiatorii, sembrano essere soprattutto
formali, al di fuori di un autentico valore etico, secondo concezioni largamente
diffuse nel mondo antico, che però appaiono soprattutto accentuate nella
religiosità etrusca. Ma è possibile che almeno gli aspetti più rigidi di questo
formalismo si siano definiti soltanto nella fase finale della civiltà etrusca, e
precisamente nell 'ambito di quelle classi sacerdotali le cui elaborazioni
rituali e teologiche trovarono la loro espressione nei libri sacri, forse
favorite dal desiderio dei sacerdoti stessi di accentrare nelle loro mani
l'interpretazione della volontà divina e quindi la direzione della vita
spirituale della nazione.
Un altro aspetto, che si ricollega alla mentalità
primitiva degli Etruschi, è l'interpretazione illogica e mistica dei fenomeni
naturali, che persistendo sino in età molto recente viene a contrastare in
maniera drammatica con la razionalità scientifica dei Greci. A questo riguardo è
particolarmente significativo e rivelatore un passo di Seneca (Quaest. nat., II,
32, 2) a proposito dei fulmini: Hoc inter nos et Tuscos...interest: nos putamus,
quia nubes collisae sunt, fulmina emitti,. ipsi existimant nubes collidi, ut
fulmina emittantur," nam, cum omnia addeum referant, in ea opinionesunt, tamquam
non, quiafactasunt, significent, sed quia significatura sunt, fiant. (La
differenza fra noi [cioè il mondo ellenistico-romano] e gli Etruschi... è
questa: che noi riteniamo che i fulmini scocchino in seguito all'urto delle
nubi; essi credono che le nubi si urtino per far scoccare i fulmini; tutto
infatti attribuendo alla divinità, sono indotti ad opinare non già che le cose
abbiano un significato in quanto avvengono, ma piuttosto che esse avvengano
perche debbono avere un significato...).
L 'al di là
La mistica unità del mondo celeste e del mondo terrestre si estende
verisimilmente anche al mondo sotterraneo, nel quale è localizzato, secondo le
dottrine etrusche più evolute, il reame dei morti. Gran parte delle nostre
conoscenze sulla civiltà degli antichi Etruschi proviene, come è noto, dalle
tombe (la stragrande maggioranza delle iscrizioni è di carattere funerario; alle
pitture, alle sculture, alle suppellettili sepolcrali siamo debitori dei dati
fondamentali sullo sviluppo delle forme artistiche e sugli aspetti della vita).
Ed è naturale che le tombe ci offrano, più o meno direttamente, indizi sulle
credenze relative alla sorte futura degli uomini e sui costumi e sui riti
collegati a queste credenze. Ciò nonostante siamo ancora ben lungi dall'avere
una idea chiara dell'escatologia etrusca. Motivi complessi e contrastanti
denunciano livelli diversi di mentalità religiosa ed influenze eterogenee. Ne
risultano problemi tuttora in parte irresoluti, singolarmente
affascinanti.
Il carattere stesso delle tombe e dei loro equipaggiamenti,
soprattutto nelle fasi più antiche, offre una testimonianza inequivocabile del
persistere di concezioni primitive universalmente diffuse nel mondo
mediterraneo, secondo le quali la individualità del defunto, comunque
immaginata, sopravvive in qualche modo congiunta con le sue spoglie mortali, là
dove esse furono deposte. Ne consegue l'esigenza, fondamentale per i superstiti,
di garantire, difendere, prolungare concretamente questa sopravvivenza, non
soltanto come tributo sentimentale di affettuosa pietà, ma come obbligo
religioso non disgiunto, probabilmente, da timore. A questo genere di concezioni
appartiene in Etruria, come altrove (e segnatamente nell'antico Egitto), la
tendenza ad immaginare il sepolcro nelle forme di una casa, a dotarlo di arredi
e di oggetti d'uso, ad arricchirlo di figurazioni pregne, almeno
originariamente, di significato magico (specialmente pitture tombali con s.cene
di banchetto, di musica, di danze, di giuochi atletici, ecc.), a circondare il
cadavere delle sue vesti, dei suoi gioielli e delle sue armi; a servirlo con
cibi e bevande; ad accompagnarlo con figurine di familiari; e, infine, a
riprodurre l'immagine somatica del morto stesso, per offrire un incorruttibile
«appoggio» allo spirito minacciato dal disfacimento del corpo, onde in Etruria
(come già in Egitto) sembra nascere il ritratto funerario. Ma quale sia
l'effettiva e più profonda natura delle idee religio- se che traspariscono
esteriormente in così fatte costumanze e come esse abbiano potuto sussistere ed
evolversi accanto ad altre credenze è cosa ancora tutto sommato assai
oscura.
All'origine della storia delle città etrusche vediamo infatti
dominare pressoche esclusivo un rito funebre, quale è quello della cremazione,
che non può non riflettere concetti estranei a quelli del legame materiale tra
spirito e corpo del defunto; che anzi, almeno nella piena età storica, esso
sembra talvolta significare un'idea di «liberazione» dell'anima dai ceppi della
materia verso una sfera celeste. Tanto più curioso è osservare come nelle tombe
etrusche del periodo villanoviano e orientalizzante le ceneri e le ossa dei
morti bruciati si contengano talvolta in urne in forma di abitazioni o entro
vasi che tentano di riprodurre le fattezze del morto (i così detti "canopi" di
Chiusi): ciò che rivela, già dai tempi più antichi del formarsi della nazione
etrusca, una mescolanza di credenze e forse anche un riaffermarsi delle
tradizionifunerarie mediterranee sul costume diffuso dai seguaci della
cremazione. Ne si può affermare che l'idea della sopravvivenza nella tomba
escluda assolutamente una fede nella trasmigrazione delle anime verso un regno
dell"'al di là". Ma è certo che in Etruria quest'ultima concezione si venne
affermando e concretando progressivamente sotto l'influsso della religione e
della mitologia greca, con l'attenuarsi delle credenze primitive: e si configurò
secondo la visione dell'averno omerico, popolato da divinità ctonie, spiriti di
antichi eroi ed ombre di defunti. Già nei monumenti del Ve IV secolo, e poi
soprattutto in quelli di età ellenistica, la sorte futura è rappresentata come
un viaggio dell'anima verso il regno dei morti e come un soggiorno nel mondo
sotterraneo. Soggiorno triste, senza speranza, a volte dominato dallo spavento
che incute la presenza di mostruosi dèmoni, o addirittura dai tormenti che essi
infliggono alle anime. È, in sostanza, la materializzazione dell'angoscia della
morte in una escatologia essenzialmente primitivistica. E a simboleggiare la
morte sono specialmente due figure infernali: la dea Vanth dalle grandi ali e
con la torcia, che, simile alla greca Moira, rappresenta il fato implacabile; e
il dèmone Charun, figura semibestiale armata di un pesante martello, che può
considerarsi una paurosa deformazione del greco Caronte dal quale prende il
nome. Sia di Vanth sia di Charun esistono moltiplicazioni, forse con una propria
individualità ed un proprio secondo nome. Ma la demonologia infernale è ricca e
pittoresca, e conosce altri personaggi, come l'orripilante Tuchulcha dal volto
di avvoltoio, dalle orecchie d'asino e armato di serpenti; accoglie largamente
la simbologia di animali ctonii, come il serpente e il cavallo.
Anche per
questa fase più tardiva le fonti monumentali, nei loro aspetti frammentari ed
esteriori, sono insufficienti a darci un'idea sicura e completa delle credenze
contemporanee sull'oltretomba. Stando alle pitture e ai rilievi sepolcrali,
parrebbe che il destino dei morti fosse inesorabilmente triste ed uguale per
tutti: la legge crudele non risparmia neanche i personaggi più illustri, la cui
affermazione di superiorità si limita ai costumi sfarzosi, agli attributi delle
cariche rivestite e al seguito che li accompagna nel viaggio agli inferi.
Esistono tuttavia nella tradizione letteraria, alcuni accenni più o meno
espliciti a consolanti dottrine di salvazione, e cioè alla possibilità che le
anime conseguano uno stato di beatitudine o addirittura q i deificazione,
attraverso speciali riti che sarebbero stati descritti dagli Etruschi nei loro
Libri Acherontici. Un prezioso documento originale di queste cerimonie di
suffragio, con prescrizioni di offerte e di sacrifici a divinità specialmente
infernali, sembra esserci conservato nel testo etrusco della tegola di Capua,
che risale al V secolo a.C.. Non sappiamo fino a che punto allo sviluppo di
queste nuove concezioni escatologiche abbia contribuito il diffondersi in
Etruria di dottrine orfiche, pita- goriche e, più ancora, dionisiache (il culto
di Bacco è, in verità, largamente attestato anche in rapporto con il mondo
funerario). Comunque le speranze di salvazione sembrano restare collegate al
concetto delle operazioni magico-religiose, proprie di una spiritualità
primitiva, piuttosto che dipendere da un superiore principio etico di
retribuzione del bene compiuto in vita.
Forme del culto
Le testimonianze monumentali, i documenti scritti etruschi e i
riferimenti delle fonti letterarie classiche offrono numerosi dati per la
ricostruzione della vita religiosa e delle forme del culto. Si tratta di
costumanze che, almeno per quel che riguarda gli aspetti sostanziali (luoghi
sacri e templi, organizzazione del sacerdozio, sacrifici, preghiere, offerte di
doni votivi, ecc.), non differiscono profondamente dalle analoghe manifestazioni
del mondo greco, italico e, specialmente, romano. Ciò si spiega per un verso
considerando i comuni orientamenti spirituali della civiltà greco-italica a
partire dall'età arcaica, per altro verso tenendo conto della fortissima
influenza esercitata dalla religione etrusca su quella romana. Uno studio delle
antichità religiose etrusche non può quindi prescindere dal quadro, ben
altrimenti particolareggiato e complesso, che in materia rituale ci presentano
la Grecia e Roma: tanto più difficile è determinare i riflessi che le concezioni
proprie della mentalità religiosa etrusca ebbero, con motivi peculiari, nella
prassi del culto.
Sarà, in primo luogo, da attribuire agli Etruschi quella
concreta e quasi materialistica adesione a norme sancite ab antiquo, quel
preoccupato formalismo dei riti, quel frequente insistere sui sacrifici
espiatorii, che si avvertono nell'ambito delle tradizioni religiose romane come
un elemento in certo senso estraneo alla semplice religiosità agreste dei prisci
Latini e indizio della presenza di un fattore collaterale che non può non
riportarsi ad una antica e matura civiltà cerimoniale, quale è appunto
l'etrusca. Questa ars colendi religiones (secondo l'espressione di Livio nel
passo sopra citato) risponde in pieno al senso di subordinazione dell'uomo alla
divinità, che sappiamo predominante nella religiosità etrusca e presuppone la
fede nella efficacia magica del rito, proprio delle mentalità più primitive. La
concretezza degli atti cultuali si manifesta nella precisa determinazione dei
luoghi, dei tempi, delle persone e delle modalità, entro i quali e attraverso i
quali si compie l'azione stessa volta ad invocare o a placare la divinità:
quell'azione che i Romani chiamavano nel loro complesso res divina e gli
Etruschi probabilmente ais(u)na (cioè, appunto, servizio "divino", da ais
"dio"): donde, anche, la parola umbra esono "sacrificio". Essa si svolge nei
luoghi consacrati (tempia) dei quali si è fatta già menzione: recinti con altari
ed edifici sacri contenenti immagini delle divinità. Sovente questi edifici sono
orientati verso sud e sud-est. Il concetto di consacrazione al culto di un
determinato luogo o edificio è forse espresso in etrusco dalla parola sacni
(donde il verbo sacnisa): questa condizione può estendersi, come in Grecia e nel
mondo italico e romano, ad un complesso di recinti e templi, per esempio sulle
acropoli delle città (Marzabotto); carattere in certo senso analogo hanno anche
le tombe, presso le quali o entro le quali si compiono sacrifici funerari o si
depongono offerte.
Speciale importanza deve avere avuto in Etruria la
regolamentazione cronologica delle feste e delle cerimonie, che, insieme con le
modalità delle azioni sacre, costituiva la materia dei Libri Rituales ricordati
dalla tradizione. Il massimo testo rituale etrusco, tramandatoci nella lingua
originale -e cioè il manoscritto su tela parzialmente conservato nelle fasce
della mummia di Zagabria - contiene un vero e proprio calendario liturgico, Con
l'indicazione dei mesi e dei giorni ai quali si riportano le cerimonie
descritte. È probabile che altri documenti fossero redatti nella forma attestata
dai calendari sacri latini: e cioè come una elencazione consecutiva di giorni
contrassegnati dal solo titolo delle feste o dal nome della divinità
celebrata.
Il calendario etrusco era forse analogo al calendario romano
precesareo: conosciamo il nome di alcuni mesi e sembra che le "idi", circa a
metà del mese, abbiano un nome di origine etrusca; ma il computo dei giorni del
mese segue generalmente, a differenza del calendario romano, una numerazione
consecutiva. Ogni santuario ed ogni città doveva avere, come è logico, le sue
feste particolari: tale è appunto il caso del sacni cilfh (santuario di una
città non altrimenti identificabile), al quale fa riferimento il rituale di
Zagabria. Le celebrazioni annuali del santuario di Voltumna presso Volsinii
avevano invece carattere nazionale, come sappiamo dalla tradizione. Tra le
cerimonie e gli usi sacri può ricordarsi quello della infissione dei chiodi per
segnare gli anni (clavi annales) nel tempio della dea Nortia a Volsinii,
ricordato a proposito dell'analogo rito del tempio di Giove Capitolino a Roma.
Anche per intendere la natura e l'organizzazione dei sacerdozi siamo costretti
ad avvalerci del confronto con il mondo italico e romano.
Abbiamo in ogni
caso indizi per ritenere che essi fossero varii e specializzati, strettamente
collegati con le pubbliche magistrature e sovente riuniti in collegi. Il titolo
sacerdotale cepen (con le variante cipen attestata in Campania), particolarmente
frequente nei testi etruschi, è ad esempio seguito spesso da un attributo che ne
determina la sfera d'azione o le specifiche funzioni: come nel caso di cepen
fhaurx, che senza dubbio indica un sacerdote funerario (da fhaura «tomba»). La
dignità sacerdotale in genere o specifici sacerdozi sono designati anche con
altre parole: quali eisnevc (in rapporto con aisna, l'azione sacrificale), celu,
forse santi, ecc. Si hanno inoltre i sacerdoti divinatori: e cioè gli aruspici
(netsvis), rappresentati nei monumenti con un costume caratteristico composto di
un berretto a terminazione cilindrica e di un manto frangiato, e gl'interpreti
dei fulmini (trutnvt?). Il titolo marun-, è, come già sappiamo, in rapporto con
funzioni sacrali, per esempio nel culto di Bacco (marunux paxanati, maru
paxafhuras): si osservi il doppio titolo cepen marunuxva, che indica
probabilmente un sacerdozio con le funzioni proprie dei maru. Si può ricordare
anche il titolo zilx cexaneri, nel quale si è voluto intendere qualcosa come
"curator sacris faciundis", (ma è congettura molto opinabile). Probabilmente a
confraternite si riferiscono termini collettivi quali paxafhuras, formalmente
analoghi a quelli che esprimono aggregati gentilizi (per es. Velfhinafhuras nel
senso dei membri della famiglia Velfhina) o altri collegi.
A Tarquinia
esisteva in età romana un arda LX haruspicum veri similmente di antica origine.
Uno degli attributi dei sacerdoti era illituo, bastone dall'estremità ricurva,
che è però frequentemente rappresentato nei monumenti anche in rapporto ad
attività profane, per esempio in mano ai giudici delle gare atletiche. L 'azione
del culto è volta ad interrogare la volontà degli dèi, secondo le norme
dell'arte divinatoria; e quindi ad invocare il loro aiuto e perdono attraverso
l'offerta. È probabile che l'una e l'altra operazione fossero strettamente
collegate tra loro; benche sia ricordata dalle fonti letterarie una distinzione
tra vittime sacrificate per la consultazione delle viscere (hastiae
cansultatariae) e vittime destinate all'offerta vera e propria, in sostituzione
dei sacrifici umani (hastiae animales). Del pari intrecciate in complicati
cerimoniali sembrano le offerte incruente (di liquidi e cibi) con quelle cruente
di animali. Il grande rituale di Zagabria e il rituale funerario della Tegola di
Capua descrivevano minuziosamente, in tono prescrittivo e con un linguaggio
tecnico specializzato, queste liturgie; ma lo stato delle nostre cognizioni
della lingua etrusca non ci consente di stabilire con esattezza il significato
di molti 'termini impiegati nella descrizione dei riti e, pertanto, di
ricostruirne in pieno lo svolgimento. La preghiera, la musica, la danza dovevano
avere larga parte nelle cerimonie. Una scena di culto con offerte è
rappresentata nella parete di fondo della Tomba del Letto Funebre di
Tarquinia.
I doni votivi offerti nei santuari, per grazie chieste o ricevute,
consistono per lo più di statue di bronzo, pietra, terracotta, raffiguranti le
divinità stesse e gli offerenti, o anche animali, in sostituzione delle vittime,
e parti del corpo umano; inoltre vasi, armi, ecc. Questi oggetti che erano
ammassati in depositi o favisse, recano spesso iscrizioni dedicatorie. Essi
variano per valore artistico e per pregio (la massima parte è costituita da
modeste figuri ne di terracotta lavorate a stampo): ciò che indica, intorno ai
grandi centri del culto, una diffusa e profonda religiosità
popolare.
Il culto degli dei e dei defunti
Dopo che i sacerdoti avevano ottenuto attraverso la divinazione la
conoscenza del volere divino, si dava attuazione a tutto ciò che ne derivava dal
punto di vista del comportamento, sulla base delle norme che facevano anch'esse
parte della ''disciplina etrusca" ed erano oggetto di trattazione nei Libri
Rituales. Queste norme si traducevano (e si esaurivano) in una serie
impressionante di pratiche, cerimonie e riti rigidamente codificati e ripetuti
meccanicamente fino a diventare puro e semplice formalismo. Essi toccavano sia
gli aspetti religiosi della vita degli etruschi sia quelli civili, secondo il
principio che ''ogni azione umana doveva essere compiuta in conformità della
disciplina". E per ogni rito, cerimonia di culto o servizio divino doveva essere
stabilito con precisione il luogo, il tempo, il modo, lo scopo, la persona
preposta e, naturalmente, la divinità che veniva chiamata in causa. Le funzioni
sacre si svolgevano perciò in luoghi rigidamente circoscritti e consacrati
(templi, santuari, altari) e il loro svolgimento era codificato fin nei minimi
particolari tanto che, se veniva sbagliato od omesso anche un solo gesto, tutta
l'azione doveva essere ripetuta da capo. Musica e danza vi trovavano ampio
spazio. Oltre all'uso di sacrificare bovini, ovini e volatili, particolarmente
diffuso era quello dei doni votivi che potevano andare dagli ex voto (statue e
statuine di divinità e di offerenti), alle prede di guerra (armi, carri), agli
stessi edifici sacri (dedicazione di un tempio o di un sacello).
Tra le
pratiche di carattere religioso quelle destinate ai defunti avevano presso gli
etruschi un carattere tutto particolare. Esse erano legate alla concezione (del
resto diffusa in altre civiltà del Mediterraneo) che l'attività vitale del
defunto, la sua ''individualità" continuasse anche dopo la morte e che questa
sopravvivenza avesse luogo nella tomba. Spettava però ai vivi, ai familiari e
dei parenti, garantire la sopravvivenza dell'entità vitale del defunto al quale
doveva essere data una tomba, cioè una nuova casa, e un corredo di abiti,
oggetti d'uso personali, cibi, di cui si serviva simbolicamente o magicamente.
Per la stessa ragione vitalità e forza venivano trasmesse al defunto con giochi
e gare atletiche che si svolgevano in occasione dei funerali o delle ricorrenze
anniversarie della morte. Quanto alle pratiche proprie dei funerali, la prassi
non era dissimile da quella che avveniva altrove: esposizione del cadavere al
compianto pubblico e alle lamentazioni di donne appositamente pagate (prefiche),
corteo funebre e banchetto presso la tomba. Il culto della ''sopravvivenza" nel
sepolcro era ulteriormente sviluppato nel culto degli antenati e in particolar
modo del capostipite, specie delle famiglie gentilizie. Tra il V e il IV secolo
a.C., però, la fede della sopravvivenza del morto nella tomba cambiò sotto
l'effetto delle suggestioni provenienti dalla civiltà greca. Ad essa si sostituì
la concezione di un ''mondo dei morti" (simile all'Averno o all'Ade) dove le
''ombre" soggiornavano. Ai defunti vennero allora dedicati particolari riti di
suffragio, stabiliti dai Libri Acherontici, e offerte alle divinità infere (in
particolare il sangue di alcuni animali) che potevano consentire alle anime il
conseguimento di uno speciale stato di beatitudine.
La
''disciplina etrusca"
Secondo gli etruschi gli dèi condizionavano il
mondo e ogni azione umana: occorreva quindi ''tradurre" la loro volontà andando
in cerca dei segni attraverso i quali essa si manifestava. Perciò era necessario
avere a disposizione un codice che interpretasse quei segni e un prontuario di
norme precise e costanti che per ogni segno indicasse il conseguente
comportamento atto a soddisfare (e quindi a seguire) la volontà degli dèi.
Questo complesso di conoscenze fu chiamato dai romani ''disciplina etrusca" i
cui principi ispiratori erano fatti risalire dagli etruschi all'intervento
rivelatore della stessa divinità. Essa si sarebbe servita di esseri mitici o
semidei (come il fanciullo Tagete o la ninfa Vegoe) i quali avrebbero ''dettato"
le verità soprannaturali e insegnato agli uomini l'arte di avvicinarsi ad esse:
in pratica la divinazione. Appositi collegi sacerdotali, che si tramandavano la
professione di padre in figlio, erano preposti all'interpretazione dei segni
della volontà divine: i fulguratores osservavano le traiettorie dei fulmini, gli
àuguri interpretavano i voli degli uccelli, gli arùspici leggevano il fegato
delle pecore e di altri animali sacrificati.
Le dottrine divinatorie, e tutte
le altre che formavano il corpus minuzioso e vastissimo dei riti etruschi, erano
tramandati nei testi della cosiddetta ''disciplina etrusca": i Libri
Haruspicini, svelati dal fanciullo Tagete, trattavano la consultazione delle
viscere degli animali; i Libri Fulguratores, il cui contenuto era stato
manifestato dalla ninfa Vegoe, riguardavano la scienza dei fulmini; i Libri
Rituales, svelati anch'essi dalla ninfa Vegoe, trattavano della suddivisione
della volta celeste, della gromatica (ripartizione dei campi), dei riti e delle
modalità per la fondazione delle città e per la consacrazione dei santuari, e
infine degli ordinamenti civili e militari. Esistevano poi i Libri Acherontici,
svelati da Tagete, che esponevano le credenze nell'oltretomba e dettavano le
norme per i riti di salvazione. Infine v'erano i Libri Fatales, nei quali si
trattava dei dieci secoli di vita assegnati dal Fato alla nazione etrusca, e i
Libri Ostentaria che trattavano dell'interpretazione dei prodigi e dei fenomeni
naturali.
L’interpretazione dei fulmini e delle
viscere
L’interpretazione dei fulmini
L’osservazione e
l’interpretazione dei fulmini era regolata da una casistica alquanto complessa.
Grande importanza avevano il luogo e il giorno in cui essi apparivano, ma anche
la forma, il colore e gli effetti provocati. Le varie divinità che avevano la
facoltà di lanciarli disponevano, ciascuna, di un solo fulmine alla volta,
mentre Tinia ne aveva a disposizione tre.
Il primo era il fulmine
“ammonitore” che il dio lanciava di sua spontanea volontà e veniva interpretato
come avvertimento; il secondo era il fulmine che “atterrisce” ed era considerato
manifestazione d’ira; il terzo era il fulmine “devastatore”, motivo di
annientamento e di trasformazione: Seneca scrive che esso “devasta tutto ciò su
cui cade e trasforma ogni stato di cose che trova, sia pubbliche che private”. I
fulmini erano variamente classificati a seconda che il loro avviso valesse per
tutta la vita o solamente per un periodo determinato oppure per un tempo diverso
da quello della caduta. C’era poi il fulmine che scoppiava a ciel sereno, senza
che alcuno pensasse o facesse nulla, e questo, sempre stando a quel che dice
Seneca, “o minaccia o promette o avverte”; quindi quello che “fora”, sottile e
senza danni; quello che “schianta”; quello che “brucia”, ecc. Ma Seneca parla
anche di fulmini che andavano in aiuto di chi li osservava, che recavano invece
danno, che esortavano a compiere un sacrificio, ecc. Con un tale groviglio di
possibilità, solo i sacerdoti esperti potevano sbrogliarsi. Plinio il Vecchio
arriva ad affermare che un sacerdote esperto poteva anche riuscire a scongiurare
la caduta di un fulmine o, al contrario, riuscire con speciali preghiere, ad
ottenerla.
Resta da dire che dopo la caduta di un fulmine c’era l’obbligo di
costruire per esso una tomba: un piccolo pozzo, ricoperto da un tumuletto di
terra, in cui dovevano essere accuratamente sepolti tutti i resti delle cose che
il fulmine stesso aveva colpito, compresi gli eventuali cadaveri di persone
uccise dalla scarica. Naturalmente, il luogo e la tomba erano considerati sacri
e inviolabili ed essendo ritenuto di cattivo auspicio calpestarli, erano
recintati e accuratamente evitati dalla gente, quali “nefasti da sfuggire”, come
scriveva nel I secolo d.C. il poeta romano Persio originario dell’etrusca
Volterra.
L’interpretazione delle viscere
Le viscere degli
animali di cui si servivano gli Aruspici (dette in latino exta) erano di diverso
tipo: polmoni, milza, cuore, ma specialmente fegato (in latino hepas). Esse
venivano strappate ancora palpitanti dal corpo degli animali appena uccisi ed
espressamente riservati alla consultazione divinatoria e quindi distinti da
quelli immolati per il sacrificio. Esse venivano strappate ancora palpitanti dal
corpo degli animali appena uccisi ed espressamente riservati alla consultazione
divinatoria e quindi distinti da quelli immolati per i sacrifici. Si trattava in
genere di buoi e talvolta anche di cavalli ma soprattutto di pecore.
Delle
viscere dovevano essere prese in considerazione la forma, le dimensioni, il
colore ed ogni minimo particolare, specialmente gli eventuali difetti. Quando
non rivelavano nulla di apprezzabile per la divinazione, erano ritenute “mute” e
inutilizzabili; erano invece “adiutorie” quando indicavano qualche rimedio per
scampare ad un pericolo; “regali” se promettevano onori ai potenti, eredità ai
privati, ecc.; “pestifere” quando minacciavano lutti e disgrazie. L’osservazione
era più minuziosa nel caso del fegato, dato che in esso, per l’aspetto generale
e per la particolare conformazione, veniva riconosciuto il “tempio terrestre”
corrispondente al “tempio celeste”. La sua importanza era del resto connessa
alla credenza diffusa presso gli antichi che esso fosse la sede degli affetti,
del coraggio, dell’ira e dell’intelligenza. Ritenuto che nel fegato fosse
esattamente proiettata la divisione della volta celeste, si trattava di
riconoscere a quale delle caselle di quella corrispondessero, nel fegato, le
irregolarità. Le imperfezioni, i segni particolari o anche le regolarità, e
quindi prendere in considerazione i messaggi della divinità che occupava la
casella interessata. Per meglio riuscire nell’intento, per l’istruzione dei
giovani aruspici, venivano utilizzati degli appositi modelli di fegato, in
bronzo o in terracotta, sui quali erano riprodotte le varie ripartizioni e
scritti i nomi delle diverse divinità.
L’osservazione
dei prodigi
La fama di insuperabili interpreti di viscere e fulmini,
della quale godevano gli Etruschi, era completata da quella che li riteneva
anche esperti conoscitori del significato di ogni genere di prodigi. Il romano
Varrone, che desumeva evidentemente da fonti etrusche, riferisce che tra i
prodigi si distinguevano l’ostentum, che prediceva il futuro; il “prodigio”, che
indicava il da farsi; il “miracolo”, che manifestava qualcosa di straordinario;
il “mostro”, che dava un avvertimento. Tra i prodigi più frequenti erano
annoverati la pioggia di sangue, la pioggia di pietre e quella di latte, gli
animali che parlavano, la grandine, le comete, le statue che sudavano, ecc. In
aggiunta alle manifestazioni di carattere straordinario, nelle categorie dei
prodigi rientravano anche fatti del tutto naturali: c’erano perciò alberi e
animali “felici” o “infelici”, cioè portatori di cattivo o di buon auspicio,
piante commestibili che portavano bene e piante selvatiche che portavano male.
La casistica era infinita: ad essa tutti prestavano in genere molta attenzione,
magari per tradizione o per rispetto della comune opinione.
Libri Fulgurales
Seneca (II 32 ss.) e Plinio (II,135 ss:) hanno
conservato una larga parte di excepta dai libri fulgorales etruschi e della loro
minuziosa casistica (soprattutto delle opere del volterrano Cecina). Il
principio basilare e' quello secondo il quale: alcuni Dei posseggono le
Manubiae, ovvero le potesta' di scagliare i fulmini.(Serv. Aen. I,42.) In
particolare 9 dei (Plin. n. h.,II,138), forse da identificare con i misteriosi
dii novensiles o novensides della lista di Marziano Capella, ma noti anche in
dediche romane.
I tipi di Fulmine sono 11 per 9 Dei, perche' Tinia (Tin =
Giove) possiede 3 manubiae. (Plin. n.h., II, 138; Sen. n.q. II,41) Le 3 manubie
possono distinguersi per il loro significato e per il fatto di essere scagliati
da Giove da solo o con il "consiglio" degli altri Dei.
Prima
manubia del Solo Tinia
Seconda manubia di Tinia + i 12 Dei
Consentes
Terza Manubia di Tinai + Dei Involuti
I 3 tipi di
fulmini possono essere di natura fisica (Fest. p. 114 L; Sen. n.q. II, 40)
oppure per alcuni (Serv. auct. Aen. VIII, 429)
ostentatorium =
dimostrativo
(dopo consultazione con i 12 Dei Consentes. Segno di Ira degli
Dei.Utile e dannoso serve per impaurire).
peremptorium = perentorio
(Dopo
consultazione con i Dei superiores et involuti. Devasta. Indica che tutto verra'
radicalmente trasforamato nella vita pubblica o privata.)
presagum = presago
(Di avvertimento per suadere (convincere) o dissuadere (far cambiare
idea)).
Da Seneca ..manubia placata est et ipsius concilio iovis
mittitur.
oppure per altri (Serv. Aen. I, 230)
quod terreat = che
atterisce
quod adflet = che soffia
quod puniat = che punisce
Degli
altri 9 Dei abbiamo solo degli indizi,dalle fonti letterari, per 5 di essi:
Uni = Giunone
Menerva = (Mnrva,Menrua,Meneruva,Merva,Merua,Mera)=
Minerva
Sethlans = Vulcano
Mari = (Mars,Maris) Marte
Satres =
(Satrs) Saturno
La dottrina romana del fulmine attribuiva i fulmini notturni
a Summanus e tenendo conto del fegato di Piacenza e cio' che dice Capella
probabilmente il corrispondente etrusco potrebbe essere Cilen - Nocturnus.
Mentre l'identita' tra Vetisl etrusco e Vediovis o Veiovis romano farebbe
attribuire a questo una manubia infera, anche in considerazione di uno Zeus
sbarbato munito di fulmine frequente nella iconografia etrusca. Anche per i
fulmini vale la dottrina delle 16 regioni che vale per l'epatoscopia.(Plin. n.h.
II, 143)
L'esame del fulmine (e del tuono) da parte dell'aruspice prevedeva
una casitica precisa, enunciataci da Seneca (n.q. II ,48 ,2 ):
1- Da parte di
quale Dio proviene
2- quale = di che tipo e'
3- quantum = la durata
4-
ubi factum sit, cui = l' oggetto colpito
5- quando, in qua re = in che
circostanza
Per quel che riguarda il tipo:
1 - di che colore era il
fulmine
manubiae albae = bianche = forse di Tinia
manubiae nigrae = nere =
di Sethlans
manubiae rubrae = rosse = forse di Mari
Provenienti dai
Pianeti associati al nome divino e non dal Dio.
I fulmini provenienti da
Satres provenivano anche dalla Terra in inverno ed erano detti Infernali.
2 -
genus:
l' acre del fulmine, il grave del tuono, intensita' e capacita'
erano di 3 tipi:
quod terebrat = che perfora,sottile e
fiammeggiante.
quod dissipat = che si disperde,passante,capace di rompere
senza perforare.
quod urit = che brucia in 3 modi
come un soffio (afflat)
e senza grave danno bruciando dando fuoco
3 - C' erano fulmini Secchi -
Umidi e Clarum (Plinio)
Per quel che riguarda l'oggetto colpito i fulmini
possono essere
fatidica = cioe' portatori espressi di segni eventualmente
comprensibili (fata)
bruta = privi di significato
vana = il cui
significato si perde
l'oggetto puo' essere
schiantato = discutere
non
rompersi = terebrare
essere + o - affumicato = urere
restare affumicato =
fuscare
Per quel che riguarda l'auruspice Seneca dice che il sacerdote
procedeva
con l'analisi sistematica = quomodo exploremus
con
l'interpetazione dei segni = quomodo interpretemus
con l'espiazione,
propiziazione e purificazione = quomodo exoremus
Ma soprattuto il sacerdote
non era solo in grado di leggere i segni
ma anche di evocarli con l'attirare
(exorare) il fulmine.
L'arte della divinazione
Il segno più importante, la ''voce" più potente della divinità era il
fulmine, che proveniva direttamente dal dio supremo Tinia; l'ars fulguratoria,
cioè quella di trarre dalla sua osservazione tutte le informazioni possibili,
era quindi al primo posto nella divinazione etrusca. Era regolata da una
casistica alquanto complessa che teneva conto della parte del cielo in cui il
fulmine appariva (la volta celeste era divisa in sedici parti, abitata ognuna da
una divinità), della forma, del colore, degli effetti provocati e del giorno
della caduta. Oltre all'osservazione dei fulmini (cheraunoscopia) c'era un'altra
forma di divinazione molto generalizzata alla quale era possibile ricorrere ogni
volta che fosse ritenuto utile o necessario senza dover attendere altre forme di
prodigi dipendenti invece dal caso, come appunto il fulmine. Era l'epatoscopia,
o lettura del fegato degli animali sacrificati, che i romani chiamavano
haruspicina. Il fegato, la cui immagine si riteneva fosse proiettata la
divisione della volta celeste, veniva strappato ancora palpitante dal corpo
dell'animale (pecora, bue, cavallo) e se ne osservavano le regolarità e
irregolarità a ognuna delle quali era attribuito un messaggio. Per questo
venivano usati degli appositi modelli in bronzo o in terracotta sui quali erano
riprodotte le varie ripartizioni e scritti i nomi delle divinità. Fra i modelli
giunti sino a noi il più celebre è il ''Fegato di Piacenza". Oltre al fegato gli
arùspici leggevano anche altre viscere come il cuore, i polmoni, la
milza.
Il rito di fondazione
Fra i dettami
della disciplina etrusca famoso in tutta l'antichità era quello della fondazione
di città per il quale erano previste meticolosissime disposizioni. Gli aùguri
cominciavano col delimitare una porzione di cielo consacrata proprio in funzione
del rito (e definita con il termine significativo di templum) all'interno della
quale trarre gli auspici dedotti dal volo degli uccelli che la attraversavano,
dai fenomeni meteorologici che in quel perimetro potevano verificarsi, o da
altre manifestazione considerate provenienti dalle divinità. Erano poi
individuati il centro della città stessa e delle principali direttrici viarie
scavando fosse in cui venivano deposte offerte e sovrapposti cippi che fungevano
sia da punti di riferimento sia da luoghi sacrali. Veniva poi tracciato con un
aratro dal vomere di bronzo un solco continuo che disegnava il perimetro delle
mura, interrotto solo là dove si sarebbero aperte le porte delle città; il solco
diventava subito linea inviolabile per tutti gli uomini e attraversarlo
equivaleva ad attaccare la città. Lungo tutto il perimetro delle mura correva
inoltre, tanto all'esterno quanto all'interno, un'ampia fascia di terreno (il
pomerium) che non doveva essere né coltivata né edificata e che era dedicata
alla divinità. Una solenne cerimonia di sacrificio inaugurava la città così
prefigurata. La fondazione di Roma a opera di Romolo e Remo così come ce l'hanno
tramandata le leggende è un'applicazione puntuale del rito etrusco: i gemelli
che osservano il volo degli uccelli per decidere chi dei due dovesse dare il
nome alla città, il solco tracciato da Romolo, l'uccisione di Remo che, saltando
all'interno del perimetro, profana i sacri confini e ''invade" la nuova
fondazione.
Le pratiche rituali
Dal
momento che con le arti divinatorie veniva raggiunta la conoscenza del volere
divino, si trattava di dare attuazione a tutto ciò che ne derivava dal punto di
vista del comportamento. Occorreva cioè agire sulla base delle norme prescritte
dalla “disciplina” e oggetto della trattazione specifica dei “libri rituali”.
Tali norme si traducevano in una serie interminabile di pratiche, di cerimonie,
di riti. Si dovevano perciò determinare i luoghi, i tempi e i modi nei quali e
con i quali doveva essere eseguito quello che veniva chiamato il “servizio
divino” (aisuna o aisna, da ais che significa dio), nell’indicazione delle
persone alle quali l’azione competeva e, naturalmente, prima di tutto, della
divinità alla quale essa era dedicata. I luoghi dovevano essere circoscritti,
delimitati e consacrati; i tempi regolati dalla successione cronologica delle
feste e delle cerimonie previste ed elencate nei calendari sacri; i modi
rispettati fin nei minimi particolari, tanto che, qualora fosse stato sbagliato
oppure omesso un solo gesto, tutta l’azione avrebbe dovuto essere ripresa da
capo. Nelle funzioni trovavano ampio spazio la musica e la danza; le preghiere
potevano essere d’espiazione, di ringraziamento o di invocazione; i sacrifici
cruenti riguardavano particolari categorie di animali; le offerte comprendevano
prodotti della terra, vino, focacce e altri cibi preparati.
Particolarmente
diffusa, tanto a livello di religiosità “ufficiale” quanto a livello di
religiosità popolare, era l’usanza dei doni votivi. Nel primo caso poteva
trattarsi di statue o altre opere d’arte, di oggetti particolarmente preziosi,
di prede di guerra e di edifici sacri; nel secondo caso i doni erano solitamente
piccoli oggetti, per lo più di terracotta (ma anche di bronzo, di cera e mollica
di pane) che i fedeli compravano nelle apposite rivendite presso i
santuari.
Il rituale funerario
Durante il
periodo villanoviano, il corpo del defunto era spesso cremato; le sue ossa
combuste venivano raccolte in un apposito vaso che per la sua forma gli
archeologi hanno chiamato "biconico", poichè costituito da due coni
contrapposti, collegati per le basi (museo archeologico-topografico, sala di
Roselle ecc.). In genere, questo contenitore ha soltanto un' ansa (quando ve
n'erano due, una veniva ritualmente spezzata). Inoltre, la sua bocca è coperta
da una ciotola, anch'essa munita di una sola ansa; oppure, nel caso che il
defunto fosse appartenuto alla classe dei guerrieri, è talvolta coperta da un
elmo. Il vaso e il corredo funebre, composto dagli oggetti più cari al defunto,
vengono deposti in un "pozzetto", scavato appositamente nel terreno; talvolta,
le sue pareti vengono foderate con lastre di pietra e l'apertura ne è chiusa con
un lastrone. In alcune zone dell'Etruria d'epoca villanoviana i cinerari hanno
la forma di capanna, le cosiddette "urne a capanna" appunto (museo
archeologico-topografico, sala di Vetulonia), quasi a voler ricostruire per il
defunto la sua casa terrena.
Il corredo mostra alcune differenze, soprattutto
a livello di sesso: spesso la presenza di un rasoio distingue la deposizione
dell'uomo, mentre quella della donna è evidenziata da oggetti usati per la
filatura, come un fuso o una fuseruola. Successivamente, nell'VIlI secolo a.C.
il corredo che accompagna il defunto diventa più prezioso, aumentano gli oggetti
di metallo, soprattutto in bronzo, e compa- provenienti dalla Grecia; cominciano
inoltre altri tipi di sepolture, contraddistinte da dimensioni maggiori, come le
tombe a fossa, nelle quali viene deposto il defunto inumato. Con l'inizio di
questo tipo di sepoltura, il rito cambia; in- fatti, il corpo del defunto non è
cremato, ma è deposto in una fossa scavata nel terreno, munita talvolta di
pareti foderate con lastre di pietra -Sovana-, come i "pozzetti". In alcune aree
dell'Etruria, per esempio a Vetulonia, più tombe di questo tipo vengono riunite
entro circoli di pietre, quasi a voler tener uniti i membri di una medesima
famiglia.
La differente ricchezza presente nei contesti funebri è un dato
molto importante perche segnala, all'interno della società etrusca, il formarsi
di una diversa stratificazione sociale rispetto alla più omogenea situazione del
periodo villanoviano. Nel periodo orientalizzante, nel VII secolo a.C., troviamo
tombe costruite o scavate nella roccia; la scelta fra le due possibilità è
dovuta ai diversi tipi di formazione geologica presenti nelle differenti aree e,
per molti decenni, i membri di una stessa famiglia (gens) vengono sepolti
all'interno di una medesima tomba . I corredi raggiungono talora livelli di
ricchezza eccezionali; la tomba assume carattere monumentale, manifestando così
la potenza della famiglia a cui appartiene. Un lungo dròmos (corridoio) porta
all'interno della tomba, in cui è scavata o costruita la camera funeraria
sotterranea; all'esterno la protegge un tumulo artificiale di terra, contenuto
da un "tamburo" (un muro circolare) di pietra. Dal VI secolo a.C. diminuiscono
le dimensioni delle tombe, scompare il loro aspetto monumentale e si assiste
talvolta a una specie di "pianificazione edilizia" all'interno della necropoli,
come quella della Necropoli del Crocifisso del Tufo a Orvieto. Il dato
archeologico ci fa comprendere, in tale caso, che la grande aristocrazia, quella
proprietaria dei monumentali tumuli, ha perso potere in quest'area, lasciando
spazio a un ceto medio. Le costruzioni monumentali permangono in uso solo in
alcune zone dell'Etruria. A Populonia troviamo nella seconda metà del VI secolo
un tipo di costruzione piuttosto origi nale, la cosiddetta "tomba a edicola", il
cui esterno è simile a una piccola casa munita di un tetto a doppio
spiovente.
Nel periodo ellenistico ci sono ancora tombe di proporzioni
monumentali, come quelle di Sovana o di Norchia, le note e affascinanti tombe
rupestri scavate nella roccia tufacea. Le loro facciate imitano quelle dei
templi o dei palazzi, come si rileva per la tomba Ildebranda a Sovana.
S'intendeva evidentemente eroizzare il defunto, deponendo il suo corpo
all'interno di un vero e proprio "tempio"; vicino alla tomba vi possono essere
altari per le celebrazioni cultuali dei defunti. Nello stesso periodo, a
Volterra le tombe vengono scavate nella roccia tufacea; sulle loro banchine,
ricavate nella pietra, troviamo urne contenenti le "ceneri" dei defunti di una
medesima gens . Tali "urnette", prodotte dalle botteghe locali in alabastro o
tufo, sono decorate sulla cassa con rilievi più o meno alti, raffiguranti scene
mitologiche tratte dal repertorio greco (Iliade, Odissea, ecc. ) oppure legati
al mondo etrusco (il congedo del defunto dai propri cari, mostri dell'aldilà
ecc.). Il coperchio "rappresenta" in genere il defunto/a disteso sul letto da
banchetto. Il viso della persona effigiata non è inteso quale ritratto nel senso
proprio del termine, ma piuttosto una “tipologia” di volto, che raffigura per
esempio una "giovane donna" oppure un "uomo anziano".
Nel II secolo a.C.,
accanto a questo tipo di urna cineraria, rivolta a una committenza appartenente
a un ceto "medio", compaiono urnette in terracotta, provenienti dal territorio
di Chiusi, realizzate a matrice e deposte in tombe a "nicchiotto" semplicemente
scavate. Furono fatte per una classe sociale economicamente meno rilevante, che
tuttavia ebbe notevole fortuna politica nell'Etruria Settentrionale del tempo.
In alto, sulla cassa, è scritto il nome del defunto, a testimoniare la
diffusione dell'alfabetizzazione, ormai raggiunta anche da ceti sociali
"subalterni".
L'antropomorfizzazione e le statue cinerario
Il
Museo Archeologico di Firenze rivela al visitatore un aspetto interessante della
civiltà etrusca, talvolta non del tutto conosciuto. Il fenomeno riguarda in
particolare la città di Chiusi, le cui manifestazioni connesse all'arte e
all'artigianato rivelano, già nel VII secolo a.C., una tendenza
all'antropomorfizzazione: i vasi canopi. Sono ossuari realizzati in genere con
ceramica di impasto, ma talvolta anche in metallo (bronzo), cinerari che
presentano per coperchio una raffigura zione stilizzata della testa del defunto;
qualche volta, il "vaso" ha due piccole braccia disegnate a rilievo e può essere
collocato sulla rappresentazione miniaturizzata di un sedile (Museo
archeologico-topografico, sala di Chiusi). Qualcosa di simile troviamo anche nel
periodo Villanoviano, quando per coperchio del vaso biconico è posto un elmo,
quasi a voler restituire un 'integrità fisica al defunto.
Successivamente,
nel V secolo a.C., questa tendenza diventa ancora più evidente con la presenza,
sempre nella città di Chiusi, di statue cinerario: grandi sculture, come quella
della Mater Matuta, scolpite in pietra, che ospitano in una cavità interna le
"cene ri" del defunto, mentre la testa amovibile della statua funge da
"chiusura”.
La tomba come casa del defunto
Gli scavi archeologici
delle necropoli ci hanno fornito molti dati sulla civiltà etrusca. Un fattore
costante nell'ideologia funeraria etru- sca risulta la tomba, sentita come
dimora del defunto. Abbiamo già riferito di alcune urne cinerarie conformate "a
capanna", ma anche taluni monumenti funerari possono denotare questo aspetto.
L'ingresso della tomba può essere costituito da una porta in pietra con tanto di
battenti e, a guardia di essa come a custodia di un'abitazione terrena, sono
poste statue di animali fantastici, quali sfingi leonine, o più vicini alla
realtà, come i leoni; oppure, a testimonianza dell' importanza del defunto,
troviamo statue rigididamente composte di prefiche. Talvolta le camere
sotterranee delle tombe gentilizie riproducono fedelmente la pianta e l'interno
di un'abitazione, il cui "arredo" viene allora "scolpito" nell'interno: sedie,
letti, porte modanate, le stesse suppellettili, nonche i tetti a doppio
spiovente con l'orditura delle travi del soffitto. Medesima decorazione si
riscontra nella forma e nel coperchio di alcune urne cinerarie, che hanno l'
aspetto esteriore identico a quello di una casa. Da tutto ciò emerge chiaramente
l'immagine di un mondo dell'aldilà molto prossimo a quello terreno. Gli oggetti
che facevano parte del corredo funebre testimoniano la volontà degli Etruschi di
ricreare nell'oltretomba la realtà di ogni giorno. Un'ulteriore testimonianza di
ciò è notoriamente rappresentata dalle pitture delle tombe, che spesso
riproducono scene di vita quotidiana e in particolare di
banchetto.
Il culto dei morti
Tra le pratiche
di carattere religioso, un posto del tutto particolare occupavano quelle che
avevano come destinatari i defunti. Nei primi tempi, esse erano legate alla
concezione della continuazione dopo la morte di una speciale attività vitale del
defunto. A tale concezione si accompagnava l’idea che quell’attività avesse
luogo nella tomba e fosse in qualche modo congiunta alle spoglie mortali. Dato
però che tutto dipendeva dalla collaborazione dei vivi, i familiari del defunto
erano tenuti a garantire, agevolare e prolungare per quanto possibile la
“sopravvivenza” con adeguati provvedimenti.
La prima esigenza da soddisfare
era quella di dare al morto una tomba, che sarebbe diventata la sua nuova casa;
subito dopo veniva quella di fornirgli un corredo di abiti, ornamenti, oggetti
d’uso e, insieme, una scorta di cibi e bevande. Il resto era un arricchimento e
poteva variare a seconda del rango sociale del defunto e delle possibilità
economiche degli eredi. Si poteva così foggiare la tomba nell’aspetto sia pure
parziale o soltanto allusivo della casa, e dotarla di suppellettili e arredi, e
magari affrescarla sulle pareti con scene della vita quotidiana o dei momenti
più significativi della vita del defunto. Quanto alle pratiche proprie dei
funerali, esse andavano dall’esposizione al compianto pubblico al corteo funebre
al banchetto davanti alla tomba. Tutte queste pratiche, insieme alle cerimonie e
ai riti che dovevano essere compiuti in onore di divinità connesse con la sfera
funeraria, facevano parte di un autentico culto dei morti, sacro da rispettare e
da venerare. La situazione tuttavia cambiò con il tempo: infatti, per effetto
delle suggestioni provenienti dal mondo greco, nel corso del V secolo a .C.,
alla primitiva fede di sopravvivenza del morto nella tomba, si sostituì l’idea
di uno speciale regno dei morti. Questo fu immaginato sul modello dell’Averno (o
Acheronte) greco, il regno dei morti, governato dalla coppia divina di Aita e
Phersipnai (Ade e Persefone greci).
ALCUNE OPERE:
ARRINGATORE
Tratto
dal testo della sovrintendenza del Museo Archeologico di Firenze
Provenienza: Il grande bronzo entrò a far parte, nel 1566, delle collezioni
del Granduca Cosimo de' Medici. Scrive a tal proposito Vasari, in una lettera
datata 20 settembre 1566, al Borghini: "Il Duca ha avuto una statua di bronzo
intera che non gli manca niente, d'uno Scipione Minore" - (l 'identificazione
era errata) -"di braccia 3 incirca in atto di locuzione". Non conosciute le
circostanze del recupero, il luogo di rinvenimento rimane incerto tra quello
tradizionale, Sanguineto (PG) sulla riva settentrionale del lago Trasimeno, e
Pila, presso Perugia, località emersa da fonti archivistiche.
Stato di
conservazione e tecnica: grande statua in bronzo eseguita con tecnica a cera
perduta, a fusione cava, in sette parti (testa e collo, tronco in due pezzi,
braccio destro, mano sinistra, le due gambe) poi saldate e, nel caso delle
gambe, inferiormente piene per maggior robustezza, fissate con chiodi alla toga.
Gli occhi, in diverso materiale (avorio, osso e/o pasta vitrea) erano inseriti a
parte e sono oggi perduti. Ciocche di capelli, bordi della toga, iscrizione ed
altri particolari sono incisi. La mano destra fu spezzata al momento del primo
rinvenimento.
Datazione: primi decenni del I sec. avanti Cristo.
Soggetto: la statua, a grandezza naturale, rappresenta un uomo maturo, con i
capelli aderenti alla testa pettinati a ciocche, vestito di una corta toga (toga
exigua), praetexta, e, a contatto con la pelle, di una tunica bordata da una
stretta banda (angustus clavus; vedi il braccio destro). Indossa dei calzari
(calcei). Il suo rango è dichiarato dall' anello che porta alla sinistra.
La
destra è alzata, la mano aperta nel gesto del silentium manu lacere: il
personaggio è ritratto nel momento in cui, apprestandosi a parlare in pubblico,
chiede l'attenzione, di qui il nome con cui la statua è universalmente nota,
l"'arringatore".
Il personaggio, un etrusco, come vedremo
dall'iscrizione, si atteggia e veste ormai alla maniera romana: la sua veste,
pur riportabile alla tebenna etrusca, è ormai accostabile alla toga romana; i
calzari presentano la caratteristica linguetta (lìngula) e le corregge
(corrigiae) dei calcei senatorii romani.
L'iscrizione: incisa su tre
righe sul bordo della toga, è un 'iscrizione di carattere "pubblico": la grafia
è composta e ben curata, le lettere presentano appendici (apicature) destinate a
renderle più belle e ricercate. Il tipo di alfabeto usato è quello presente, in
epoca tardo etrusca, nell 'area di Chiusi e Cortona.
aulesi .metelis
.ve. vesial. clensi cen .jleres .tece .sansl. terine tu ines .chisvlics
così interpretabile: "per Aule Metelifiglio di Vel e di una Vesiquesto
(oggetto sacro) al dio Tece Padre è posto (o simile) dal pago (o vico) di
Chiusuli". Certa è l'interpretazione della prima riga, incerta quella delle
altre; quanto basta comunque per capire che ci troviamo di fronte ad una statua
comnemorativa di un uomo pubblico, politico, Aulo Metello appunto, offerta in
suo onore da una qualche comunità in un santuario della zona di Perugia o, più
probabilmente, del Trasimeno.
Il ritratto: l'iscrizione dichiara con
evidenza che, con questa statua, si voleva ricordare, e rappresentare, un uomo
ben preciso, Aulo Metello. Anche il volto dunque si sarà voluto avvicinare alle
fattezze del personaggio, accentuandosi in questo una tendenza stilistica di
pronunciato verismo di influenza, ancora, romana. Lungo e dibattuto è il
problema del nascere e del fiorire del genere artistico del ritratto, e,
soprattutto, il problema di quando si possa parlare, per una testa dipinta o
scolpita, di ritratto, nella "moderna" accezione del termine. Nella sua
evoluzione sono state individuate le seguenti tappe:
l) ritratto
intenzionale: il primo impulso al ritratto, che si manifesta nella sua forma più
ingenua, attribuendo un nome determinato ad una immagine generica;
2)
ritratto tipologico: la genericità dell'immagine si riduce, cercandosi di
indicare con essa la classe di appartenenza del personaggio raffigurato (un re,
un guerriero, un dio), e la sua età (vecchio, giovane).
La III e la IV tappa
tendono ad imitare precisamente le fattezze individuali del soggetto,
riproducendone veristicamente i tratti somatici (ritratto fisionomico) ed infine
cercando di conferire ad essi un'espressione psicologica che meglio ricordi il
personaggio: è il ritratto fisionomico, ritratto nella sua accezione moderna,
che affonda però le sue radici nei fermenti della Grecia del IV sec., quando,
sullo stimolo della sofistica, si abbandonano le più antiche remore ideologiche
che avevano fino ad allora impedito dieternare con un tale tipo di ritratto un
individuo isolandolo al di sopra della massa di suoi pari, per giungere ora ad
un più pieno apprezzamento della individualità del singolo. Se ancora per il
sarcofago dell"'obeso" siamo incerti se ci troviamo di fronte ad un ritratto
fisionomico, e non piuttosto ad un ritratto tipologico di dominus adagiato sulla
sua kline, per la nostra statua è ormai chiara, nella cura minuziosa dei
dettagli, la potente influenza del verismo ritrattistico di Roma. Il collo è
lungo, la fronte è solcata da profonde rughe, il taglio degli occhi prosegue
lateralmente in sottili incisioni e la loro intensità è aumentata dall'ampiezza
delle guance, magre e glabre; la bocca, ben disegnata, è sottolineata da un
mento piuttosto deciso.
Aule Meteli, un etrusco (lo dichiara, l'iscrizione)
che veste, si fa ritrarre alla maniera romana. Un etrusco, dunque, ormai
pienamente romanizzato, come giuridicamente romanizzata è, proprio in questi
anni, l'Etruria che, con la Lex Iulia e laLex Calpurnia de civitate (90 a.C.),
acquisisce la cittadinanza romana. La nostra statua è dunque un monumento che
possiamo prendere a simbolo dello scomparire di una civiltà, quella etrusca,
lentamente ed inesorabilmente assorbita da quella romana. Con debita prudenza
possiamo quasi riassumere in questo bronzo un'epoca: " Aulo Metello, nato
etrusco, cittadino romano".
CHIMERA
Tratto dal testo della sovrintendenza
del Museo Archeologico di Firenze
La storia
La Chimera fu scoperta
nel 1553 (secondo il Vasari nel 1554), durante la costruzione di fortificazioni
medicee alla periferia della città. Il ritrovamento avvenne il 15 novembre 1553
e dopo il rinvenimento fu subito trasportata a Palazzo Vecchio. Questa scoperta
sensazionale ebbe larga eco tra artisti e letterati dell'epoca, come ad esempio
il Cellini, il Vasari, Tiziano ecc. ela notizia si diffuse assai rapidamente,
tanto che nella seconda metà del'500 la Chimera divenne l'interesse precipuo e
la mèta di numerosi viaggiatori stranieri che ne parlarono in appunti di viaggio
corredati spesso da disegni dell'opera.
Da alcuni disegni più antichi e da
notizie sul ritrovamento nell'Archivio di Arezzo risulta che solo la coda,
rintracciata dal Vasari, mancava e che non fu ricomposta. Così viene anche a
cadere la leggenda che vedeva nel Cellini l'esecutore del restauro integrativo
delle zampe che dovevano quindi essere complete seppur danneggiate. Dopo il
rinvenimento si cominciò la ricerca di testimonianze iconografiche che
garantissero che si trattasse proprio della Chimera di Bellerofonte,
indirizzando l'indagine soprattutto sui reperti numismatici. Dal Vasari
(Ragionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze nel palazzo di loro
Altezze Serenissime, Firenze 1558, ed Arezzo 1762, pp. 107-8) si ricava e si ha
testimonianza del metodo seguito per giungere ad affermare che il "leone"
scoperto ad Arezzo era proprio la Chimera. Ad un interlocutore che domanda se si
tratta proprio della Chimera di Bellerofonte, come dicono i letterati, il Vasari
così risponde:
"Signor sì, perche ce n'è il riscontro delle medaglie
che ha il Duca mio signore, che vennono da Roma con la testa di capra
appiccicata in sul collo di questo leone, il quale come vede V.E., ha anche il
ventre di serpente, e abbiamo ritrovato la coda che era rotta fra que' fragmenti
di bronzo con tante figurine di metallo che V.E. ha veduto tutte, e le ferite
che ella ha addosso, lo dimostrano, e ancora il dolore, che si conosce nella
prontezza della testa di questo animale...".
Quindi, per risolvere i
problemi interpretativi che si erano venuti a creare con il ritrovamento della
statua, l'indagine non si limitò alle testimonianze letterarie e mitologiche, ma
progredì nella ricerca di documentazioni iconografiche antiche, particolarmente
per quello che concerneva la documentazione numismatica. E non si può escludere
che la ricerca di medaglie avesse come fine ultimo quello di scoprire un modello
per restaurare la statua che mancava della coda. Infatti, furono trovate delle
monete d'argento di Sicione recanti l'immagine della Chimera. Queste monete, ora
nel Medagliere del Museo Archeologico di Firenze, facevano presumibilmente parte
delle Collezioni Granducali. Esse mostrano la Chimera con la giusta posizione
della coda, formata dal serpente. La coda con la testa di serpente doveva
avventarsi minacciosa contro l'avversario e non mordere un corno della testa
della capra: si tratta infatti di un restauro sbagliato eseguito, in epoca
neoclassica, da Francesco Carradori nel 1785.
I Medici e la Chimera
La Chimera, come abbiamo detto sopra, fu subito portata a Palazzo Vecchio
nella sala di Leone X: si trattava di un'operazione non solo artistica (in
quanto si adattava al progetto decorativo stabilito dal Vasari) ma anche
"strategica"; in questo senso la Chimera, l'opera più importante
dell"'etruscheria" toscana, stava anche a simboleggiare le fiere che Cosimo
aveva combattuto e domato per costruire il suo regno.
Il mito
Chìmaira, in greco, letteralmente significa capra. Ed infatti questo mostro
della mitologia greca con il corpo e la testa di leone, talvolta alato, con la
coda a forma di serpente, portava nel mezzo della schiena una testa di capra.
Omero (II. VI, 181-182) ed Esiodo (Theog., 321-322) narrano che era figlia di
Tifone. La Chimera fu uccisa dall'eroe Bellerofonte, ritenuto da alcuni
addirittura figlio di Posidone; Bellerofonte riuscì a catturare e domare il
cavallo alato Pègaso, con il quale riuscì ad uccidere la Chimera. La statua
bronzea del Museo Archeologico di Firenze rappresenta la Chimera ferita in atto
di avventarsi sul suo aggressore, mentre la testa di capra si reclina, morente,
per le ferite ricevute.
La coda con la testa di serpente, come abbiamo detto,
è un restauro non giusto: doveva avventarsi minacciosa contro l'avversario e non
mordere un corno della testa della capra. Probabilmente, la Chimera faceva parte
di un gruppo con Bellerofonte sul Pegaso che colpiva dall'alto, come fa supporre
la ferita sanguinante sul collo della capra. Però non si può escludere
completamente 1 'ipotesi che si trattasse di un dono votivo a se stante.
La datazione
Molto si è discusso sull'appartenenza della Chimera
all'arte etrusca, tesi ormai accettata senza riserve dagli studiosi. La "maniera
etrusca" già notata dal Vasari si riflette in quel misto di naturalismo (nella
muscolatura e nelle vene rilevate, rese con calligrafico realismo, del corpo
teso del leone) e di stilizzazione (nella testa con fauci spalancate in atto di
feroce aggressione e nel pelame della criniera e del dorso, reso con ciocche
dette convenzionalmente "a fiamma"); di conservatorismo (negli elementi
convenzionali arcaizzanti della testa e della criniera) e di intensa
espressività (nell'aggressività feroce del muso del leone e nel patetico
abbandono della testa della capra). Altro elemento a favore della etruschità di
questa opera d'arte è la iscrizione sulla branca anteriore destra, tracciata sul
modello ed eseguita insieme alla fusione. Vi si legge tinscvil, cioè dono votivo
al dio Tinia (assimilabile al Giove dei Romani).
Si tratta di un'iscrizione
dedicatoria con caratteristiche grafiche appartenenti all'area
etrusco-settentrionale, cosa che avvalorerebbe l'ipotesi di una offi- cina
nord-etrusca, localizzata ad Arezzo o in zona contigua. Per quanto riguarda la
datazione, quella finora consueta della fine del V secolo a.C. è universalmente
abbassata ai primi decenni del IV sec. a.C.
La collocazione al Museo
Archeologico
Come abbiamo detto sopra, la Chimera rimase a lungo, come un
simbolo, a Palazzo Vecchio e solo molto tempo dopo, nel 1718, venne trasportata
nella Galleria degli Uffizi, proprio come oggetto da esporre in museo. Non a
caso fu trasportata agli Uffizi: in questo periodo, la famiglia Medici non era
più quella potente di una volta e cominciava anche, lentamente, uno studio più
serio sull"'etruscheria", che andava ben oltre la semplice curiosità. Dopo il
1879 ci furono forti pressioni perche tutto il materiale antico fosse collocato
nel Palazzo della Crocetta, l'odierna sede del Museo Archeologico. Lo scopo fu
raggiunto solo in parte, ma tra le opere trasferite ci furono l'Idolino, la
Chimera ed altri bronzi classici (1890).
MATER MATUTA
Provenienza:
Chianciano (Siena). Venne scoperta probabilmente nel 1846 o nel 1847 da Luigi
Dei in un terreno a 1 krn. a sud di Chianciano, in località 'La Pedata'.
Stato di conservazione: lacunoso, con numerose reintegrazioni.
Datazione: 450-440 a.C
La statua-cinerario aveva subìto un primo
restauro ad opera di restauratori chiusini dell'800, i quali, seguendo il gusto
e la moda dell'epoca, avevano integrato le parti mancanti con tasselli, scolpiti
nella stessa 'pietra fètida' della scultura (pietra arenaria a grana finissima,
tipica delle cave esistenti nelle vicinanze di Chiusi), tenuti insieme da un
impasto di polvere di pietra fètida e di gomma collosa di natura organica, in
modo da ottenere l'effetto di integrità.
A causa dei danni rilevanti
arrecati alla Mater Matuta dall'alluvione del 1966, fu necessario un nuovo
intervento di restauro, effettuato con tecnica perfezionata e rigore
scientifico, che ha pennesso di discernere le parti autentiche del monumento dai
posticci del restauro ottocentesco ( eliminati, quindi, nella nuova
ricostruzione).
Il cinerario è in fonna di statua femminile, che regge sul
grembo un bambino, avvolto in un panno. La figura è seduta su un trono, di fonna
cubica, con i braccioli pieni a fonna di finge accosciata con le ali aperte. La
testa, mobile, fungeva da coperchio; ugualmente mobili sono i piedi. Il corpo,
che fa un tutt'uno con il tronco, fu probabilmene ricavato da un unico blocco di
pietra. Nell'interno della statua, secondo Milani, furono rinvenuti l'oinochòe
plastica a testa femminile e lo spillo d'oro con decorazione granulare,
conservati nella vetrina adiacente.
La statua-cinerario di Chianciano,
variamente identificata con una divinità (Bona Dea; Tujltha, la dea degli
Etruschi protettrice dei morti, Proserpina; o Mater Matuta) con tutta
probabilità rappresenta una defunta con il suo bambino. Dal punto di vista
stilistico si nota una tale discrepanza tra l'esecuzione della testa e quella
del corpo (fenomeno, questo, tuttavia frequentissimo nell'arte etrusca, che si
rinnova, anche in epoca posteriore, nelle figure dei defunti sui coperchi delle
urne), da far pensare che siano stati prodotti in botteghe diverse. Il corpo,
massiccio, si stacca appena dal blocco cubico del trono; il panneggio del
chitone e del himàtion è reso con vivo plasticismo e senso volumetrico nelle
ampie e pesanti pieghe accentuate soprattutto sulle gambe. Molto bella è la
testa, con capelli spartiti sulla fronte, trattenuti da una tenia e ricadenti
sulle tempie in bande ondulate; volto ovale con grandi occhi a mandorla,
sottolineati da palpebre pesanti; naso diritto; bocca con labbra carnose,
leggermente aggettanti, che ne accentuano l'espressione serena e pensosa, che
riflette una eco della grande arte greca del V sec. a.C. La datazione è stata
molto discussa, oscillando tra la metà del V ed il IV sec a.C. Gli oggetti del
corredo (la oinochòe a testa femminile, datata dal Beazley a1470-450 a.C. e lo
spillo d'oro granulato, datato nel 2° venticinquennio del V sec.a.C.) ed i dati
iconografici sembrano confermare la datazione della Mater Matuta al 450-440 a.C.
Per il suo uso come cinerario, la Mater Matuta si collega ai canopi
chiusini.
Il canopo (o più propriamente "ossuario antropòide") non è che un
'urna cineraria con copertura a testa umana, tipica e caratteristica della
regione chiusina. A sua volta, il canopo si riallaccia ad una lunga tradizione,
che sorge nella civiltà villanoviana. Infatti, la copertura ad elmo di alcuni
ossuari villanoviani (generalmente coperti da ciotola-coperchio monoansata) non
è che un principio di antropomorfizzazione, che troverà il suo pieno sviluppo
proprio nell'ossuario antropoide chiusino. Cronologicamente, i canopi vanno
dalla metà del VII al principio dell'età ellenistica (IV sec.a.C.). I canopi,
come le statue-cinerario, hanno una testa mobile, che chiude il vaso contenente
le ceneri; anche essi sono posti su di un sedile di trono, spesso in terracotta,
talora in lamina bronzea, più modesto dei troni delle statue-cinerario, ma
indicante una chiara intenzione di onorare il ricordo del defunto. Sia i canopi
che le statue-cinerario sono peculiari dell'ambiente chiusino e attestano la
continuità coerente e costante di una cultura artistica che può aver determinato
il fiorire in Chiusi di una scuola scultorea di notevole importanza. Ciò è
dovuto prevalentemente al tipo di fiorente economia agraria, che Chiusi sviluppa
in modo particolare, ma che si ritrova anche in altre città dell'Etruria interna
(a differenza di quanto troviamo nei centri dell'Etruria costiera, la cui
florida economia commerciale e marittima subisce un arresto ed una conversione
da mercantile ad agraria soltanto dopo la sconfitta etrusca a Cuffia del 474
a.C. e la conseguente perdita del dominio sul mare).
Il SARCOFAGO di LARTHIA
SEIANTI
Provenienza: tomba a camera della gens Larcna, rinvenuta nel
1877 in loc. Martinella, un km a NE di Chiusi.
Stato di
conservazione: il sarcofago, pressochè intatto, conserva gran parte della
policromia antica, frequente in monumenti del genere, ma spesso sbiadita
irrimediabilmente dal tempo e dalle condizioni di giacitura dei reperti.
Realizzato in terracotta, fu confezionato in quattro parti distinte (e poi
giustapposte) per l'impossibilità di cuocere insieme il grande coperchio e la
grande cassa. La figura è stata eseguita a mano libera; per la decorazione della
cassa si è probabilmente fatto uso di stampi.
Datazione: secondo quarto
delll secolo a.C.
Soggetto: la defunta è immaginata semidistesa sulla
kline, il busto tenuto eretto puntellando il braccio sinistro su due cuscini a
bande gialle, bianche e violacee (nell'indicazione dei colori seguiremo anche le
descrizioni del pezzo al momento della scoperta, quando essi erano più vivi)
dalle lunghe frange gialle e viola. Tiene nella mano sinistra aperta, dalle dita
inanellate, uno specchio circolare: la superficie riflettente interna è in
azzurro, la cornice perlinata in giallo e deve quindi essere immaginata aurea.
La destra discosta dal volto, in un gesto di pudicizia, un lembo dell'ampio
mantello bianco, bordato da una striscia violacea tra due minori verdi, che le
avvolge le spalle, i fianchi e le gambe, coprendo una tunica, pure bianca,
decorata da tre bande verticali (due laterali violacee ed una verde centrale) e
da una banda a V che sottolinea la scollatura. Stringe la tunica, poco sotto il
seno, una cintura annodata, gialla, frangiata, con motivi rilevati a fulmine ed
a dischetto, con punto centrale rosso (forse ad indicare l'inserzione di una
qualche pietra dura). I piedi, con calze verdi, calzano sandali con legacci
verdi decorati con borchiette gialle. La chioma, a corte ciocche regolari che
incorniciano la fronte, reca un diadema (o forse una ghirlanda) di fiori in
giallo; ricordano l'oro la collana a girocollo con pendente, la bulla a testa di
Medusa sullo scollo, le due armille sul braccio destro. Gli orecchini, a disco
con pietre rosse, hanno un pendente a ghianda.
Il fronte della cassa è
decorato secondo un chiaro partito architettonico, generato forse dalla
particolare ideologia funeraria etrusca (la tomba vista come casa del defunto),
o forse, più semplicemente, mediatovi come elemento decorativo. E' ripartito in
quattro settori da cinque pilastrini scanalati con capitelli compositi, che
sorreggono una fila di ovoli ed un listello piatto su cui è impresso il nome
della defunta. I pilastrini inquadrano spazi rettangolari decorati con due
rosoni a rilievo violacei e rossi, intercalati a due pàtere umbelicate dipinte
di giallo.
Il ritratto: come vedremo, l'iscrizione tracciata sul
sarcofago al momento della sua esecuzione, venne poi sostituita, prima dell'uso
effettivo, da un' altra, con un diverso nome: il fatto rende ancorpiù evidente
il problema dell'eventuale valore ritrattistico della figura sul coperchio. In
effetti lungo e dibattuto è, in generale, il problema del ritratto, del suo
nascere e fiorire e, soprattutto, di quando si possa parlare, per una testa, di
ritratto nella "moderna" accezione del termine. Nella sua evoluzione sono state
individuate le seguenti tappe: 1) ritratto intenzionale: il primo impulso al
ritratto, che si manifesta nella sua forma più ingenua, attribuendo un nome
determinato ad una immagine generica; 2) ritratto tipologico: la genericità
dell'immagine si attenua, cercando di indicare con essa la classe di
appartenenza del personaggio raffigurato (un re, un guerriero, un dio, una
matrona), e la sua età (giovane, vecchio). La III e la IV tappa tendono ad
imitare precisamente le fattezze individuali del soggetto, riproducendone
veristicamente i tratti somatici (ritratto fisionomico) ed infine cercando di
conferire ad essi un' espressione psicologica che meglio connoti il personaggio:
è il ritratto fisionomico, il ritratto come oggi lo concepiamo.
Nel
monumento, la caratterizzazione del volto è piuttosto scarsa e non sembra andare
oltre la generica rappresentazione di una giovane matrona pomposamente
recumbente sulla sua ricca kline, nello sfoggio della sua ricchezza. La notevole
somiglianza del volto stesso con quello dell'analogo sarcofago di Seianti
Tanunia conservato presso il British Museum di Londra, ci convince ad assegnarlo
all'ambito del semplice "ritratto tipologico". L’iscrizione:
larqia:seianti:s…i:sve…(impressa nell’argilla); ...ti a:lar...lisa: niasa
(dipinta sullo stucco che ha coperto la prima): vedi Corpus Inscriptionum
Etruscarum 1215.
Impressa sul listello superiore della cassa prima della
cottura, quando l'argilla era ancora cruda, l'iscrizione indica il nome della
defunta, o forse il nome del personaggio che commissionò il sarcofago, senza poi
usarlo. L'iscrizione, in effetti, risultava, al momento della scoperta,
parzialmente riempita e ricoperta da uno strato di stucco (alcune lettere sono
ancora mal leggibili) sul quale era stato dipinto un secondo nome, diverso dal
primo, oggi quasi completamente scomparso. Poco chiaro per questo il reale
rapporto tra la defunta seppellita nel nostro sarcofago e gli altri personaggi
sepolti nella stessa tomba, sicuramente pertinente alla famiglia larcna.
Il corredo: attorno al sarcofago furono rinvenuti i seguenti oggetti.
Argento: craterisco in lamina; padella; doppio pettine; tre pàtere; tre
spilloni; un cucchiaino per cosmetici; tre aghi (forse frammento di una fibula);
un paio di pinzette; vetro: cinque pedine da gioco, di vario colore; alabastro:
due anforischi; bronzo: una fiaschetta in lamina; un asse romano.
Possiamo
agevolmente distinguere tre gruppi di materiale: il vasellame da mensa
miniaturizzato, gli oggetti da toeletta, la moneta. Proprio quest 'ultima,
presente nel corredo come obolus Carontis, cioè come offerta che la defunta
elargirà al traghettatore degli Inferi al momento di esser trasportata nel mondo
dei morti, ci fornisce un utile dato cronologico per la datazione della tomba:
il monetiere che ha curato la sua coniazione è infatti M. Titinius, che sappiamo
attivo a Roma tra il 189 ed il 180 a.C.. La sepoltura sarà dunque di poco
posteriore a tale epoca, visto che la datazione tipologica degli altri oggetti
di corredo non può scendere molto nel II sec. a.C. I ricchi oggetti da toeletta
non fanno che completare, stavolta con l' oggetto reale, la ricca parure già
esibita dalla figura sul coperchio.
Il vasellame da mensa, miniaturistico,
rimanda al mondo del banchetto aristocratico: una delle manifestazioni tipiche
del vivere gentilizio, esaltata nei cicli pittorici delle tombe di Tarquinia
(Tomba del Triclinio, Tomba dei Leopardi...) come anche e soprattutto dalla
figura sdraiata a banchetto dei grandi sarcofagi maschili ( cfr. quello
dell'obesus ) e delle piccole urne cinerarie. Il particolare pregio del metallo
con cui tali oggetti di corredo sono stati realizzati costituisce un'ulteriore
prova della estrema ricchezza della defunta. Una ricca signora, dunque,
debitamente onorata anche nell ' oltretomba: uno dei tanti indizi della
particolare considerazione della donna nel mondo etrusco. Una considerazione
spesso esagerata da certi moderni, specie influenzati dalla propaganda
"scandalistica" della storiografia greca. Una società rigidamente androcentrica
non poteva che stigmatizzare negativamente la libertà ad essa concessa, ancor
più se questa lo era da un mondo economicamente in competizione, quale quello
etrusco. Al di là di facili esagerazioni possiamo comunque riscontrare numerose
prove di un diverso ruolo rivestito dalla donna etrusca rispetto ad altre
civiltà antiche, assolutamente androcentriche. Un esempio tra tutti, quello
offertoci dall'onomastica. Le formule onomastiche antiche citano il nome del
padre, il patronimico; quelle etrusche citano talvolta anche il nome della
madre, il metronimico (che però mai sostituisce il primo!). Si veda, come
esempio, l'iscrizione tarquiniese CIE 5471:
Larth Arnthal Plecus clan
Ramthasc Apatrual..., cioè Larth, figlio di Plecus e di Ramtha
Apatrui.
Mentre la donna romana, inoltre, non possedeva un prenome, cioè un
nome proprio, diverso dal nome familiare (ossia il gentili zio che, volto al
femminile, la designava), la donna etrusca aveva invece il proprio prenome al
pari dell'uomo. Il diverso rilievo della donna etrusca nell'ambito delle società
antiche ci è poi confermato anche da altri indizi, anche storici: è l'etrusca
Tanaquilla, moglie di Tarquinio Prisco, che, alla morte del marito, impone a
Roma il regno di un sovrano ne appartenente alla linea dinastica, ne voluto da
(almeno apparenti) forze politiche interne: Servio Tullio (vedi Livio,
1,34).
La Lingua
L'etrusco è una lingua costruita in un alfabeto di
origine greca e affine all'alfabeto latino. Le incognite che ancora oggi la
lingua etrusca presenta sono da attribuire alla sua estraneità rispetto ai
gruppi linguistici noti. A detta degli antichi, tra cui lo storico Dionigi di
Alicarnasso, la lingua parlata dagli Etruschi era diversa da tutte le lingue
conosciute. Dopo la conquista romana, essa fu a poco a poco sostituita dal
latino, fino ad uscire completamente dall'uso.
Il presunto
mistero
Il materiale: entità e caratteristiche delle testimonianze superstiti
Documentazione diretta
Documentazione indiretta
II processo
interpretativo
Alfabeto etrusco
Piccolo vocabolario
etrusco
Trascrizione delle iscrizioni
Iscrizioni indicanti
alfabeti
Il presunto mistero
Contrariamente a
quanto molti ancora suppongono, i documenti della lingua etrusca sono tutt’altro
che ‘indecifrati’ o ‘indecifrabili’: scritti con un alfabeto di derivazione
greca, di tipo euboico (‘rosso’, cioè occidentale, secondo la divisione
stabilita da A. Kirchhoff delle scritture dei Greci), fin dal secolo scorso si
leggono senza nessuna particolare difficoltà; ma anche in precedenza, salvo
qualche dubbio relativo a singoli segni, l’epigrafia aveva rappresentato il
capitolo forse più solido nell’intero panorama dell’etruscologia.
Sappiamo
dunque che già nel tardo VIII secolo a.C. gli Etruschi erano certamente in
possesso d’un alfabeto, introdotto in Italia centrale da coloni euboici
dell’isola d’Ischia e comprendente ventisei lettere, come si desume da una
tavoletta d’avorio, dalla finalità evidentemente scolastica, ritrovata a
Marsiliana d’Albegna (Grosseto). Ma quattro lettere non sono effettivamente
impiegate (la b, la d, la s sonora e la o, che si confondeva col suono u),
mentre per il suono f dal VI secolo a.C. è introdotto un segno apposito. La
scrittura procede normalmente da destra verso sinistra; assai più raramente, da
sinistra a destra ovvero con andamento bustrofèdico, cioè alternato riga per
riga. In epigrafi meno antiche si possono incontrare puntini di separazione tra
le parole. In realtà il problema è un altro ed è un problema d’interpretazione
linguistica, non di decifrazione epigrafica: quello d’intendere il significato
dei testi, redatti in una lingua che non sembra imparentata con nessun altra
delle antiche o moderne proposte alla comparazione, e di elaborare,
possibilmente, una descrizione grammaticale, morfologica e sintattica, di questa
lingua, che è poi la condizione stessa della sua conoscenza effettiva. E, da
tale punto di vista, bisogna ammettere che, nonostante lo sforzo grandioso di
molte generazioni di studiosi, i risultati sicuri permangono pochi e settoriali;
e ciò non per insufficienza d’impegno o per inadeguatezza dei metodi adottati,
ma per la qualità medesima dei documenti disponibili. Infatti le iscrizioni
etrusche, anche se numerose (circa 10.000), vengono in grandissima parte da
necropoli; sono perciò di carattere funerario e generalmente molto brevi. Esse
ci danno perciò soprattutto, se non soltanto, nomi di persona e indicazioni
anagrafiche elementari, pur essendo in gran parte abbastanza facilmente (ma
talvolta approssimativamente) traducibili.
I pochissimi testi etruschi più
complessi - un rituale scritto su un rotolo di tela poi utilizzato per avvolgere
una mummia, ora al Museo di Zagabria; una tegola iscritta, proveniente da Capua,
a Berlino; il Cippo di Perugia - suscitano invece gravi difficoltà
nell’interpretazione, anche perché non si conoscono per il momento ampi
documenti bilingui a carattere di traduzione letterale (del tipo della Stele di
Rosetta). Ciononostante la pazienza degli indagatori conduce pian piano a
singole acquisizioni che, pur nei limiti quasi invalicabili imposti dalla
quantità e dalla qualità dei documenti (ai testi epigrafici bisogna aggiungere
le parole etrusche riportate dagli scrittori antichi), possono organizzarsi in
un disegno generale abbastanza ben definito. Dopo l’esperienza dei metodi
‘etimologico’ (che presupponeva la parentela dell’etrusco con altre lingue
conosciute) e ‘combinatorio’ (rivolto ad analizzare solo per via interna la
‘combinazione’ degli elementi costitutivi del testo), in anni recenti hanno
trovato sviluppo due nuovi modi d’accostare il problema linguistico: il
cosiddetto ‘bilinguismo’, promosso specialmente da Massimo Pallottino, che
integra l’analisi combinatoria con l’uso di fonti interpretative esterne (per
esempio, il confronto con formule di dedica latine e greche); e lo
‘strutturalismo’ di Helmut Rix, che reputa sufficiente una descrizione della
‘struttura’ dei testi a chiarirne anche il significato. Della grammatica
dell’etrusco non è qui il caso di parlare diffusamente, perché c’introdurrebbe
in un terreno di ardua e complicata spiegazione. Preferiamo dare al lettore
l’esempio di una declinazione di sostantivo ormai sufficientemente accertata
(secondo gli schemi di lingue più note, come il greco e il latino e quello di un
‘epigrafe funeraria abbastanza traducibile.
Ecco il modello di declinazione
del sostantivo methlum (che significa ‘nome’): methlumes (‘del nome’); methlumth
(‘nel mome’, con valore locativo); methlumeri (‘al nome’). Ed ecco invece
l’esempio di epigrafe funeraria (si tratta dell’iscrizione incisa su un
sarcofago da Norchia e riportata sia nel Corpus Inscriptionum Italicarum di A.
Fabretti, N. 2070, sia nel nuovo Corpus Inscriptionum Etruscarum, N. 5874):
Arnth Churcles [Arnth Churcle], Larthal [di Larth] clan [figlio] Ramthas
Nevtnial [(e) di Ramtha Nevtni], zilc parchis [pretore] amce [fu] marunuch
[appartenente al collegio dei ‘maroni’] spurana [urbano] cepen [sacerdote] tenu
[ha esercitato], avils [di anni] machs [cinque] semphalchls [(e) settanta] lupu
[è morto].
Il materiale: entità e caratteristiche delle
testimonianze superstiti
Si è già detto che uno dei fondamentali fattori
negativi per la conoscenza della lingua etrusca (e potremmo aggiungere più
generalmente della civiltà etrusca) è costituito dalla ristrettezza della
documentazione. Tuttavia questa documentazione è tutt'altro che trascurabile: si
tratta infatti del più ingente complesso di testimonianze scritte di una lingua
antica parlata in Italia, e nell'intero Mediterraneo centro-occidentale, a parte
il greco, il fenicio-punico e il latino; in età arcaica gareggia per entità con
i resti epigrafici di queste stesse lingue; ed è in continuo aumento. Proprio il
flusso delle nuove scoperte ravviva la speranza che il futuro, anche prossimo,
possa riservarci ulteriori sorprese. È più che probabile che il sottosuolo
etrusco nasconda ancora un ricco patrimonio di iscrizioni. Non si può escludere
che un' attenta indagine nelle aree dei maggiori centri urbani porti al
ritrovamento di testi epigrafici di carattere pubblico, storico-commemorativo o
giuridico eventualmente redatti in etrusco e in latino (ciò che è ben possibile
per le fasi più recenti dell'Etruria sottomessa o federata a Roma).
Rimarrà
naturalmente comunque l'incolmabile lacuna dell'assenza di testi letterari, per
cui ci è preclusa la possibilità di conoscere l'etrusco alla stessa stregua
delle altre lingue del mondo classico. In teoria documenti letterari etruschi
potrebbero scoprirsi nel futuro in papiri dell'Egitto o di Ercolano (se si tien
conto del già avvenuto miracolo - che di un vero miracolo dobbiamo parlare - del
rinvenimento di un testo etrusco sulle bende di tela di una mummia egiziana); ma
si tratta purtroppo di possibilità tanto tenui e remote da potersi definire
chimeriche.
Documentazione diretta
Le
testimonianze che attualmente possediamo aifini della conoscenza della lingua
etrusca si distinguono in dirette e indirette. Testimonianze dirette sono i
testi: in gran parte editi nel C.I.E.. in altre raccolte e rassegne specifiche,
ed in varie pubblicazioni monografiche e periodiche; alcuni pochi ineditì
(soprattutto quelli che continuamente vengono in luce, nella fase che segue
immediatamente la loro scoperta). Si tratta di materiale tutto di carattere
epigrafico, cioè di iscrìzioni sopra monumenti od oggetti di scavo, salvo i
frammenti del libro della mummia di Zagabria, che ha tuttavia anch'esso una
provenienza archeologica.
Quest'ultimo documento è di importanza eccezionale
non soltanto per la civìltà etrusca, ma anche più generalmente per le antichità
classiche, trattandosi dell'unico libro sacrale su tela (liber linteus) che ci
sia stato conservato per il mondo greco ed italico-romano. Aveva originariamente
la forma di un panno rettangolare ripiegato, quale è riconoscibile in alcuni
monumenti funerari etruschi. Fu poi tagliato in strisce ed impiegato per
avvolgere la mummia di una donna egiziana, di età tolemaica o romana, scoperta
probabilmente nel medio Egitto (ma il luogo di ritrovamento è incerto). Questa
utilizzazione, nella quale andarono perduti importanti frammenti del testo
originario, è senza dubbio secondaria; ignoriamo quali precedenti circostanze
abbiano determinato la presenza di un libro religioso etrusco in Egitto. La
mummia fu portata in Europa da un viaggiatore croato e poi dònata al Museo
Nazionale di Zagabria, dove J. Krall riconobbe la scrittura delle fasce come
etrusca. Riaccostando tra loro queste bende, si è potuto ricostruire un testo
scritto entro i limiti di almeno dodici colonne verticali: esso consta
attualmente di circa 1200 parole più o meno chiaramente e completamente
leggibili, alle quali si può aggiungere almeno un centinaio di altre parole che
si ricostruiscono dal contesto. Data la frequenza delle ripetizioni, il numero
delle parole sicure diverse fra loro si riduce a poco più di 500. Comunque il
libro di Zagabria è senza paragone il più lungo ed il più importante di tutti i
documenti etruschi finora in nostro possesso.
Le iscrizioni, scoperte
soprattutto nell'Etruria tirrenica, campana e padana - in minor numero o
eccezionalmente nel Lazio, in territorio umbro e fuori d'Italia (Africa, Francia
meridionale) -, sono incise o dipinte sopra elementi architettonici, pareti di
tombe, cippi, sarcofagi, urne, tegole, statue, arredi, laminette metalliche,
vasi, ecc. Esse ammontano ad oltre diecimila; ma solo pochissime sono di entità
rilevante. Tra queste alcune hanno il carattere di documenti autonomi non legati
alla natura dell'oggetto, nel senso cioè che il loro supporto mobile ha la
funzione di una specifica superficie scrittoria (non diversa da quelle di
materiale deperibile come i volumi di tessuto o di pelle, le tabelle e i dittici
lignei, ecc., che vediamo frequentemente riprodotti nei monumenti figurati
etruschi, ma che nella realtà sono andati perduti a causa del nostro clima,
mentre il clima secco dell'Egitto ha salvato illiber linteus di Zagabria). La
più lunga è inscritta sopra una lastra di terracotta in forma di tegola
proveniente da Capua e successivamente passata ai Musei di Berlino: esso consta
di 62 righe conservate, divise in dieci sezioni, con quasi 300 parole leggibili;
la seconda parte del testo è molto rovinata; la scrittura è tracciata a righe
alternativamente rovesciate in modo da imitare il procedimento detto
bustrofedico. Un testo graffito su ambedue le facce di un lungo nastro di lamina
di piombo, purtroppo trovato in frammenti, è venuto recentemente alla luce in un
piccolo santuario presso Santa Marinella (C. I. E. 6310): vi si leggono tracce
di almeno 80 parole, di cui solo una quarantina leggibili integralmente; ed è
inciso con lettere di proporzioni miniaturistiche. Una laminetta lenticolare
anch'essa di piombo rinvenuta a Magliano e conservata nel Museo Archeologico di
Firenze (C. I. E. 5237) è caratterizzata da una iscrizione incisa, sui due lati,
a spirale con movimento dal margine esterno verso il centro: vi si contano
almeno 70 parole (talvolta non è facile distinguere se un gruppo di lettere
contiene una o due parole).
Un carattere del tutto particolare, per la loro
materia e la loro importanza linguistica e storica, hanno infine le lamine d'oro
scoperte nel santuario di Pyrgi, già più volte citate, di cui due scritte in
etrusco una in fenicio (C.I.E. 6314-6316); l'etrusca più lunga, di 15 righe e 36
o 37 parole, corrisponde a quella fenicia (nel senso di una bilingue, come già
sappiamo); mentre la più breve è di 9 righe e 15 parole). Non mancano altri
documenti di un certo sviluppo su lamine metalliche, come le tabellae defixionis
(cioè consacrazioni a divinità infere di persone che si vogliono maledire:
specialmente quelle di Monte Pitti C.I.E. 5211 e di Volterra C.I.E. 52) e alcune
di contenuto non precisabile.
Fra i titoli propriamente epigrafici eccelle
il cippo di pietra, pro- babilmente confinario, del Museo di Perugia (C.I.E.
4538), che pre- senta su due facciate una lunga e bella iscrizione scolpita di
46 righe e 136 parole. Tra le iscrizioni funerarie alcune sono estese come
quella del sarcofago di Laris Pulenas del Museo di Tarquinia (C. I. E. 5430),
tracciata sul rotolo aperto esibito dal defunto scolpito sul coperchio, con 9
righe e 59 parole; ma ne esistono anche altre non meno lunghe e rilevanti,
benche più rovinate, dipinte sulle pareti delle tombe di Tarquinia. Esistono
inoltre diverse epigrafi di sepolcri, sarcofagi, cippi che presentano alcune
righe di testo ed una certa varietà di parole; ma la grandissima maggioranza
consta di poche parole ed è redatta secondo formule fisse; non mancano alcune
brevi bilingui etrusco-latine. Le iscrizioni dedicatorie su oggetti mobili si
distinguono in un gruppo arcaico, con proprie formule ed il nome del dedicante,
e in un gruppo più tardo in cui è più frequente il nome della divinità; ma,
tolte le leggende piuttosto estese di alcuni vasi arcaici, sono anch'esse
generalmente brevi e stereotipe. Dobbiamo ricordare infine le innumerevoli
leggende esplicative delle figurazioni tombali, dei vasi dipinti, degli specchi,
ecc., le iscrizioni su monete, proiettili di piombo e altri oggetti minimi, le
marche di fabbrica, in gran parte con nomi propri. Si aggiungano, per la loro
singolarità, i famosi dadi da giuoco di avorio detti provenire da Tuscania e
conservati nella Bibliothèque Nationale di Parigi, con parolette (certamente
numerali) su ciascuna delle sei facce.
Documentazione
indiretta
Fonti indirette per la conoscenza dell'etrusco sono: 1) le
glosse, ed altre informazioni offerte dagli scrittori classici e postclassici;
2) gli elementi etruschi passati nel latino e gli elementi comuni
etrusco-italici; 3) gli elementi etruschi sopravvissuti nella toponomastica; 4)
i supposti frammenti di versioni latine da testi originari etruschi.
Le
glosse sono parole etrusche delle quali è data la traduzione latina o greca:
citate occasionalmente in testi di autori classici o inserite in veri e propri
dizionari. Se ne contano una sessantina; ma il loro valore come elementi
traduttori esterni, ai fini dell'interpretazione dell'etrusco, è piuttosto
limitato: proprio come nel caso delle bilingui etrusco-latine. Glosse di
carattere vario ci provengono da Varrone (de lingua latina), da Verrio Flacco
(de verborum significatione), da Isidoro (Etymologicum) e specialmente nel
Lessico di Esichio. A speciali categorie di vocaboli appartengono le glosse
etrusche con nomi di piante medicinali e con nomi di mesi (Papia, Liber
Glossarum di Leida) che pare si ritrovino anche nei testi etruschi: es. Aclus =
giugno, cfr. nel testo di Zagabria. Osservazioni di carattere fonetico e
grammaticale sull'etrusco, di scarsissimo valore, risalgono a Varrone, all' Ars
de orthographia di M. Cappella. Per alcune parole l'origine etrusca è
esplicitamente testimoniata dagli scrittori classici (mantisa. histrio. /ucumo.
atrium. ecc.); per altre è ipotetica e si può anche pensare ad una formazione
analogica, cioè a parole latine che imitino nella terminazione i derivati
etruschi, come pure a relitti del generale substrato preindoeuropeo d'Italia,
piuttosto che ad imprestiti dall'etrusco nella sua fase storica. Preferibilmente
si riterranno o sospetteranno etrusche quelle parole latine di etimologia oscura
e di terminazione etruscheggiante che si riferiscono al linguaggio tecnico del
culto, delle istituzioni civili e militari, della tecnica, ecc. : teniamo
presente il fortissimo influsso culturale esercitato dall'Etruria su Roma
primitiva in questi settori. Ne mancano esempi di vocaboli per i quali l'etrusco
è stato probabilmente intermediario tra il greco e il latino: per es. groma
(nome di uno strumento di orientazione e misurazione dei campi). Non è da
escludere neanche qualche limitato influsso dell'etrusco sulla fonetica e sulla
morfologia del latino. Il problema in tutto il suo complesso meriterebbe un
nuovo più attento esame, anche ai fini dell'ermeneutica etrusca. Ancora meno
chiara è la questione di eventuali dirette sopravvivenzelessicali etrusche in
volgari italiani; mentre l'ipotesi di una derivazione etrusca dell'aspirazione
toscana è accettata da diversi linguisti.
La difficoltà fondamentale consiste
soprattutto nel distinguere tra i diversi strati e le diverse aree di diffusione
dei toponimi preindoeuropei: ad esempio tra voci toponomastiche di tipo
«mediterraneo» o «paleoeuropeo» generale, diffuse anche nell'Italia centrale
(come i derivati dalle basi carra-, pala-, gav-, ecc.), e voci toponomastiche
che invece derivano dall'etrusco di età storica direttamente o attraverso una
forma latina come alcuni nomi di città (per es. Bolsena da Volsinii, etr.
Velsna-). Vanno infine menzionati gl'ipotetici esempi di versioni in latino
dall'etrusco. Già sappiamo che il corpo dei libri sacri etruschi fu tradotto o
compendiato in latino. Nelle congerie di riferimenti indiretti, riassunti,
rifacimenti di scritti etruschi, dei quali qualche eco è giunta fino a noi, si
notano alcuni brani che ci interessano non soltanto per la conoscenza della
letteratura e della civiltà etrusca, ma anche per le forme di espressione che
potrebbero riflettere una particolare struttura di linguaggio: per esempio il
frammento tratto dai Libri Vegoici e riportato dai Gromatici con insegnamenti
della Lasa Vegoia sulla divisione dei campi.
II
processo interpretativo
È evidente che il nostro interesse si
concentra soprattutto sulla documentazione diretta, cioè sui testi etruschi,
mentre le fonti indirette potranno se mai considerarsi come dati accessori e
ausiliari. Il problema che intendiamo affrontare in modo specifico a questo
punto è dunque essenzialmente quello dell'interpretazione dei testi (o
«ermeneutica» in senso proprio, volendo usare il termine tradizionalmente
diffuso negli studi etruscologici), cioè della comprensione del significato dei
documenti, indipendentemente dall'obiettivo della conoscenza della struttura
della lingua dei cui risultati si darà conto nel capitolo successivo.
Il
punto di partenza è la constatazione ormai pacificamente e incontrovertibilmente
acquisita in sede scientifica (contro ogni residua disinformazione in materia)
che esiste da tempo una generale e basilare capacità di leggere e capire,
individuandone la qualità e il senso o il contenuto certo o approssimativo, ogni
testimonianza scritta etrusca che costituisca l'illustrazione di monumenti
figurati (nomi di divinità e di eroi, di persone, ecc.), o ricordi i defunti
menzionandone la genealogia, l'età, la qualità o le azioni, o indichi
l'appartenenza e la destinazione di singoli oggetti con particolare riguardo
alle dediche votive, e così via; mentre per alcuni testi più lunghi di carattere
rituale (è il caso specialmente del manoscritto della mummia di Zagabria, della
tegola di Capua, della laminetta di piombo di Magliano si pensi al Cippo di
Perugina) possiamo accostarci alla comprensione complessiva del valore del
documento, talvolta alla sua articolazione in settori, paragrafi o frasi, e
perfino alla interpretazione di singoli brani.
Il fondamentale ostacolo a
maggiori approfondimenti eprecisazioni è rappresentato dalla incertezza dei
valori semantici di una parte notevole del lessico etrusco, cioè del significato
di molte parole e radici, talvolta anche ricorrenti con frequenza e perciò
sicuramente riferibili a concetti importanti (per esempio la serie di voci
diffusissime ar, ara, aras, arce, art?, ecc. , di cui, nonostante tante
autorevoli e motivate ipotesi, non crediamo ancora possibile considerare
accertato il senso); ed in questi casi occorrerà onestamente confessare la
nostra ignoranza. Di molte parole si sa la rispondenza a concetti generici senza
possibilità di precise oggettivazioni: così nei testi rituali ricorrono termini
con funzione verbale dalle basi hec-, sac-, acas-, ecc. , indicanti azioni di
culto, più o meno nel senso di offrire, porgere, sacrificare, consacrare, forse
invocare; mentre termini come fase, cleva, tartiria, acazr, debbono
corrispondere a singoli tipi di cerimonie e di offerte a cose concretamente
offerte, sacrificate o donate, per altro non distinguibili. Si sa d'altra parte
che la nozione generale di offrire, donare, dare (nell'ambito sacro,
eventualmente votivo, ma anche presumibilmente in quello profano) è espressa con
assoluta certezza dai «verbi» mul-. tur-. al-: il cui reciproco rapporto, di
diversa sfumatura o di diverso impiego preferenziale nel tempo o di pura
sinonimia, resta tuttavia incerto. Il fatto è che per «tradurre» esattamente non
poche parole etrusche occorre, od occorrerebbe, conoscere la realtà dei concetti
che ad essi si sottendono sul piano religioso, istituzionale, sociale, tecnico:
problema, dunque, non tanto linguistico quanto piuttosto
storico-culturale.
Ma i nostri sforzi per intaccare questo grosso nucleo di
oscurità del lessico etrusco, per precisare il significato di parole e di frasi
vagamente intelligibili, e conseguentemente per interpretare sempre più
puntualmente e sempre in maggior numero i testi, sono in continuo, seppur lento
e limitato, progresso, soprattutto a seguito dell'ininter- rotto acquisto di
nuovo materiale di studio, divenuto particolarmen- te sostanzioso nel corso
degli ultimi anni, come già si è rilevato nel capitolo precedente. Si può citare
come esempio tra i più istruttivi il caso della scoperta della già menzionata
iscrizione ceretana «dei Claudii», che con l'espressione apa-c ati-c,
manifestamente significante «e il padre e la madre» ( = latino paterque
materque), conoscendosi già con certezza il valore ati = «madre» e l'uso della
copulativa enclitica -c, ha consentito di accertare definitivamente il senso
della parola apa = «padre», in precedenza vagamente sospettato e per così dire
avvicinato e circuito, ma rimasto nella nebulosità dell'ipotesiI6. Analoga
considerazione, come ben s'intende, vale per quanto si è detto a proposito della
prova del valore ci = «tre», fornita dalla corrispondenza bilingue delle lamine
di Pyrgi. I risultati finora conseguiti si estendono naturalmente dal signi-
ficato delle parole alle loro funzioni e correlazioni, che danno senso ai
contesti. A questo proposito esistono alcune certezze elementari, come il
rapporto di appartenenza o discendenza indicato da un suffisso di «genitivo»
nelle usuali formule onomastiche: Larces clan «di Larce figlio».
Diremo che
esistono due soli principi di evidenza in assoluto: 1) riconoscere comechessia
il significato e la funzione di singole parole; 2) constatare la natura del
documento e, conseguentemente, desumerne il contenuto complessivo. Si tratta di
approcci fondamentalmente diversi e, nei loro sviluppi, addirittura opposti. Il
primo è basato su dati analitici, dai quali, attraverso un'indagine linguistica
strutturale e combinatoria, si tende alla ricomposizione e ricostruzione del
senso generale del testo (o del contesto). Il secondo, al contrario, considera i
testi sinteticamente per quanto essi possano voler dire, partendo dalle loro
caratteristiche archeologiche e affinità culturali, per poi discendere ai
particolari della valutazione linguistica dei singoli elementi che li
compongono.
Le prime parole riconosciute e riconoscibili dell'etrusco sono i
nomi propri. Essi costituiscono di fatto l'enorme maggioranza delle parole
presenti nelle iscrizioni etrusche ed hanno rappresentato il fondamento iniziale
di ogni loro tentativo d'interpretazione. Per quanto riguarda l'onomastica
personale appariva ed appare immediata l'identità formale con elementi
onomastici latini, prenomi (Marce: lat. Marcus) e nomi gentilizi (Vipi: lat.
Vibius); si è constatata altresì un'analoga costruzione con formula bimembre
(prenome e gentilizio) o trimembre (prenome, gentilizio, cognomen) e presenza
del patronimico. Con altrettanta facilità si riconoscono nomi divini comuni al
latino e all'etrusco (Menerva: lat. Minerva. Selvans: lat. Silva- nus) e nomi
greci di divinità e personaggi mitologici (Alexsantre, Elina, Elinai).
Aggiungiamo i toponimi ravvisabili dalla loro forma latina (Pupluna: lat.
Populonia) e loro derivati con valore di etnici (rumax «romano» da Ruma-
«Roma»).
Diverso è il caso per quel che riguarda tutto il resto del
patrimonio lessicale etrusco, estraneo all'onomastica, cioè le parole comuni o
appellativi. È qui che s'incontrano le difficoltà di fondo. Non possiamo contare
su strumenti diretti di traduzione se non per le scarse e malsicure nozioni
fornite dalle glosse. Si vorrebbe perciò ricorrere al confronto con radici e
formazioni di parole di altre lingue, supponendo una loro origine comune, nel
senso del vecchio metodo etimologico.
Passiamo ora all'esame dell'altra
possibilità di cogliere l'espressione di un testo, o di parte di esso, nella sua
globalità partendo da indizi esterni. Il tipo del monumento o dell'oggetto
inscritto è stato sempre, fin dall'inizio, una guida sicura per delimitarne il
senso: tanto ovvia e istintiva da restare per lungo tempo sottintesa (se ne è
avuta coscienza critica soltanto con la teorizzazione del metodo bilinguistico).
È evidente che l'epigrafe di un sarcofago o di un loculo tombale non può che
riferirsi ad un defunto, formulandosi presumibilmente nello stesso schema dei
testi funerari latini: ciò che era stato avvertito già a partire dalle
osservazioni degli eruditi del Settecento, con tutte le conseguenze relative
(onomastica personale, rapporti e termini di parentela come clan = figlio, sex =
figlia, e così via). Altrettanto evidente è che sugli oggetti mobili (vasi,
statuette di bronzo, ecc.) debbono necessariamente comparire annotazioni di
proprietà o di destinazione o, soprattuto se il luogo di provenienza è un
santuario, dediche a divinità, implicanti la presenza del nome dell'offerente,
dei termini esprimenti l'azione dell'offerta, eventualmente del nome divino,
come nelle analoghe iscrizioni greche o latine. Ancora più evidente è che le
parole scritte accanto a figure di divinità o di eroi, per esempio in scene di
specchi o in pitture, sono didascalie che notificano il personaggio (cosiddette
«bilingui figurate»). Le parolette incise su ciascuna delle sei facce dei dadi
da giuoco «di Tuscania» rappresentano senza il minimo dubbio le prime sei unità
numerali. Ogni scarto da questi elementi di certezza non può che condurre ad
interpretazioni aberranti.
L'evidenza «obiettiva» desunta dall'accostamento
di testi etruschi a testi di altra lingua in ambienti culturalmente vicini e per
casi di dimostrabile o presumibile af- finità di contenuto può estendersi, sia
pure con cautela, anche a documenti per i quali sono meno significativi
gl'indizi offerti dalla natura archeologica dell'oggetto o del luogo, quale è
soprattutto il libro su tela di Zagabria, le cui formule rituali sono state
studiate tentando di stabilire paralleli con formule rituali umbre delle Tavole
Iguvine, o latine degli Atti dei Fratelli Arvali, del de agricultura di Catone,
e altre.
Richiami culturali e storici valgono talvolta a legittimare
confronti anche più lontani, come quello fra il titolo di magistratura etrusca
zilafh mexl rasnal (ricorrente con lievi varianti formali in iscrizioni del
IV-III secolo a.C.) e il titolo onorifico latino di età romana imperiale praetor
Etruriae o praetor (Etruriae) quindecim populorum, di cui si è già parlato:
esempio significativo di una rispondenza generale che dà l'impressione di un
vero e proprio «calco linguistico», ma che è più difficile analizzare nel senso
e nel rapporto delle singole parole dei populi etruschi. Lo stesso «principio
dei testi paralleli» come fonte primaria d'interpretazione globale vale
ovviamente, per le vere e proprie bilingui. Le quali tuttavia, salvo il caso
speciale di Pyrgi, sono poche e brevissime. Si tratta di iscrizioni funerarie
redatte in etrusco e in latino, che presentano corrispondenze di nomi personali
e solo eccezionalmente dati utili per la conoscenza del lessico e della
grammatica. Assai più ampio e complesso è naturalmente il contributo che hanno
offerto e possono offrire le lamine d'oro di Pyrgi inscritte in fenicio e in
etrusco (A), per le quali potrebbe essere discutibile la definizione come
«bilingue» in senso tecnico, trattandosi di oggetti distinti (comunque uguali e
trovati insieme); ma che a parte alcune indiscutibili divergenze tra i due
testi, hanno in sostanza lo stesso contenuto: cosicche la versione etrusca
risulta più o meno efficacemente illuminata da quella fenicia, con risultati di
grande importanza ermeneutica già in parte rilevati e di cui si tratterà
ulterior- mente più avanti in uno specifico esame di queste iscrizioni.
Partendo dalle certezze di base sin qui descritte (valore di singole parole
con particolare riguardo all'onomastica e significato d'insieme dei testi), il
processo interpretativo si sviluppa ulteriormente, a livello di ipotesi,
attraverso più approfonditi tentativi di analisi contestuale e strutturale, nei
quali consiste l'essenza di ciò che, più o meno vagamente, suole intendersi come
metodo combinatorio: com- plesso di operazioni che non ha, dunque, capacità di
rivelazioni ermeneutiche primarie, ma svolge una funzione secondaria di
verifica, precisazione ed estensione dei dati acquisiti. Si tratta di
controllare la ricorrenza delle singole parole, valutarne la posizione e i
rapporti, studiarne le forme, prospettarne le funzioni, distinguere frasi e
partizioni dei testi, e così via. Molte volte i risultati di queste indagini
ricostruttive sono ovvii o altamente probabili: quasi un semplice prolungamento
delle nozioni di partenza, con conseguente ampliarsi delle zone di traducibilità
praticamente sicura. Altre volte invece si tende a costruire ipotesi ingegnose,
ma non dimostrabili, spesso contrastanti tra loro, o a costruire ipotesi sopra
ipotesi, e a sostenerle puntigliosamente, sino a dare l'impressione di una
gigantesca macchina girante a vuoto: ciò che costituisce appunto il limite
degenerativo di tanta parte dei tentativi «combinatorii» degli ultimi decenni,
cui va reagito con un maggiore senso di misura e di prudenza.
Occorre infine
riconoscere e sottolineare con chiarezza che non soltanto tutte le conquiste
sino ad oggi realizzate nel processo d'interpretazione dei testi etruschi, ma
anche l'intero patrimonio di conoscenze sulle caratteristiche e sulla struttura
della lingua etrusca di cui si darà conto nel capitolo successivo derivano in
ultima analisi da quei dati di evidenza primaria sui quali si è ritenuto
opportuno insistere nelle pagine che precedono. Lo studio linguistico è
nettamente conseguente all'originaria certezza dei significati, e non
viceversa.
Alfabeto etrusco
Si riporta
brevemente l’alfabeto etrusco, visto nelle diverse fasi del periodo
etrusco:
Nella seguente tabella si confrontano gli alfabeti delle
principali lingue del mondo classico:
Inoltre, si confrontano
gli alfabeti delle principali lingue italiche:
Etrusco
Osco
Umbro
Volsco
Piccolo vocabolario
etrusco
In questo vocabolario, uso le due lettere sh per rappresentare la
lettera M Etrusca, scritto normalmente con s'.
ais, plurale
aisar, dio.
am, esser.
an, egli, ella.
apa, padre.
ati, mader.
avil,
anno.
clan, figlio.
eca, questo.
fler, offerta, sacrificio.
hinthial, anima.
in, esso.
lauchum, re.
lautun, famiglia.
mi, mini, Io, me.
mul-, offrire, dedicare.
neftsh, nipote.
puia,
moglie.
rasenna or rasna, Etrusco.
ruva, fratello.
spur- or shpur-,
città.
sren or shran, figura.
shuthi, tomba.
tin-, giorno.
tular, confini.
tur-, dare.
zich-, scrivere.
zilach, un tipo di
magistrato.
Numerali:
1. thu
2. zal.
3. ci.
4. sha.
5. mach 6. huth.
7. semph.
8. cezp.
9. nurph.
10. shar.
Trascrizione delle iscrizioni
Le
trascrizioni delle lettere etrusche qui adottate sono conformi agli usi più
comuni tra gli etruscologi. Ciò a comportato la composizione di segni-immagini
appositamente create , , , etc. che potessero essere viste con qualsiasi
sistema operativo. La soluzione non è molto elegante sul piano tipografico, ma
non crea confusioni di lettura rispetto ai simboli tradizionali.
Per la
trascrizione delle spiranti si sono impiegati i simboli tradizionali (quelli del
Thesaurus Linguae Etruscae e del Corpus Inscriptionum Etruscarum), sebbene vari
autori si siano adeguati al sistema del Prof. Helmut Rix, sistema che dà luogo a
qualche arbitrarietà, poiché presuppone una precedente ipotesi sulla provenienza
dell’iscrizione. I valori delle lettere dell’alfabeto etrusco sono noti da
parecchio tempo anche nelle varietà locali. L’unico problema riguarda il suono
marcato dal san o tsade nell’area meridionale che equivale al suono marcato
dal sigma comune a tre tratti al Nord e al sigma a quattro tratti usato a
Caere. Il prof. H. Rix ha riportato in auge una vecchia ipotesi di A. Pauli,
secondo cui l’etrusco ha una spirante postdentale [s] e una spirante palatale
[ ] (quella di it. sci, ingl. shape, franc. chou etc.). Questa tesi va
acriticamente prendendo piede presso altri etruscologi, sebbene non possa
basarsi su alcuna prova epigrafica e linguistica. Secondo un’altra ipotesi,
sostenuta da M. Durante (in Studi in onore di V. Pisani, I, Brescia 1969, pp.
295-306) e caldeggiata da M. Cristofani (Introduzione allo studio dell’etrusco,
Firenze 1991), i grafemi suddetti marcano /ss/: lo dimostrerebbe il fatto che il
suffisso patronimico e gamonimico -sa (al Nord) o - a (al Sud) è trascritto in
caratteri latini come -ssa.
L’ipotesi che il san meridionale e il sigma
settentrionale esprimano [ss] potrebbe essere accettata senza grosse obiezioni
quando tale grafema non è all’inizio della parola; ma per i numerosi termini
“meridionali” che iniziano col san e “settentrionali” che iniziano col sigma
occorrerebbe supporre una “tensione dei muscoli orali” (per usare le parole del
Cristofani) che contrasta con le regole dell’economia fonetica. È probabile che
nell’etrusco recente questo potesse essere uno degli esiti del suffisso
suddetto. Occorre però notare che a volte il suffisso è scritto -za sia in
caratteri latini che etruschi e che anche altri dati epigrafici (ad es. la serie
ut(u)s e / u uze / utu e / utuse) mostrano come i grafemi in questione
marcassero un’affricata postdentale o un suono confondibile con essa. A nostro
avviso il san meridionale (Volsinii, Vulci, Tarquinia, Campania), il sigma al
Nord (Chiusi, Perugia, Cortona, Siena, Volterra, Vetulonia, Populonia, Emilia,
Adria) e il sigma a quattro tratti di Caere marcano appunto un suono affricato
postdentale, che spesso è l’esito di un incontro s+t o di un originario gruppo
st- . Come afferma ad es. André Martinet, in latino i gruppi -ts- originari si
risolsero in -ss-. Quindi anche nel tardo etrusco la particolare affricata
posdentale marcata dai simboli suddetti, forse più prolungata di /z/, si sarebbe
risolta ora in -ss- ora in -zz- (sorda) quand’era in posizione
intervocalica.
In alcune iscrizioni della zona di Cortona, e in
particolare nella Tabula Cortonensis, è usata una e rovesciata che qui viene
riprodotta con lo stesso simbolo. Dall’esame della Tabula Cortonensis si deduce
che essa marca tre diversi suoni:
1) una e con indebolimento verso i, come
nei derivati di *pet- (p tkeal, p tr-), in t csinal, s tmnal etc.
2) una
tendenza all’atonìa a favore della liquida o nasale successiva (p rkna, t rsna,
c n, t n a) o una colorazione verso o (ad esempio i casi in cui si ha lat. ol,
rispetto a etr. el : nel gruppo vel- di V l, V lara, V l inal, V l ur, V lusina,
V l e e poi in F l ni, liunt , t l; in C latina e anche in pru che pare avere la
base di lat. oper-.
3) una e lunga e chiusa in Sc va < Skaiva, Sc v <
Scevai , An < Anei , sparz te < *sparzaite che corrisponde all’uso del
digrafo ei nell’umbro scritto in caratteri latini.
In alcune
iscrizioni dell’area senese e nel Fegato di Piacenza è usata una particolare
forma a U o V rovesciato ( ) per marcare /m/. Ad esempio le iscrizioni
si leggono
1 = l . hepni . hermes 2avial
2 = herme .
hereni 2 lar al.
Nell’iscrizione 2 sono notevoli le forme di m e di h
; in 1 sono notevoli le legature di lettere che realizzano ep e
me.
Iscrizioni indicanti alfabeti
Si riportano brevemente esempi di alfabeti rinvenuti su reperti
archeologici
1. a b c d e v z h i k l m n s o p ś q r s t u
2. a b c d v e z h i k l m n o r ś q s t u
1 Alfabeto
modello inciso su una tavoletta di avorio, da Marsiliana (agro di Vulci; VII
sec. a. C.). Si notino le spiranti , M, , X.
2 Alfabeto inciso
sull’anforetta di Formello (presso Veio; VII sec. a. C.) con le spiranti , M,
, X.
3 Parte di alfabeto scritto su un bucchero del VI secolo a. C.,
trovato a Ferentum.
a c e v z i k l
4. Alfabeto inciso sul
letto funerario di una tomba di Magliano (Toscana), VI sec. a. C.
a e v z
h i k l m n p r s t u f
5. Alfabeto inciso su un vaso
perugino della seconda meta’ del VI secolo a. C.
a e v z h i k l m n p
r s t u
Dopo l’alfabeto sono scritte 4 lettere, in senso opposto: tafa
(altri leggono abat o afat).
6. Alfabeto su ciotola proveniente
dagli scavi presso Roncoferraro (Mantova). L’alfabetario, che risale
al IV
sec. a. C., rispecchia fedelmente le norme ortografiche dell’Etruria padana, da
Spina a Bologna.
a e v z h i k l m n p r s t u f
7.
Alfabeto scritto su un fondo di vaso trovato a Poggio Moscini (Bolsena) e datato
al II secolo a. C. ] c e v z h i l m n p r s t u [
Il Cippo di
Perugia
E' un cippo rettangolare di travertino, ritrovato
nei dintorni di Perugia e conservato ora al Museo archeologico della
città.
L'iscrizione corre per 24 righe sulla facciata e continua su una delle
supertìci per 22 righe, per un totale di 128 parole.
La scrittura è quella in
uso a Perugia tra III e II secolo a.C.
Il testo, a carattere giuridico, e la
trascrizione su pietra di una sentenza relativa a questioni di proprietà tra le
famiglie perugine dei Velthina e degli Aftuna.
Il Fegato di Piacenza
L’argomento è stato già affrontato nella sezione archeologica relativa a
Piacenza. In questo paragrafo affronteremo l’aspetto linguistico e la sua
interpretazione.
Il fegato etrusco di bronzo ha le seguenti
dimensioni: mm 126 x 76 x 60.
Per l'esame delle viscere esso veniva
capovolto di sotto in su perché la parte inferiore era ritenuta la più
importante, su questa si alzano tre protuberanze che sporgono: la più piccola a
forma semi mammellare (il processus papillaris), la seconda piramidale (il
processus pyramidalis), la terza è la cistifellea.
Su questa superficie
si trovano quaranta iscrizioni che si riferiscono a nomi di divinità tra le
quali sono identificate: Tin (Giove), Uni (Giunone), Neth (Uns), (Nettuno),
Vetisi (Veiove), Satres (Saturno), Ani (Giano), Selva (Silvani), Mari (Marte),
Futlus (Bacco), Cath (Sole), Herole (Ercole), Mae (Maius) e altri cinque o sei
che non hanno corrispondente nella religione romana. Nella parte convessa si
trovano due iscrizioni, una su di un lobo (Usils = parte del sole), l'altra
sull'altro (Tivs = parte della luna). Il fegato di bronzo reca attorno al
margine esattamente sedici caselle contenenti ciascuna il nome di una divinità e
queste sedici caselle corrispondono alle altrettante parti in cui gli Etruschi
dividevano il cielo.
Fegato di fronte e trascrizione
Sul fegato etrusco sono stati fatti molti studi, i più importanti furono
quelli dei ricercatori tedeschi Deecke (1880), Korte (1905), Thulin (1906) che
misero in risalto l'importanza di questo cimelio archeologico definendolo un
documento fondamentale per la conoscenza della religione e della lingua etrusca.
Ma a che cosa serviva questa riproduzione bronzea di un fegato di pecora con
tante iscrizioni in lingua etrusca? Il Korte lo confrontò con il coperchio di
un'urna cineraria ritrovata a Volterra che rappresentava un sacerdote (3° secolo
a.C.) che tiene in mano un fegato come quello ritrovato a Ciavernasco di
Settima, vicino al ponte della Ragione. Dunque il nostro bronzo è uno strumento
originale della “disciplina”; l'aruspice interpretava il volere divino da segni
particolari riscontrati nel fegato della vittima sacrificata, cioè poteva
prevedere se un'impresa si sarebbe compiuta sotto influssi favorevoli o
sfavorevoli, confrontando il viscere ancora caldo col modello bronzeo inscritto,
che fungeva da guida, da prontuario.
Il Fegato Etrusco risale al periodo tra
il secondo e il primo secolo avanti Cristo (come denunciano le caratteristiche
delle scritture usate nelle iscrizioni) e non all'epoca della dominazione
etrusca nella Pianura Padana (V - IV - sec. a.C.). Quindi il fegato non è da
ritenersi un documento della dominazione etrusca nella provincia di Piacenza, ma
un oggetto prodotto successivamente da nuclei etruschi presenti nelle colonie
tra Pesaro e Rimini o nella stessa Piacenza, oppure è da ritenersi un oggetto
erratico perduto da un auspice che seguiva una legione romana (Ducati). La sua
relativa "tardità" nulla toglie all'interesse che desta in noi, perché
rappresenta una lunga tradizione conservatasi intatta attraverso i secoli
(Terzaghi). Più di quaranta saggi sono stati pubblicati in tutto il mondo sul
Fegato piacentino, ciò testimonia la "fama" a livello mondiale del nostro
reperto, unico esemplare nella sua forma (esiste un altro Fegato di Alabastro al
museo Guarnacci di Volterra); modelli di fegato con le stesse caratteristiche
suddivisioni, sono stati ritrovati a Babilonia, nella valle del Tigri e
dell'Eufrate e ad Hattusas la capitale degli Ittici. Questi sono in terra cotta
ma utilizzati con lo stesso scopo religioso di quello di Piacenza.
Esiste anche un’interpretazione geografica del fegato, di cui si riporta una
breve descrizione:
· le scritte sulla parte posteriore della mappa
indicano le due regioni principali della mappa, la parte meridionale LIVR (o
TIVR, non e' chiara la lattera iniziale) diventa YHDS (oppure T-HDS) che ricorda
sia la parola GIUDA che la HADESH (Kadesh) storicamente famosa e attualmente
localizzata erroneamente nella Siria mediorientale
· la regione
settentrionale viene invece denominata YSILS che diventa P^HY^, leggibile come
PNHYN (in queste scritte le due lettere S etrusche appaiono unificate e quindi
c'e' equivalenza tra la N semitica e la sua quasi uguale ^, la lettera "muta"),
la regione del monte PAN-Cervino nonche' legata alla questione punica Tra le
scritte delle singole regioni appaiono evidenti le seguenti
interpretazioni:
· la montagna a forma di conoide, il monte Cervino,
si presenta con la scritta TLUS che diventa TYP^ (TYPN), il nome della divinita'
TIFEO (TIFONE)
· Tifeo-Tifone e' legato storicamente ai vulcani
dell'Italia meridionale, dall'area vesuviana al vulcano Etna e difatti nella
mappa compare la scritta TYP^ esattamente nel settore che corrisponde alla
Campania e nello spicchio esterno corrispondente alla Sicilia
· tra
la regione Sicilia (TLUS che diventa TYP^) e la regione Calabria c'e' un segno
lungo che indica chiaramente lo stretto di Messina
· la regione
Calabria, indica con il nome LEThA tale stretto di Messina e la parola diventa
YG-ZB
· a prescindere dal significato suo originale (per esempio Z-B,
"questo e' il padre"), ZB e' lo ZEB famoso nelle cronache assire, un fiume che
nasce dal Monviso, scorre nell'Adriatico, passa dallo stretto di Messina e
arriva a sfociare nell'oceano Atlantico
· che la parola ZB sia legata
a questo fiume appena descritto lo ritroviamo nella parola accanto al Monviso,
che anch'essa la si legge come YG-ZB-K (LEThAM etrusco)
· sappiamo
per certo che il fiume ZEB erano due, uno meridionale e uno settentrionale, e
difatti troviamo aldila' della catena alpina, dove nasce il fiume Danubio, la
parola CAThA che diventa tB-ZB, il "doppio Zeb", o meglio l'altro Zeb da
identificare come Danubio
· nella parte centrale del fegato abbiamo
la catena alpina e sotto di essa abbiamo il fiume che nasce dalla protuberanza a
sinistra, il Po e il Monviso
· la catena montuosa alpina si abbassa
nella parte occidentale
· l'ultima lingua della protuberanza
rappresenta la striscia morenica all'imbocco della valle d'Aosta (la piu' grande
morena glaciale d'Europa, un panorama unico che lo si nota fin da
lontano)
· si raggiunge cosi' la zona della grande piramide, cosi'
alta da essere visibile da tutta la pianura
· finche' siamo in
pianura la piramide e' rappresentata dal Monterosa (un riferimento unico per
come si distingua nettamente dal resto della catena)
· girando dietro
la morena ed entrando nella valle d'Aosta la vera montagna-piramide la
identifichiamo con il monte Cervino
· la regione Toscana appare come
YD^Y, chiaramente legata a Giuda e la parola successiva contiene il DG che
contraddistingue la civilta' etrusca, il VEL che diventa appunto DGY, con DG
uguale a "pesce" ma anche ai successivi DOGI
· la regione delle
Marche appare come "tHYGL", chiaramente legata ai TIGLAT assiri di cui troviamo
tracce nei reperti Piceni
· la regione degli Abruzzi appare come
NGY-DB e sembra legata all'influenza della lingua ungherese (non e' un caso che
sia cosi' dato che il popolo Israelitico abitava a fianco di altre popolazioni e
gli stessi Edomiti balcanici presero il loro posto durante le deportazioni),
SELVA diventa NGY-DB, il "grande dio" ("nagy deba")
· la stessa
scritta NGY-DB la ritroviamo difatti nella zona balcanica a mostrare il
collegamento di questa regione italica con quelle
balcaniche-danubiane
· nelle regioni tedesche, nella parte
settentrionale della mappa, troviamo riferimenti ai "fasci", P-Sh (con la P che
semiticamente si tramuta facilmente in F, come Fenici e Punici)
· la
parte piu' settentrionale, all'incirca la Danimarca, viene scritta come TINSRNE
che diventa THLNS-LG, i "luoghi di Atlans" e mi sembra ovvio come questo abbia
portato a considerare anticamente Atlante colui che sostiene il mondo (e' questa
la regione dove si e' piu' vicini al cielo della stella polare) e anche
Atlantide trova qui la sua localizzazione
Le Lamine di Pyrgi
Nel
1964, a Santa Severa, cittadina che sorge sull'antica Pyrgi, il porto di Caere,
vennero alla luce, durante gli scavi diretti da Massimo Pallottino, tré lamine
d'oro: su una era inciso un testo in lingua punica, sulle altre due un testo
etrusco. Le lamine erano state accuratamente nascoste, all'epoca della
distruzione del santuario, in una vasca scavata fra il tempio A ed il tempio B.
Se è vero che il testo in lingua punica non presenta problemi insormontabili,
nessuno ci dice che l'etrusco ne costituisca la traduzione. Possiamo solo
comparare i nomi propri che figurano nei due testi. Ad esempio, nella lamina
punica un personaggio è definito "re delle genti di Caere": ora, sappiamo che in
quell'epoca la città non aveva re.
(scrive il dott. Massimo Pittau, insigne
linguista) Il solo dato certo è che le due versioni parlano dello stesso
argomento, cioè di un trattato stipulato fra Caere e Cartagine; i contraenti
invocano a testimoni del patto le divinità tutelari di entrambe le nazioni. Nei
due testi si riconosce il nome del magistrato di Caere, Thefarie Velianas, che
avrebbe dedicato un santuario ad Uni. Sappiamo che le cerimonie religiose
celebrate a conclusione dell'accordo si svolsero secondo il rito punico.
Purtroppo nella lamina in punico non esiste la traduzione di un solo termine
etrusco per noi nuovo. Si riporta il testo redatto dal Prof . Massimo Pittau,
studioso di lingua etrusca. Circa 40 anni fa, e precisamente nel 1964, si è
avuta una scoperta archeologica e linguistica che ha colpito in maniera
immediata e notevole il mondo degli studiosi specialisti della civiltà antiche,
e non soltanto questi: a Pirgi, cioè nel porto della città etrusca di Cere
(attuale Cerveteri), durante gli scavi condotti in un santuario di cui si aveva
già notizia per antiche testimonianze storiche, nei resti di un piccolo locale
interposto fra i due templi, sono state trovate tre lamine d'oro. Su queste
risultano incise delle scritte, due in lingua etrusca ed una in lingua punica o
fenicia, le quali sono state riportate alla fine del sec. VI od ai primi anni
del V a.C.
Etrusco
Punico
La notizia rimbalzò da un capo all'altro nel mondo dei dotti, anche
per l'immediata prospettiva che si intravide di avere finalmente trovato
iscrizioni etrusche abbastanza ampie con la traduzione in un'altra lingua
conosciuta e quindi con la speranza di vedere proiettate sulla lingua etrusca,
scarsamente conosciuta, nuove ed importanti cognizioni da parte della lingua
fenicio-punica, che invece è conosciuta in maniera discreta. Senonché questa
speranza cadde quasi immediatamente, quando si intravide che l'iscrizione in
lingua fenicio-punica e quella maggiore in lingua etrusca si corrispondono tra
di loro, sì, ma non costituiscono affatto un esatta "traduzione" l'una
dell'altra, cioè si intravide che si ha da fare non con un «testo bilingue
etrusco-punico», bensì con un «testo quasi-bilingue etrusco-punico», nel quale
cioè i due testi si corrispondono solamente a grandi linee.
D'altronde quella
speranza cadde in larga misura, anche per la circostanza negativa che pure il
testo punico si rivelò subito scarsamente aggredibile in fatto di
interpretazione e di traduzione effettiva e minuta. Dopo circa un quarantennio
di studio ermeneutico molto intenso delle lamine di Pirgi, condotto sia dagli
specialisti della lingua etrusca sia da quelli della lingua punica, le
conclusioni alle quali si è alla fine pervenuti sono che da un lato alla
conoscenza dell'etrusco sono venute dal testo punico alcune conferme
significative, ma purtroppo anche molto ridotte in quantità e in qualità,
dall'altro la traduzione dei due testi, condotta in maniera comparativa, implica
purtroppo numerosi e grandi punti oscuri sia per l'uno che per l'altro. E la
presa di posizione ultima che gli specialisti delle due lingue hanno assunto, in
maniera esplicita od anche implicita, è che convenga mandare avanti l'analisi e
la interpretazione e traduzione di ciascuno dei due testi in maniera
sostanzialmente indipendente l'uno dall'altro, nella quasi certezza che si ha da
fare con due versioni alquanto differenti di un identico messaggio relativo ad
un certo evento storico: la consacrazione, da parte di Thefario Velianio,
lucumone o principe-tiranno di Cere, di un piccolo edificio religioso in onore
della dea Giunone-Astarte.
Per parte mia premetto che il mio presente
intervento sui testi etruschi delle lamine di Pirgi trova la sua motivazione in
due importanti circostanze: in questi ultimi quasi quarant'anni che ci separano
dalla scoperta delle lamine, la conoscenza dell'etrusco ha effettuato numerosi
ed importanti passi in avanti, conseguenti sia al ritrovamento di altro
materiale documentario e quindi ad una più ampia e più esatta documentazione
della lingua etrusca, sia al conseguente ulteriore approfondimento scientifico
che ne hanno effettuato gli specialisti, soprattutto quelli di estrazione
propriamente linguistica. Procedo adesso a presentare il testo delle tre lamine
prima nella loro effettiva documentazione epigrafica e dopo nel loro ordinamento
propriamente linguistico, infine la mia traduzione ed il mio commento
storico-linguistico di ciascuna.
1ª lamina con iscrizione in lingua
etrusca
cioè
Traduzione: «Questo thesaurus e queste
statuette sono divenuti di Giunone-Astarte. Avendo la protettrice della Città
concesso a Thefario Velianio due [figli] da Cluvenia, (egli) ha donato a ciascun
tempio ed al tesoriere offerte in terreni per i tre anni completi di questo
Reggente, offerte in sale (?) per la presidenza del tempio di questa (Giunone)
Dispensatrice di discendenti; ed a queste statue (siano) anni quanti (sono) gli
astri!».
tmia «thesaurus, tesoro di santuario», da confrontare col greco
tameîon «tesoro o tesoreria» (vedi sotto tameresca); si trattava di una di
quelle edicole che una città o il suo regnante costruiva accanto ai grandi
santuari per esporvi i doni offerti alle rispettive divinità, anche con finalità
propagandistiche di immagine esterna nei confronti dei numerosissimi
frequentatori dei santuari. ita tmia icac heramasva «questo thesaurus e queste
statuette». Il pronome dimostrativo ita «questo» corrisponde perfettamente ad
ica «questo», per cui è da escludersi che in questo passo dietro le due varianti
esista una qualche distinzione. L'uso così ravvicinato che lo scrivano ha fatto
delle due varianti può essere stato determinato, al livello di meccanismo
inconscio, dalla attrazione delle consonanti vicine: ita t- e
ica-c.
heramasva «statuette», in cui -s(a)- è una variante del noto suffisso
diminutivo -za, mentre -va è la ugualmente nota desinenza del plurale (vedi
avanti heramve). Probabilmente le statuette erano due, una per ciascuno dei
figli di Thefario Velianio, e ancora probabilmente raffiguravano i due bambini
oppure due animali che simbolizzavano altrettante vittime da immolare alla
divinità.
vatiekhe «sono venuti, sono divenuti», forse da confrontare col
lat. vadere; è al preterito debole attivo, in 3ª persona
plurale.
unialastres, da distinguere in unial-astres «di Giunone-Astarte», è
da confrontare con fuflunsul pakhies «di Funfluns-Bacco» dell'iscr. TLE-TET 336,
prove evidenti, l'una e l'altra, di interpretazione od assimilazione
sincretistica di dèi stranieri in origine differenti. Una spiegazione unitaria
del vocabolo in senso totalmente etrusco è da respingersi perché inspiegabile
dal punto di vista morfologico; d'altronde anche l'iscrizione punica nella prima
riga richiama esplicitamente Astarte: L'STRT.
vatiekhe unialastres «sono
divenuti di Giunone-Astarte», cioè, dopo la dedicazione e la consacrazione ormai
«appartengono a Giunone-Astarte».
themiasa probabilmente significa «che ha
concesso, avendo concesso», participio passato attivo (LEGL 124), da connettere
con thamuce «concesse» della 3ª lamina.
mekh il contesto ci spinge a
reintegrare una l morfema del genitivo, cioè mekhl «della città, della
città-stato, dello Stato, del Popolo», in questo caso "della città-stato di
Cere"; vedi mekhl dell'iscr. CIE 5360 di Tarquinia e della Tabula Cortonensis
(capo I).
thuta «tutore, protettore-trice, patrono-a»; cfr. ati thuta «madre
protettrice» dell'iscr. TLE-TET 159; è da confrontare col lat. tutor, tutrix,
che è privo di etimologia (DELL s.v. tueor) e che pertanto potrebbe derivare
proprio dall'etrusco.
thefariei è un prenome maschile, che corrisponde a
quello lat. Tiberius; è in dativo asigmatico (LEGL 80, 2°). In velianas non
compare la desinenza del dativo a norma della "flessione di gruppo"; invece la
-s è quella dell'originario genitivo patronimico ormai fossilizzata (LEGL
78).
sal «due». Non si può affatto escludere che questo sia l'esatto
significato di sal con la considerazione che la compresenza di zal e sal nel
Liber linteus della Mummia vieterebbe che i due vocaboli avessero il medesimo
significato, come ha scritto M. Pallottino, Saggi, 648; infatti l'alternanza
zal/sal «due» si riscontra anche nella Tabula Cortonensis (capo I).
cluvenias
gentilizio femm. (in genitivo), che trova riscontro in quello lat. Cluvenius
(RNG).
munistas «del monumento o edificio o tempio», letteralmente «di questo
monumento ecc.», da distinguere in munis-tas (in epoca recente sarebbe stato
munists), in genitivo di donazione (LEGL 104, 136).
thuva(-s) probabilmente
aggettivo riferito a munistas e pur'esso in genitivo; siccome sembra derivato da
thu «uno», probabilmente significa «singolo», «ciascuno», con riferimento a
ciascuno dei due templi che costituivano il complesso sacrale di
Pirgi.
tameresca (tameres-ca) «e del tesoriere» del tempio, anch'esso in
genitivo di donazione; vedi tamera «dispensiere, tesoriere, questore» delle
iscr. TLE-TET 170, 172, 195, da confrontare col greco tamías «dispensiere». Per
la congiunzione enclitica -ca vedi hamphisca, laivisca del Liber linteus e
fariceka dell'iscr. TLE-TET 78.
ilacve «offerte» (plur.) (LEGL
69).
tulerase «in terreni» e sarebbe il dativo sigmatico plur. di tul
«confine, terreno, territorio», plur. tular = lat. fines «confine,-i» e
«terreno,-i, territorio» (LEGL 80, 1°).
nac «per, in», preposizione che nella
frase ci avil khurvar «per i tre anni completi», avente un implicito valore
"temporale", mostra di reggere l'accusativo, mentre nella frase seguente nac
atranes zilacal «per la presidenza del tempio», avente un implicito valore
"finale", mostra di reggere il genitivo.
khurvar siccome richiama il lat.
curvus, è probabile che significhi «circolari», ma qui col significato di
«completi» (aggettivo plur.) (LELN 122).
tesiameitale, da confrontare con
tesinth «curatore, comandante, capo» dell'iscr. TLE-TET 227 (LEGL 124); lo
traduco «di questo Reggente» per il fatto che non si riesce a capire quale fosse
l'esatta posizione giuridico-istituzionale di Thefario Velianio rispetto alla
città-stato di Cere, anche se si ha l'impressione che fosse un
"Principe-Tiranno", come quelli che di volta in volta si impadronivano del
potere in numerose poleis greche. Inoltre è ragionevolmente ipotizzabile che
egli fosse stato aiutato dalla potente Cartagine nella sua conquista del potere
a Cere; ed in questo modo e per questa ragione si comprenderebbero bene sia la
assimilazione effettuata nella lamina tra la etrusca Giunone e la fenicia
Astarte, sia la versione in lingua punica dell'iscrizione etrusca di questa 1ª
lamina. In proposito è appena da ricordare la notizia data da Erodoto (I 166,
167; VI 17) della lega politico-militare che si era stabilita fra Cere e
Cartagine, la quale aveva attaccato i Focesi della colonia greca di Alalia, in
Corsica, nella battaglia navale del Mare Sardo (circa 535 a.C.) e, pur con un
esito militare incerto, li aveva costretti a sloggiare dalla Corsica. Il
vocabolo è da distinguere in tesiame-itale, con -itale genitivo del pronome
dimostrativo ita «questo-a» in posizione enclitica; in epoca più recente sarebbe
stato -itle e cioè *tesiameitle (cfr. il seguente seleitala).
alsase «in
sale» (?), in dativo sigmatico come tulerase, ma al sing.; in questa
supposizione sarebbe da richiamare il greco áls ed il lat. sal, inoltre il nome
della città etrusca di Alsium sulla costa tirrenica presso Cere andrebbe
spiegato con riferimento alla estrazione del sale. È appena da ricordare il
grande valore che aveva il sale in epoca antica, anche per la conservazione
delle carni e dei pesci. In subordine prospetto che ilacve alsase significhi
«offerte (in terreni) ad Alsium».
atrane(-s) sembra un aggettivo derivato
dall'etr.-lat. atrium «atrio» ed anche «tempio», per cui significherebbe
«templare, del tempio» (in genitivo).
zilacal (zilac-al) «della prefettura o
presidenza» templare o del tempio.
seleitala «di questa Dispensatrice», da
confrontare con selace «ha elargito» della 3ª lamina; è da distinguere in
sele-itala, con -itala ancora genitivo del pronome dimostrativo ita in posizione
enclitica e forse al femm. (cfr. venala dell'iscr. TLE-TET 34); in età più
recente sarebbe stato *seleitla (cfr. tesiameitale) (LEGL 107).
acnasvers
probabilmente «d(e)i discendenti o successori» (genit. plur.), da confrontare
con acnanas «che lascia, lasciando», acnanasa «che ha lasciato, avendo lasciato»
(LEGL 123, 124).
itanim (itani-m) probabilmente «ed a questi-e», dativo plur.
di ita «questo-a», da confrontare con etan «questo-a» (accusativo; TLE-TET 620,
Cr 3.24). Però potrebbe corrispondere al più recente etnam «poi, inoltre, in
verità» = lat. etenim «(e) infatti, in realtà, in verità», per cui la frase
andrebbe tradotta: «In verità le statue (abbiano tanti) anni quanti (sono) gli
astri!». In ciascuna delle due soluzioni si deve pensare ad una frase ottativa,
che per ciò stesso spiegherebbe l'ellissi del verbo. È del tutto errato
affermare - come ha fatto un archeologo - che non esistono proposizioni ottative
che sottintendano il verbo: ne esistono in tutte le lingue, ad es. la locuzione
italiana Alla salute! sottintende questo sia o torni alla tua (vostra o nostra)
salute!; la frase augurale Auguri agli sposi e figli maschi! sottintende ed
abbiano figli maschi!
heramve «statue» (plur.), quelle offerte a
Giunone-Astarte da Th. Velianio per i suoi due figli, probabilmente due, cioè
una per ciascuno; è da confrontare col greco hérma «erma, base, sostegno,
puntello, cippo (anche funerario), cippo con figura di Ermes», dio Hérmes
«Ermes», fiume Hérmos della Lidia (finora privi di etimologia, ma probabilmente
anatolici e lidî; GEW, DELG) ed inoltre con la glossa etr. Ermius «agosto» (ThLE
416).
eniaca «quanti-e».
pulumkhva «astri, stelle» (plur., LEGL 69),
significato assicurato da un corrispondente vocabolo della iscrizione
punica.
2ª lamina con iscrizione in lingua fenicio-punica
«Alla signora Astarte questo sacello ha fatto e donato Tiberio
Velianio re di Cere, nel mese di Zebah, come dono nel tempio e nella cella,
perché Astarte ha favorito il suo fedele, nel terzo anno del suo regno, nel mese
di KRR, nel giorno della sepoltura della divinità. E gli anni della statua della
divinità siano tanti quanti (sono) gli astri».
Questa traduzione
della 2ª lamina è stata da me derivata da quelle correnti prospettate da
specialisti della lingua fenicio-punica, ma adattata alla mia personale
traduzione della 1ª iscrizione in lingua etrusca. Su questa mia traduzione però
non intenderei insistere, per il motivo che sono consapevole di non avere una
sufficiente competenza su questa lingua, tale da osare di confrontarmi coi
colleghi semitisti. L'unica cosa che mi sento di dire è che quasi certamente lo
scriba che ha stilato l'iscrizione fenicio-punica era un cartaginese, il quale
non comprese bene l'iscrizione stilata dal suo collega etrusco; e soprattutto da
questo fatto saranno derivate le discrepanze tra le due iscrizioni.
3ª
lamina con iscrizione in lingua etrusca
cioè:
«Così Thefario Velianio ha concesso l'offerta del
corrente mese di dicembre (ed) ha fatto elargizioni a Giunone. La cerimonia
degli anni del thesaurus è stata la undicesima (rispetto a)gli astri». Oppure
«Così Thefario Velianio ha concesso l'offerta del corrente mese di dicembre a
Giunone (ed) ha fatto elargizioni (al tempio). La cerimonia degli anni del
thesaurus è stata la undicesima (rispetto a)gli astri».
Sia il
cambio di grafia fra le due lamine scritte in etrusco sia la differenza tra la
forma del gentilizio Velianas della prima e Veliiunas di questa ci assicurano
che ciascuna delle due lamine è stata scritta da un differente scrivano.
Probabilmente il nome del committente in realtà suonava Vélinas, cioè con
l'accento sulla prima sillaba e con la vocale posttonica indistinta.
thamuce
«concesse, ha concesso»; nell'iscr. CIE 5357 compare come thamce, cioè sincopato
(vedi themiasa della 1ª lamina).
etan(-al) interpreto «(del) presente o
corrente», intendendolo come derivato dal pronome dimostrativo eta
«questo».
masan probabilmente «dicembre» oppure, in subordine, «novembre», e
corrisponde alla forma sincopata masn del Liber linteus.
tiur «mese». masan
tiur sono privi della desinenza del genitivo ai sensi della "flessione di
gruppo" (LEGL 83-84).
unia(-s) «(di) Giunone» in genitivo di donazione o
dedicazione (LEGL 136).
vacal «rito sacro, cerimonia»; nel Liber linteus
figura sincopato in vacl.
tmial «del thesaurus» (genit.); vedi 1ª
lamina.
avilkhval (avil-khva-l) «degli anni», in genitivo plur. (LEGL
74).
amuce «fu, è stato».
pulumkhva «per, rispetto agli astri», i quali
segnavano il passare del tempo; è un complemento di tempo con morfema
zero.
snuiaph «undici»; già Marcello Durante aveva intravisto che si tratta
di un numerale. Secondo G. Giannecchini («La Parola del Passato», 1997),
indicherebbe il numero «dodici»; io lo escluderei, visto che in etrusco «dodici»
molto probabilmente si diceva sranczl (LEGL 96). Comunque questo divario di un
numero non implicherebbe alcuna differenza effettiva, per effetto del modo in
cui la gente spesso effettua la numerazione, cioè saltando sia il terminus a quo
sia il terminus ad quem. Dunque la commemorazione della prima fondazione e
dedicazione del thesaurus venne fatta undici/dodici anni dopo, secondo un numero
che nei tempi antichi aveva anche una valenza sacrale in virtù delle dodici
lunazioni della luna. E per questo motivo si spiega la diversità dello scrivano
della 1ª lamina rispetto a quello della 3ª.
Molto notevole è il fatto che in
questa 3ª lamina non si faccia alcun riferimento alla fenicia Astarte e che a
questa iscrizione etrusca non ne corrisponda una analoga punica: nella
verosimile supposizione che ho fatto a proposito della 1ª lamina, evidentemente
Thefario Velianio negli undici/dodici anni trascorsi aveva ormai rafforzato il
suo potere su Cere, per cui non aveva più bisogno dell'aiuto di Cartagine e
tanto meno di ringraziarla pubblicamente.
La Mummia di Zagabria
Il
manoscritto della "Mummia di Zagabria" è un "liber linteus" eseguito a
inchiostro con un pennello su di un drappo di lino. E' suddiviso in dodici
riquadri rettangolari ognuno con 34 righe della scrittura. Il drappo veniva
ripiegato "a fisarmonica" seguendo le linee verticali dei riquadri che
funzionavano dunque come le pagine di un libro.
Attualmente si conserva al
Museo Archeologico di Zagabria ma è stato ritrovato in Egitto, dove era stato
"riciclato" tagliandolo orizzontalmente in lunghe strisce, che furono utilizzate
come bende per una mummia.
Solo alcune delle strisce sono conservate, per
cui il manoscritto ha grosse lacune. Il testo è in assoluto il più lungo tra
quelli etruschi, esso consta infatti di 230 righe e di circa 1350 parole. Il
testo ha una storia molto curiosa: verso la metà dell'Ottocento un collezionista
croato (Mihail de Brariæ, scrittore della Regia cancelleria ungherese) aveva
riportato in patria dall'Egitto, secondo l'uso dell'epoca, alcuni oggetti
antichi, fra i quali una mummia. Qualche tempo dopo ci si accorse che le bende
del reperto erano coperte da un testo scritto con l'inchiostro nero. Solo nel
1892 questo testo, di oltre 1200 parole, venne studiato dall'egittologo Brugsch
e identificato come etrusco. Dal 1947 mummia e bende vennero trasferite al Museo
di Zagabria. L'ultimo restauro è stato curato da un'équipe italiana nel
1997.
Si tratta di un calendario rituale che specifica le cerimonie da
compiere nei giorni prestabiliti in onore di varie divinità. Le prescrizioni di
carattere religioso sono tipiche dell'area tra Perugia, Cortona e Lago
Trasimeno. La scrittura, molto precisa e accurata, è quella in uso nell'Etruria
settentrionale tra il III e il lI secolo a. C. Un esempio dalla III colonna,
riga 3: " celi huthis zathrumis flerxva Nethunsl sucri" "Settembre sei venti
offerte a Nettuno si dedichino " ossia " il 26 settembre si dedichino venti
offerte a Nettuno" Si pensa che questo libro di lino, conosciuto come liber
linteus di Zagabria, appartenesse a un aruspice, e che sia stato poi ridotto in
strisce per fasciare la mummia.
La Tabula Cortonensis
Una delle
più lunghe iscrizioni in lingua etrusca, la "Tabula cortonensis" (la tavola di
Cortona) del III-II secolo a. C., la cui clamorosa scoperta è stata annunciata
all'inizio della scorsa estate a Firenze, ha cominciato a svelare i primi
"segreti". Nel testo non si parla di defunti o riti funerari, come succede in
genere con i reperti degli Etruschi riemersi dal sottosuolo, ma di un concreto e
articolato passaggio di proprietà fra etruschi ben in vita e preoccupati di
tutelare le proprie ricchezze. Solo quattro mesi fa Francesco Nicosia, ispettore
centrale del ministero dei Beni culturali, ha reso nota l'esistenza di una
tavola bronzea, misteriosamente ricomparsa nel 1992, con una fitta iscrizione di
32 righe, spezzata in sette frammenti, la cui decifrazione sta fornendo
importantissimi elementi per la conoscenza della ancora in gran parte misteriosa
lingua degli Etruschi.
Ora un articolo della rivista "Archeologia viva" rende
noti i significativi passi in avanti nella decrittazione delle parole della
"Tabula Cortonensis", grazie agli studi del professor Luciano Agostiniani,
docente di glottologia all'università di Perugia. L'ipotesi al momento più
fondata è che la "Tavola di Cortona" racconti di una transizione tra la famiglia
Cusu, di cui farebbe parte il personaggio Petru Scevas, da una parte, e un
gruppo di quindici persone, dall'altra. È stato decodificata anche una serie di
numeri: il 10 (sar), il 4 (sa) e 2 (zal), che potrebbero indicare quantità di
cose o estensioni di terreno. È possibile, secondo Agostiniani, che si tratti
dell'atto di vendita di un terreno da parte dei latifondisti Petru Scevas e Cusu
a piccoli proprietari compratori.
Molti sono gli elementi eclatanti in
questa straordinaria iscrizione. Anzitutto la formula di datazione con il nome
degli eponimi, attestata qui per la prima volta per l'Etruria settentrionale. Il
primo dei personaggi che compare nell'ultimo elenco è accompagnato dall'epiteto
della carica rivestita, assai importante e attestata sempre per la prima volta
nell'Etruria settentrionale: si tratta dello "Zilath Mel Rasnal", il magistrato
supremo dello Stato, che intervenne nella stesura dell'atto di compravendita. Il
professor Agostiniani ha ipotizzato, inoltre, in base a numerosi riscontri,
l'esistenza sulla "Tavola di Cortona" di tre elenchi di nomi: il primo
rappresenta i venditori, il secondo i compratori e il terzo i garanti della
regolarità del contratto.
I garanti del contratto erano il magistrato supremo
e i figli e i nipoti delle due parti. Ciò significa che nel diritto orale
etrusco, chi garantiva la regolarità del contratto e i pagamenti non lo faceva
solo per sé, ma anche per i suoi discendenti. Insomma, in caso di disgrazia o di
insolvenza, il figlio o il nipote doveva garantire l'esecuzione del
contratto.
La Tegola Capuana
Il testo della famosa "Tegola di
Capua" (conservata al Museo di Berlino) rappresenta la più estesa di tutte le
epigrafi etrusche mai ritrovate, se si eccettuano le bende della "mummia di
Zagabria", che costituiscono un vero e proprio libro. Si tratta di una lastra di
terracotta (di centimetri 60 x 50), scoperta nel 1898 nella necropoli di Santa
Maria Capua Vetere e recante una lunga iscrizione graffita, di cui restano
leggibili circa treo cento parole.
Suddiviso in dieci sezioni da una linea
orizzontale, risulta attualmente costituito da 62 righe, alcune in parte
perdute, e da circa 390 parole, non tutte conservate per intero. È suddiviso in
dieci sezioni da una linea orizzontale.
La scrittura è quella in uso in
Campania intorno alla metà del V secolo a.C.
Si tratta, come nel caso della
Mummia di Zagabria, di un "calendario rituale" dove vengono prescritte cerimonie
da compiere in certe date e in certi luoghi a favore di alcune divinità. Nel
1985 ne è stata presentata una bella edizione nel testo di Francesco Roncalli,
Scrivere etrusco, che contiene anche il "libro di Zagabria" e il "cippo di
Perugia".
Sui problemi dell'interpretazione del contenuto il riferimento più
recente e importante è il libro Tabula Capuana (1995), uno degli ultimi lavori
lasciati dall'archeologo Mauro Cristofani. La redazione del documento si può
datare al 470 a.C., sebbene esso si debba ritenere la copia (o comunque la
trascrizione) di un testo certamente molto più antico. In effetti sulla tegola è
graffito un calendario festivo risalente all’età arcaica: un calendario di
prescrizioni cultuali relativo a celebrazioni pubbliche e diretto, secondo il
Cristofani, alla stessa comunità capuana. Il calendario è diviso in dieci
sezioni, corrispondenti ai dieci mesi del calendario antichissimo e comincia da
marzo (in etrusco, probabilmente, Velxitna). Anche il calendario romano (da cui
deriva il moderno) ebbe, in origine, dieci mesi e certamente cominciava da
marzo; ciò è provato al di là di ogni dubbio dai nomi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre, che oggi si trovano al nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo posto.
Le fonti antiche dicono che gennaio e febbraio furono
aggiunti dal re Numa; nel De die natali di Censorino (20, 30) si legge: «I quali
ritenevano che i mesi siano stati dieci, come un tempo succedeva presso gli
Albani, da cui ebbero origine i Romani. Quei dieci mesi (degli Albani) avevano
in tutto 304 giorni, così distribuiti: marzo 31, aprile 30, maggio 31, giugno
30, quintìle 31, sestìle e settembre 30, ottobre 31, novembre e dicembre 30».
Ecco dunque alcuni estratti del calendario festivo di Capua.
I nomi
dei mesi etruschi sono noti sostanzialmente attraverso alcune glosse, la "tegola
di Capua" e il "libro di Zagabria" (l'asterisco indica le forme ricostruite, in
quanto conosciute soltanto da glosse e non ancora attestate nei documenti
etruschi originali): marzo = *velxitna; aprile = apiras( a); maggio = anpili(a)
o ampner; giugno = acalva o acal(a); luglio = *turane o par-{}um; agosto =
*hermi; settembre = celi; ottobre = *xesfer.
La Stele di Lemno
Come
già detto, alcuni autori antichi condivisero l’idea di un’origine orientale
degli Etruschi. Ellanico, un altro storico, vissuto nel V secolo a.C., in un
brano delle sue storie, sostiene che Ceare (attuale Cerveteri) in origine si
chiamava Agylla e fu fondata dai Pelasgi, provenienti dalla Tessalia; quando poi
i Lidi, al seguito di Tirreno, assalirono Agylla, uno degli assedianti si
avvicinò alle mura e domandò il nome della città; dalle mura, uno dei Tessali,
invece di rispondere, lo salutò con la parola "chaere". Così i Tirreni, appena
presa la città, le cambiarono nome in Caere. In seguito, gli studiosi
sostenitori dell’origine orientale, affermarono che per la trasformazione dei
villaggi villanoviani in città fortificate, avvenuta all’epoca dell’inizio della
civiltà etrusca, sono state necessarie tecniche e abilità amministrative ben
maggiori di quelle dimostrate dai villanoviani stessi; ne consegue che tali
competenze furono necessariamente arrivate dall’esterno. Altri riscontri
archeologici a favore di questa ipotesi sono le somiglianze trovate tra alcune
tombe etrusche e alcune tombe dell’Asia minore, nonché alcuni aspetti della
civiltà etrusca che sembrano più orientali che italici: il piacere del lusso,
l’amore per le feste e per le danze, alcune pratiche come l’epatoscopia.
Più che a un’invasione in massa, avvenuta in un unico momento, si
può anche pensare al graduale arrivo dall’esterno di gruppi della stessa
popolazione, che a poco a poco si integrò con la base villanoviana portando i
suoi usi e la sua cultura, in seguito adottati totalmente. Come riscontro
archeologico a quest’ipotesi, nell’isola di Lemno, nei pressi della città di
Kaminia, si può citare il ritrovamento di una stele funeraria recante
un’incisione in una lingua non greca, che è stata interpretata solo grazie alla
sua somiglianza con l’etrusco, segno di un collegamento con l’idioma in uso a
Lemno nel VI sec. a.C., che pur non essendo la stessa lingua, probabilmente ha
delle radici comuni.
|
|
|
|
|
|
 | |