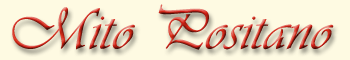6.0 Il potere capitalistico che tuttora domina sull’Italia appartiene a
quattro
regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana (qui chiamate Toscopadana
solo per amore di sintesi, ma impropriamente dal punto di vista politico, in
quanto l’Emilia e il Veneto partecipano al saccheggio del Meridione solo a
partire dal governo fascista). La consorteria toscopadana formò il suo
capitale,
cioè il potere di comandare lavoro, nei primi anni - se non del tutto nei
primi
mesi - della fondazione dello Stato unitario. Ma credo che la frase vada
capovolta. Fu essa che fece lo Stato unitario. Una volta fattolo, usò la
sovranità
statuale per moltiplicare fittiziamente il suo capitale. L’appropriazione fu
regolarmente dissimulata nei meccanismi di mercato, sapientemente orientati
a suo favore mediante leggi falsamente generali e atti governativi
grandemente equivoci.
I fenomeni a cui va prestata la massima attenzione sono: la moneta, le
ferrovie, gli armamenti, il debito pubblico. Naturalmente non si ebbe uno
svolgimento dei fenomeni in contesti separati, come dire, per capitoli. La
ricostruzione monografica, o comunque tematica, che ne fa l’accademia – per
esempio quella di Di Nardi a proposito della Banca Nazionale - è quanto di
più
fuorviante si possa immaginare; un viottolo chiuso fra due muri molto alti.
Seguendo siffatti tracciati, diventa difficile riavvicinare le opere ai
giorni,
eppure bisogna tentare.
6.1 Fatta l’Italia, il padronato di tutte le regioni si ritrovò a dipendere,
per la
sua esistenza di classe, dal governo sabaudo, dal re e dalle sue truppe in
campo. Nel timore di restare senza un baluardo contro le classi povere, i
padroni si adattarono a subire un monarca costoso e invadente, assieme al
suo
esercito di prussiani da operetta. "Ci sembra significativa la priorità
riconosciuta dal governo piemontese, attorno al quale si organizzò la
borghesia
italiana, alla costituzione di forze armate di sicuro affidamento e di
grandi
ambizioni, necessarie perché il nuovo stato potesse far fronte al duplice
pericolo della pressione dall’esterno e della disgregazione interna" (Rochat
e
Massobrio, pag. 6). Credo che agli illustri autori sia scivolata la mano
allorché
parlano di pericoli esterni. In effetti, né l’Austria, né l’Albania, né il
Turco, né il
Negus si sognarono mai di minacciare una guerra all’Italia. La Francia e
l’Inghilterra imposero le loro condizioni, ma, al tempo, lo facevano un po’
con
tutte le popolazioni arretrate e anche nella stessa Europa, con gli Stati
più
deboli. Fu semmai l’Italia a esibirsi in guerre che servirono soltanto a
consumare uomini e materiali. Più aderente alla vicenda storica è invece il
richiamo al pericolo di una disgregazione interna del nuovo Stato. Il
riferimento
generico riguarda in effetti la Guerra del Brigantaggio; un evento tuttora
non
ben inquadrato in tutte le sue implicazioni, a causa dell’italica ipocrisia,
e che
comunque fa da cartina di tornasole circa il carattere coloniale
dell’esercito
piemontese. Esponenti della borghesia padana, meno interessati al saccheggio
economico del Sud, come Massimo d’Azeglio, avrebbero rinunziato
all’unificazione del Sud purché il nuovo Stato non dovesse continuare a
combattere una guerra ingloriosa e crudele. Fu invece la perfida Destra
cavourrista e sedicente moderata, ben intenzionata al saccheggio, a non
volere
rinunziare alla dominazione sul Sud. Non bisogna dimenticare che per i
fiorentini e i genovesi lo sfruttamento dei surplus meridionali faceva parte
di
una tradizione plurisecolare. Infatti, prima dell’avvento dei Borbone al
trono di
Napoli, pronubi i dominatori francesi e spagnoli, gli usurai di Genova e di
Firenze ebbero mano libera nella spoliazione del Regno.
Le spese per l’esercito e la marina militare – scarsamente produttive in un
paese senza industria siderurgica e meccanica – pesarono in misura
disastrosa
sul buon andamento dell’azienda Italia; oltre che, ovviamente, sulla
condizione
delle popolazioni tributarie. Queste, che già ereditavano le spese sostenute
dagli ex Stati nel corso di un settennio di tensioni guerresche, dovettero
accollarsi anche la nuova, ingiustificata e velleitaria follia. Tra il 1852
e il 1860
il peso dei tributi non era cresciuto soltanto nel Regno di Sardegna, ma
dovunque. Quanto al debito pubblico, esso era aumentato dell’86 per cento.
Tab. 6.1a Entrate, uscite e crescita del debito pubblico nel complesso degli
ex Stati prima della seconda guerra cosiddetta d’indipendenza
Migliaia di lire sabaude
Anno |
Entrate
complessive |
Uscite
complessive |
Debito pubblico degli
ex Stati. Totale
progressivo |
| 1852 |
418.475 |
446.218 |
1.310.360 |
| 1859 |
571.107 |
514.221 |
1.482.760 |
| 1860 |
469.115 |
571.277 |
2.241.870 |
Mia elaborazione su Zobi, cit. pag. 12
Il debito pubblico non è fatto di cambiali a vista. Al contrario. Mentre
l’introito del tesoro è immediato, la restituzione – se mai ci sarà - è
rimandata
di anni e di decenni. Attuale è invece il peso degli interessi, come ben
sanno gli
italiani di sempre, non esclusi quelli odierni. Anche il debito flottante,
che il
tesoro dovrebbe accendere solo per provvedere alle temporanee esigenze di
contante, ma che in Italia è sempre stato un trucco governativo per
nascondere i disavanzi di bilancio, è di regola rinnovato, spinto in avanti,
più
spesso consolidato, che pagato. Comunque, il nuovo Stato non aveva una
scadenza immediata di tre miliardi e centocinquanta milioni per debiti
pregressi, ma una di 124 milioni l’anno, divenuti 160 dopo la guerra, a
titolo di
interessi a favore dei portatori delle cartelle, con un’incidenza che stava
intorno
a un quinto delle entrate.
Tab. 6.1b Annualità del debito pubblico degli ex Stati,
come calcolato retrospettivamente dopo la presa di
Roma (1871)* . Lire |
|
| Napoli |
26.003.633 |
| Sicilia |
6.800.000 |
| Lombardia |
5.534.193 |
| Veneto |
3.890.169 |
| Modena |
745.727 |
| Parma |
424.186 |
| Toscana |
4.020.000 |
| Stato Pontificio |
22.459.518 |
| Stato sabaudo |
54.921.696 |
Retrospettivamente a prima del 1861. Rendita da
pagare annualmente dal nuovo Stato.Totale generale
per l’Italia |
124.799.125 |
Si trattava di una componente non tenue della spesa pubblica, tanto più che
il gettito fiscale - benché notevole fosse il suo peso per i contribuenti -
risultò
al di sotto di quello che ottenevano complessivamente gli ex Stati (650/700
milioni circa, contro i 758 milioni di tutti gli ex Stati).
In una relazione al parlamento il deputato Pasini attribuì la fiacchezza
delle
entrate tributarie al fatto che il nuovo Stato aveva interamente devoluto ai
comuni il dazio sui consumi (Plebano, vol. I, pag. 65). Unificati gli erari
degli ex
Stati, fu evidente ai cavourristi che la mucca non dava tutto il latte su
cui
facevano assegnamento. Ciò nonostante allentarono la corda al re, in modo
che potesse spendere e spandere come se avesse l’Impero inglese. Di idee
molto più antiquate degli altri sovrani italiani, i Savoia restavano legati
alla
politica espansionistica tipica della loro casata, cosicché consideravano il
grande regno più o meno come un feudo, nonostante questo non fosse a loro
pervenuto in base a veri meriti militari, ma cavalcando abilmente l’onda
lunga
del principio napoleonico di nazionalità. Sul futuro dell’erario, certamente
anch’essi si erano fatti la medesima illusione della classe politica. E
tuttavia,
venuta a galla la realtà di un paese piegato dal fisco, essi continuarono a
scialacquare, indifferenti al fatto che a pagare fossero i loro sudditi
vecchi e
nuovi.
Se rapportate alla ricchezza nazionale, le spese militari del Regno d’Italia
furono più che folli. Neanche Hitler o Mussolini caricarono sul bilancio
pubblico
percentuali simili, che paiono deliberate da governi in preda a una forma di
follia western per fucili, cannoni e corazzate. Per maggiore sciagura, i
detentori
del potere politico insistettero sull’imbecillità tipicamente e
programmaticamente
cavouriana di acquistare gli armamenti all’estero, anziché creare
un’industria metallurgica nazionale. Dietro il carnevale erariale stavano i
generali, i quali più che una divisa da soldato avrebbero dovuto indossare
le
brache di Attila. Naturalmente i sapientoni delle accademie, per guadagnarsi
la
pagnotta, affermano che, sì, la gente pagò, ma poi si ritrovò libera e
felice
nella sua incomparabile patria, libera e indipendente. Ed è magra
consolazione
il sapere che non esiste una legge che renda obbligatoria, per gli storici,
l’onestà e l’indipendenza di giudizio. Nonché la prudenza.
Tab. 6.1c Entrate erariali ordinarie e spese militariin cifre assolute e in
percentuale dal 1862 al 1870(Lire correnti all’epoca)
| Anni |
Entrate
ordinarie
(riscosse)
Milioni |
Spese
per
l’esercito
e la marina |
% |
|
Anni |
Entrate
ordinarie
(riscosse)
Milioni |
Spese per
l’esercito e la
marina |
% |
| 1862 |
771 |
484 |
63 |
|
1867 |
715 |
400 |
56 |
| 1863 |
511 |
239 |
48 |
|
1868 |
739 |
214 |
29 |
| 1864 |
565 |
465 |
77 |
|
1869 |
902 |
|
26 |
| 1865 |
637 |
385 |
60 |
|
1870 |
801 |
446 |
|
| 1866 |
609 |
715 |
117 |
|
Totali |
6.250 |
3.348 |
54 |
Mia elaborazione da: Izzo cit. Appendici
Le spese per il riarmo impegnarono per oltre trent’anni una parte
consistentissima delle uscite statali, causando l’espansione degli interessi
sul
debito pubblico, la contrazione degli investimenti in industria e in
agricoltura,
cioè nei settori portanti della produzione e del benessere, nonché
l’allargamento dello spazio operativo dei grandi usurai nazionali e
forestieri, e
di rimbalzo l’ulteriore impoverimento dei poveri. Per mostrare quanto
incidesse
percentualmente la spesa militare sul totale delle spese per beni e servizi,
nella
tabella che segue la spesa per il debito pubblico (un’uscita per così dire
in
conto capitale) è stata espunta dai totali della spesa annuale.
Inversamente,
alla cifra degli incassi tributari sono stati aggiunti i proventi del
collocamento
del debito pubblico. Dal 1862 al 1868, i ministeri della Guerra e della
Marina
divorarono oltre la metà della spesa pubblica, e furono la fonte prima
dell’indebitamento dello Stato e del calvario degli italiani del tempo. Su
un
reddito pro-capite calcolato in 288 lire (circa dieci quintali di grano,
tutto qui!),
una considerevole quota venne saccheggiata dal mostro, per giunta
inefficiente
e causa per l’Italia d’indicibili figuracce agli occhi del mondo intero
(Lissa,
Custoza, l’ammiraglio Persano, i generali Cialdini e La Marmora: le mani più
sporche di sangue italiano da duemila anni in qua – dal tempo del genocidio
dei Sanniti sotto le mura di Roma - e la faccia più tosta di tutte le glorie
risorgimentali).
Tab. 6.1d Ripartizione percentuale della spessa pubblica al netto degli
interessi sul debito pubblico dal 1862 al 1868
| Anno |
Giustizia |
Esteri |
Pubblica istruzione |
Interni |
Lavori
pubblici |
Guerra e
Marina |
Agricolt-
Industr-
Comm. |
|
| 1862 |
4,9 |
0,5 |
2,1 |
10,1 |
17,1 |
62,0 |
3,3 |
100 |
| 1863 |
6,0 |
0,6 |
2,6 |
13,9 |
19,0 |
56,7 |
1,2 |
100 |
| 1864 |
5.9 |
0.6 |
2.5 |
13,5 |
20,0 |
56,0 |
1,5 |
100 |
| 1865 |
6,0 |
0,7 |
2,8 |
11,9 |
17,9 |
49,6 |
1,1 |
100 |
| 1866 |
5,0 |
0,8 |
2,7 |
9,4 |
9,9 |
71,4 |
0,8 |
100 |
| 1867 |
7.1 |
1,1 |
3,4 |
11,6 |
22.2 |
53,2 |
1,4 |
100 |
| 1868 |
8,0 |
1,3 |
4,0 |
12,3 |
19,7 |
53,4 |
1,3 |
100 |
Mia elaborazione su Izzo cit., "Appendici"
Lo Stato italiano aveva un parlamento eletto fra i possidenti e un senato di
nomina regia, i cui membri erano le persone più ricche del paese. Le
eccessive
spese dello Stato percuotevano fortemente anche la rendita padronale. Era
difficile, infatti, che il proprietario potesse compiere una totale o
parziale
traslazione dell’imposta sulla classe contadina, in quanto in agricoltura
vigeva,
potremmo dire, una concorrenza perfetta (tra i produttori della medesima
derrata). Inoltre, anche nelle regioni meno povere, il rapporto tra il
contadino produttore
e il proprietario percettore della rendita (o l’affittuario o il
gabellotto) era influenzato più dalla pressione demografica sulla terra
(dalla
fame delle famiglie coloniche e bracciantili) che dalla pressione fiscale.
Logica
avrebbe voluto che i redditieri, che, come detto, erano la parte
numericamente
predominante del parlamento, si muovessero contro le smodate spese statali.
Storicamente i parlamenti erano nati proprio per questo! Eppure non le
contrastarono più di tanto.
Perché? Prima di tutto perché la frazione meridionale di questi signori
doveva mostrare la sua lealtà alla frazione toscopadana, che faceva da metro
morale e patriottico dell’italianità. Poi perché, sulla frazione
toscopadana, gli
speculatori esercitavano l’egemonia culturale fomentata da Cavour. La gente
che ingrassava sulla spesa pubblica era legittimata dal credo cavourrista
del
protezionismo dall’interno, che covava sotto la cenere di un liberismo di
facciata; in pratica un liberismo non vincolante per i settori che si
volevano
proteggere (Carpi, 256 e sgg.).
Tab. 6.1d Parallelismo tra spese militari
e nuovo debito pubblico
(sommatoria in milioni di lire correnti):
| Anni |
Spese
militari |
Debito pubblico |
| 1861 |
|
500 |
| 1862 |
368 |
|
| 1863 |
675 |
|
| 1864 |
995 |
|
| 1865 |
1.245 |
925 |
| 1866 |
1.624 |
1.525 |
| 1867 |
1.844 |
1.775 |
| 1868 |
2.011 |
2.025 |
Fonte: Izzo, ibidem.
Non essendo sufficienti le entrate, i governi nazionali indebitavano i
contribuenti con chi all’interno e all’estero prestava dei soldi allo Stato.
A
pagare avrebbero provveduto le future generazioni. Questa metodologia non
era stata inventata dal defunto Conte o dai suoi corifei. Si trattava di un
espediente praticato, nei secoli precedenti, sia in Gran Bretagna sia
altrove.
Applicato all’Italia-una esso ha portato un gran bene al Nord e ha rovinato
il
Meridione; cose entrambe che, benché accortamente frollate dall’italica arte
dell’ipocrisia, tutti gli interessati constatano.
6.2 Torniamo al marzo 1861, con Cavour ancora vivo e trionfante, e con
Pepoli disoccupato, non essendo stata ancora decretata la tariffazione, in
moneta sabauda, delle monete degli altri ex Stati. Alla formazione del primo
governo nazionale venne nominato ministro delle finanze il banchiere
livornese
Pietro Bastogi. L’inclusione nel governo di ministri non piemontesi non era
una
novità. Nove anni prima, con l’ascesa di Cavour alla presidenza del
consiglio
dei ministri, lo Stato sabaudo era passato, senza modifiche statutarie e
quasi
inavvertitamente, da governo del re a governo parlamentare. Cavour, leader
indiscusso sia del governo sia del parlamento, aveva aperto la via
dell’onore ai
profughi che, dopo il 1848, andavano rifugiandosi nel Regno sabaudo divenuto
garantista, oltre che fautore dell’Italia unita. E’ stato osservato che
l’ospitalità
fu un costo che il Piemonte decise di pagare alle sue ambizioni
espansionistiche. Ciò non diminuisce l’intelligenza dell’atto politico.
Peraltro,
nelle idee di Cavour, il Piemonte non si preparava a egemonizzare l’Italia,
ma a
essere una parte della Toscopadana unita. L’idea colonialista è successiva,
direi, non specificamente piemontese, ma complessivamente toscopadana: da
attribuire essenzialmente al successivo ascendente genovese e toscano sul
governo dell’economia nazionale. Emerse, comunque, allorché gli eventi
internazionali allargarono l’originario progetto cavouriano fino alla
Sicilia e al
Napoletano. Nell’anno circa in cui il Sud rimase fuori dall’area sabauda,
l’unificazione delle regioni per prime annessesi al Piemonte e alla Liguria,
se
non fu perfettamente paritaria, tese sicuramente a esserlo. Il padronato
piemontese non giocò con due mazzi di carte con la Toscopadana, come poi
farà proprio la Toscapadana unificata con il Sud, ma si comportò con lealtà
verso i padroni lombardi, toscani, emiliani e romagnoli, coinvolgendoli
nella
gestione del potere.
Il primo ministero del Regno d’Italia-una, sovrastato com’era dalla
fortissima
personalità di Cavour e dalla centralità dell’esercito regio, appare una
continuazione dei ministeri piemontesi. E’ tuttavia possibile osservare una
qualche apertura ai liberali degli altri ex Stati. Fra le altre presenze,
ancora di
incerto significato, quella toscana non è di facciata; ha un peso reale.
Prima di
assurgere a ministro Pietro Bastogi non aveva fatto parte del circolo dei
fuorusciti. Patriotticamente non aveva altri e diversi meriti che un
mazzianesimo giovanile. Invece era il padronato toscano a godere di una
posizione speciale agli occhi di Cavour - molto più di quello lombardo.
Riconsiderando i particolari passaggi della vicenda è possibile commentare
che
il padronato lombardo, pago d’essersi liberato dell’Austria, non avanzò
pretese.
Sicuri di sé, i lombardi non fecero altro che infilarsi quatti quatti dove i
piemontesi lasciavano uno spazio, tanto che, qualche anno dopo, riuscirono
abilmente a gabbarli sul terreno fiscale. I toscani invece posero delle
condizioni
(Ragionieri e Salvestrini, passim). In appresso le vicende parlamentari
portarono alla luce del sole la contesa latente tra interessi toscani e
interessi
piemontesi, nonché il successivo accomodamento, che in effetti fu una
spartizione dannosa per la nazione. I fatti di Toscana sono stampati in
tutte le
storie unitarie. Oltre a rivendicare il merito d’avere trascinato con sé,
nelle
braccia del Savoia, l’Italia centrale, il padronato toscano era ricco; una
cosa
che era stata di notevole peso nel momento in cui Cavour era stato costretto
a
battere cassa. Difatti i soldi che, nel 1859, aveva inutilmente chiesto a
Napoleone, poi a Bombrini e infine al popolo, onde spesare la guerra
all’Austria, gli erano venuti dalla Toscana, sottoscritti formalmente dai
banchieri livornesi Antonio Adami e Adriano Lemmi. E’ da supporre, però, che
i
due non fossero che dei prestanome. La cifra era alquanto consistente,
superiore alle forze di due banchieri di provincia. Dietro a loro c’erano
sicuramente dei solidi latifondisti toscani e dei banchieri inglesi.
Cavour vivente, il contrasto tra liguri-piemontesi, da una parte, e toscani,
dall’altra, se vi fu, non uscì dalla sacralità dei gabinetti politici. Ma, a
vittoria
ottenuta, avendo portato molto, i toscani pretesero d’entrare nella sala dei
bottoni. Dovendosi avviare l’unificazione dei debiti pubblici degli ex
Stati, a
gestire l’operazione fu chiamato Pietro Bastogi.
Sull’operazione e sulle sue perfide conseguenze non c’è che da rimandare
all’opera di Nitti sul bilancio dello Stato italiano. Relativamente al
discorso della
formazione del capitalismo toscopadano, Bastogi entra in scena non più come
ministro ma come privato banchiere. Infatti, mentre egli si prodigava a
creare
l’inferno per quasi tutti gli italiani e il paradiso per una minoranza –
cioè il Gran
Libro del Debito pubblico - l’anima di Cavour volò a Dio. Gli successe il
latifondista toscano Bettino Ricasoli, il quale lo confermò al ministero
delle
finanze. L’opera di unificare i debiti dei vari ex Stati era stata appena
portata a
compimento, che cadde anche il ministero Ricasoli. Il barone toscano,
aristocratico pare d’antico lignaggio, era poco incline a piegare la schiena
al
cospetto del fulgido re d’Italia, il quale rivolle al governo un suo fedele
consorte, Urbano Rattazzi, che aveva le articolazioni dorsali più
flessibili, nella
circostanza coadiuvato dall’uomo di punta della sinistra incazzata, il
lombardo
Agostino Depretis.
I libri di storia patria strombettano ai quattro venti che il primo merito
dei
governi nazionali fu quello di fare le strade e le ferrovie, specialmente
quelle
meridionali, che l’odioso e odiato Borbone aveva trascurato di fare.
"I brevi anni a ridosso dell’unificazione appaiono già determinanti per gli
sviluppi successivi. Dalla vigilia della proclamazione del regno sino al
1865 la
politica ferroviaria fu guidata (come affermò lo Jacini) da un assoluto
stato di
necessità, da una sorta di istinto di conservazione della nuova realtà
statuale
(ndr), nata più per forza di idealità e nel quadro di delicati equilibri
europei
piuttosto che per spinte tangibili di integrazione provenienti dagli
ambienti
economici. Già i governi provvisori rilasciarono concessioni per la
costruzione e
l’esercizio di migliaia di chilometri di nuove linee, cui fecero seguito le
iniziative
altrettanto frenetiche dei governi e del parlamento italiano, in un clima di
inesperienza finanziaria e di illusioni sulla reale consistenza della
ricchezza
nazionale. Analogamente, la convenzione con la Francia del 1862 per la
realizzazione di un tunnel ferroviario nei pressi del Moncenisio rispondeva
a
considerazioni di natura prevalentemente politica e diplomatica, anche se vi
guardavano con attenzione gli ambienti economici dell’Italia
nordoccidentale.
"Dopo l’abbandono, già nel 1862, di ogni costruzione diretta da parte dello
Stato, il regime sistematicamente adottato fu quello della concessione a
privati
della costruzione e dell’esercizio delle linee, mentre lo Stato garantiva
loro un
rendimento finanziario minimo (non proprio! ndr) per chilometro. A causa
delle
modalità affrettate di valutazione delle linee da parte dello Stato
(tracciati e
redditività presunta) e dei requisiti sommari richiesti alle compagnie
concessionarie, quei primi anni videro all’opera numerose società
improvvisate
(Quanta gentilezza nella scelta degli aggettivi! ndr). Tra di esse si
distinguevano per una solidità maggiore solo quelle promosse da alcune
banche d’affari del Nord controllate da capitalisti stranieri e sorte da
pochi anni
proprio in relazione all’occasione rappresentata dalle concessioni
ferroviarie
italiane" (Fumi, pag. 91).
Ed è a questo punto – e a questo punto soltanto – che compare il grande
capitalismo toscopadano, in precedenza assolutamente invisibile, anche a
guardare con una doppia lente d’ingrandimento; un capitalismo di carta,
fatto
cioè di cambiali tratte da quei patriottici facitori di nazioni, finalmente
risorgimentati, sulla pelle dei sudditi.
Si doveva tenere a tutti costi unita una nazione che s’era pentita del suo
fasullo epos. Lo strumento per tenere unita l’unità erano i bersaglieri, i
cavalleggeri, i carabinieri. Il padronato italiano non fece obiezione circa
il peso
dei loro stipendi e il costo degli equipaggiamenti. Bersaglieri,
cavalleggeri, re e
generali dovevano funzionare da economie esterne, da infrastrutture armate,
idonee ad assicurare alla classe degli speculatori - che operava all’interno
ma
anche alle spalle del padronato fondiario - la buona riuscita delle sue
manovre.
Siccome il vero nemico erano i cosiddetti briganti, il primo, glorioso
intrallazzo
ruotò intorno alle ferrovie meridionali. Con questo nome, però, i padri
della
patria non intendevano riferirsi alle ferrovie che vanno da Napoli in giù,
ma alle
ferrovie che vanno da Napoli in su, per portare speditamente i ducati
borbonici
a Milano, ansiosa anch’essa di risorgimentare.
Di linee ferroviarie (al plurale), al Sud c’era gran bisogno, onde
realizzare un
sistema di comunicazioni interne che superasse la millenaria, reciproca
separatezza delle province. Il Sud, si sa, è una penisola lunga ma non
larga,
che si va assottigliando man mano che s’inoltra nel Mediterraneo. I punti
che
bisognava congiungere immediatamente erano l’area campana con la Puglia,
gran produttrice d’olio e di grano, e più in generale il Jonio e l’Adriatico
con il
Tirreno, essendo il percorso ferroviario, tra Bari e Napoli, un sesto o un
settimo
di quello via mare. Questo, più per gli uomini che per le cose. Per le cose,
il
trasporto marittimo otteneva un forte risparmio rispetto alla ferrovia, il
cui solo
costo d’impianto stava tra le 210 e le 250 mila lire a chilometro (come dire
10.000 quintali di grano, ovvero il nutrimento annuo di 3/4000 persone), più
il
materiale rotabile.
Comunque il problema da risolvere (allora e anche oggi), per movimentare
l’economia, era quello della viabilità interna (a pettine) tra collina e
costa. Ma
questa esigenza valse poco agli occhi patriottici dei padri della patria. Al
contrario la rapidità offerta dalle rotaie al rapido spostamento dei corpi
d’armata dal Nord, dove godevano del loro naturale habitat, all’arido Sud,
si
presentò strategicamente decisiva in un momento in cui le regioni napoletane
e
siciliane erano abitate da genti ancora da sottomettere alla radiosa corona
e
all’intrepido suo generale, Alfonso La Marmora, in buona sostanza allo Stato
nazionale, il vero e unico nemico degli italiani del Sud. E forse anche un
risparmio, nel senso che un’armata che può muoversi facilmente sul
territorio
vale almeno quattro che stanno ferme. Le ferrovie del Lombardo-Veneto erano
in mano ai Rothschil già prima dell’unità. Siccome il Lazio era ancora in
gran
parte sotto al Papa, non potendone attraversare il territorio per penetrare
al
Sud, il governo italiano decise di raggiungere Napoli aggirando lo Stato
Pontificio lungo l’Adriatico, con una tratta Ancona - Foggia, a cui
avrebbero
fatto seguito le tratte Ancona - Ceprano (a sud di Roma) e Napoli-Foggia.
Durante la sua dittatura, Garibaldi aveva stipulato con i banchieri
mazziniani
Adami e Lemmi una concessione riguardante le linee sudiche. E qui gli
storici,
poco pratici di geografia ferroviaria, fanno un ammirevole pasticcio.
Garibaldi
riconcesse ai suoi raccomandati una concessione decisa dai Borbone a favore
di
Talabot, ma non certo la Napoli-Bologna, via Adriatico. E’ infatti
inconcepibile
che il governo napoletano stipulasse una concessione riguardante i territori
del
papato. In effetti la concessione borbonica riguardava la tratta
Napoli-Foggia.
Cavour, che favoriva i mazziniani solo quando gli servivano, aveva revocato
la convenzione e si era rimesso in contatto con il banchiere francese
Paolino
Talabot. Era questi un nome d’assoluta garanzia, in quanto agiva per conto
di
James Rothschild. Morto Cavour ed esautorato Ricasoli, nell’inverno del 1862
il
nuovo presidente del consiglio, Rattazzi, spedì come suo emissario a Parigi,
affinché trattasse l’affare, l’ingegnere milanese e deputato Grattoni
(spesso
nomina sunt res), che in appresso sarà nella direzione tecnica delle Società
per
le Ferrovie Meridionali. Non ho prove da portare, ma la mia convinta
opinione è
che il piano di non lasciare alla casa parigina il boccone in via di cottura
fu
concepito sulle sponde della Senna, dall’illustre ed ecologico duca di
Galliera,
che certamente dovette fare da cicerone al connazionale, lungo i boulevard
della nuova Parigi. Peraltro il successivo botto coinvolse un così alto
numero di
persone che è facile supporre una gestazione durata parecchi mesi. Comunque
sia, nel giugno del 1862 il governo Rattazzi concluse un accordo con
Rothschild, che sottopose al parlamento affinché deliberasse la concessione
ferroviaria. Infatti, pur non essendo scritto nelle costituzioni, gli Stati
liberali e
liberisti, non diversamente dallo Stato feudale, s’intendono sovrani di ogni
via
di comunicazione, sia essa terrestre, sotterranea, sopraelevata, marittima o
aerea, anche se sono a 1000 chilometri dalla tenda del supremo comando.
6.3 Siamo alla metà di luglio dello stesso anno 1862. Mentre Pepoli
armeggia con il valore di cambio delle monete degli ex Stati, viene
insediata
una commissione parlamentare per l’esame della concessione ferroviaria a
Rothschild. La discussione non ha il tempo di cominciare che, al suo
presidente, arriva una lettera dell’ex ministro Pietro Bastogi (da non
dimenticare che è un toscano, amico di Ricasoli e di Peruzzi, gente che
aveva
dato dei soldi a Cavour), nella quale lettera si dice che un gruppo di
capitalistipatrioti
(o se preferite di patrioti capitalisti, in ogni caso ferventi) ha già
formato una società con cento milioni di capitale, per la costruzione delle
ferrovie meridionali.
In verità i milioni versati furono soltanto due e molto probabilmente in
banconote di Bombrini. Ciò nonostante l’aula di Palazzo Madama, dove
sedevano i yesman dell’organo legislativo, in preda a un moto di legittimo e
italico orgoglio, quasi scoppiò a quell’annuncio. Bastogi l’ebbe vinta prima
di
combattere. Il parlamento deliberò la concessione scavalcando persino il
governo, che statutariamente era il solo a poterla proporre. Mentre il
popolo
tricolore ancora applaudiva e piangeva di commozione, si seppe che
l’intrepido
mazziniano aveva corrotto un consistente numero di deputati. Oggi, una cosa
del genere è meno di un peccato veniale. Ciò facilita gli storici
nell’assolvere i
patrii padri, fondatori di una grande nazione (in cui, a tutt’oggi, 4 o 5
milioni di
cosiddetti cittadini sono senza lavoro). Chi si confuse, chi era un
birichino! E
poi, si sa, i soldi piacciono a tutti. Ma quanto costò la birichinata? Chi
pagò?
Chi paga tuttora?
Ora è da chiedersi: poteva, il Regno d’Italia, rinunziare a nuove linee
ferrovie? E’ convinta opinione di chi ha studiato a fondo il tema della
valorizzazione delle forze e dei mezzi della produzione nell’Italia unita –
per
esempio Emilio Sereni - che quei soldi, investiti in altre attività,
avrebbero
fruttificato molto di più. Sicuramente la rete ferroviaria imposta al Sud
nella
prospettiva di un mercato nazionale diretto dai toscopadani non fece che
danni, e non solo al Sud, contribuendo in modo decisivo alla subordinazione
economica e politica, ma allo stesso Nord, impuntatosi su una politica
granaria
nazionale non solo perdente, ma foriera di guerre. Un esempio da manuale del
colonialismo ferroviario nazionale è dato dalla linea che da Brindisi porta
in
Francia, la quale fu realizzata in connessione con l’apertura del Canale di
Suez,
raccordando tronchi già esistenti, affinché la Valigia delle Indie si
avvalesse di
un porto italiano, appunto Brindisi, che al tempo dei Romani era stata la
porta
dell’Oriente. La linea non valse a tal fine, servì invece affinché, con il
danaro
facile offerto dalle banche genovesi, le ditte liguri (spesso gli stessi
banchieri)
s’impossessassero dell’esportazione in Francia dell’olio e del vino
pugliesi.
Invece le ferrovie meridionali servirono poco o niente ai bersaglieri, i
quali, per
raggiungere i briganti napoletani e gli indocili palermitani, continuarono a
impiegare le navi di linea ex borboniche, che l’ammiraglio Persano aveva
eroicamente acquistato a prezzo di svendita (pare solo per due milioni di
lire,
tutto compreso, navi e ufficiali di vascello). Bisognerà attendere il 1893 e
l’insurrezione dei Fasci Siciliani perché i bersaglieri possano viaggiare
comodamente sdraiati nei carri-bestiame fino al luogo della patriottica
repressione.
6.4 A livello notarile, la Società italiana per le strade ferrate
meridionali
"risale ad una convenzione stipulata il 25 agosto 1862 tra il governo
italiano
ed il conte (chissà se anche lui, come Cavour, di antichissima ascendenza?
ndr) Pietro Bastogi ed approvata con regio decreto n. 804 del 28 agosto
1862.
Per essa vennero concessi al Bastogi la costruzione e l’esercizio delle
seguenti
linee ferroviarie, per una lunghezza complessiva di Km. 1365:
1 una linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli,
Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a
Taranto;
2 una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;
3 una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celasco, Sulmona e Popoli;
4 una linea da Voghera a Brescia per Pavia e Cremona.
Il conte Bastogi si impegnò a costituire una società anonima, denominata
Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e dotata di un capitale
di 100
milioni di lire, che avrebbe dovuto assumersi gli obblighi ed i diritti
contemplati
nella convenzione. La società era autorizzata a procurarsi i capitali
occorrenti,
per 1/3 sotto forma di azioni e per 2/3 in obbligazioni (Da Pozzo e Felloni,
pag.
361).
Il racconto dell’italico ri-risorgimento postunitario è esaltante. Secondo i
suoi
bilanci, in trenta anni la Società Italiana per le Strade Ferrate
Meridionali
produsse (comandò) lavoro per un valore di lire italiane 1.563.418.000,
pochissime delle quali andarono a qualche sterratore meridionale;
ricevette dallo Stato contributi a fondo perduto per 700.000.000 di lire
dell’epoca (pari a circa 5.600.000.000.000 di lire dell’anno 2000);
pagò dividendi per 109.031.000 ai risorgimentati toscopadani;
emise obbligazioni per un ammontare di 906.700.000 di lire dell’epoca;
obbligazioni che essendo collocate a un prezzo più basso del valore nominale
portarono all’introito solo di 447.300.000 lire, lasciando subito in mano ai
sottoscrittori 459.400.000 lire dell’epoca, più un interesse del tre per
cento
annuo, che a causa del prezzo di collocamento parecchio inferiore al valore
nominale, fu del sette per cento circa. Insomma una vera pacchia per gli
speculatori francesi che, investendo oro, venivano remunerati in oro, e per
gli
speculatori italiani che, investendo la carta di Bombrini, avevano in dono
un
accresciuto potere di comandare lavoro. Ma la cosa da mettere fermamente in
risalto è che al Sud fu patriotticamente vietato di fare altrettanto.
Le Ferrovie Meridionali (absit iniuria verbis) furono l’atto di nascita del
capitalismo toscopadano, che prima dell’evento era un nulla impastato di
niente, o volendo essere pedestri, era indietro e non avanti all’altro
capitalismo
peninsulare, quello napoletano.
Naturalmente le folli spese e i facili guadagni degli speculatori furono
resi
possibili dal fatto che gli agricoltori pagavano le tasse allo Stato e che
controbilanciavano le spese fatte all’estero esportando una parte
consistente
della loro produzione. Senza la qual cosa non sarebbe stato costruito
neppure
un chilometro di ferrovia, anzi non sarebbe esistito Bastogi, e neppure
Bombrini.
Dal canto suo Pietro Bastogi, cedendo la concessione governativa (anzi
parlamentare) alla cosiddetta Società per le Ferrovie Meridionali, ebbe
subito
17.500.000 di gratifica in azioni della stessa società. Fu anche fatto conte
e
senatore dal re. Nazionalizzate le ferrovie nel 1906, la sua famiglia
continuò ad
avere il protettorato sul Meridione attraverso la Società Meridionale di
Elettricità (SME). Non so dove si trovino i suoi discendenti al momento, ma
dovunque siano si abbiano i sensi della mia personale riconoscenza e la
gratitudine del popolo meridionale per l’opera di civilizzazione condotta
dal loro
antenato e da loro stessi.
6.5 Per scienza e coscienza dei miei lettori fornisco qualche dato circa i
nomi
dei meridionalisti ante litteram che sottoscrissero il famoso capitale
bastogino,
costituito da 200.000 azioni da lire 500; in tutto lire 100.000.000 Credo
che,
trattandosi di patrioti che mettevano a rischio le loro sostanze, ogni
meridionale che si rispetti sentirà il dovere di incorniciare la pagina e di
attaccare il quadro alle pareti del suo salotto.
Azionisti in quanto Patrioti da statua equestre
Patriota conte Pietro Bastogi, azioni 40.000.
Patrioti di secondo rango
Torino
Azioni: Cassa commercio e industria (Credito Mobiliare) azioni 20.000;
Ignazio Nobile de Weill Weiss, 20.000; Cavaliere Felice Genero, 4.000,
Gustavo
Hagermann, 2.000; Cavaliere Federico Carmi, 2.000; Barone Raimondo
Franchetti, 500; Cassa commercio ed industria (Credito mobiliare), 3.500,
Fratelli Ceriana, 1.000; Vincenzo Denina, 1.000; Cavaliere Camillo Incisa,
500;
F. Berné e Comp., 500.
Genova
Azioni: Cassa generale di Genova, 5.000, Cav. Felice Genero, 500; Fratelli
Leonino di David, 1.000; Barone Giuliano Cataldi, 250; Cavaliere Giuseppe
Pignone, 250; De La Rùe e Comp., 2.000; L. Gastaldi e Comp., 500; Francesco
Oneto, 500; Carlo De Fernex e Comp., 2.000; Maurizio Jung, 2.500; I.
Tedeschi e Comp., 1.000; Solei Hebert, 250; D. Balduino fu Nino, 350;
Cavaliere avvocato Tito Orsini, 250; Fratelli Cataldi, 250; Amato Bompard,
400; P. Pastorino e Comp., 1.000; Firs e Comp., 500.
Milano
Azioni: Zaccaria Pisa, 6.000; G. A., Spagliardi e Comp., 6.000; Pietro
Carones, 1.500; Pio Cozzi e Comp., 1.000, Fratelli Brambilla, 500; Fratelli
Valtolina di G., 200; Giuseppe Finzi di A., 500; Marchese Gaetano Gropallo,
500; Weiss-Norsa e Comp., 3.000; S. Norsa, 500; Carli e Comp., 3.000;
Caccianino, 1.000; Giulio Bellinzaghi, 6.000; Noseda e Burocco, 4.000;
Cavaiani Orveto e Comp., 3.500; Brambilla e Comp., 3.500; G. Maffioretti e
Comp., 3.000; Utrich e Comp., 3.100; W. Warchex Garavaglis e Comp., 3.200;
Livorno
Azioni: Luca Mimbelli, 2.000; Bondi e Soria, 1.000; E.E. Arbib e Comp.,
1.500; S. Salmon,, 1.200; David Valensin, 500; C. Binard, 500; G. M.
Maurogordato, 500; D. Allatini, 400; Gioachino Bastogi, 400; Angelo Uzielli,
300; I. Sonnino, 300; R. di A. Cassuto, 250; P. Racah e Comp., 250; S. Moro,
200; I. S. Friedmann, 200; Bondi e Soria, 3.500.
Firenze
Azioni: Angelo Mortera, 500; G. Sacerdote, 500; Leopoldo Cempini, 1.000;
Elia Modigliani, 500; L. di S. Ambron, 500; A. di V. Modigliani, 600; Angelo
Qrvieto, 1.000; Angelo Qrvieto, 500; G. Haraneder, 500; Z. Della Ripa,
1.000;
Em. Pegna, 200; Alessandro Prato, 1.000; Giacomo Levi, 200; Angelo Levi,
300; Alberto Levi, 200; Jacob Castiglioni, 1.000; B. Philipson, 500; Anselmo
Vitta, 500; Barone Raimondo Franchetti, 1.000;
Bologna: Fratelli Ballerini, 1.000;
Modena: Allegra e David Guastalla, 1.000;
Alessandria, Angelo Frascara, 1.000
Brescia: Fiers e Comp Gaetano Bonoris, di Brescia, 1.000
Mantova: Giac. D’Italia, di Mantova, 3.500;
Bergamo: Ingegnere G. Silvestri, di Bergamo.
Venezia: Jacob Levi e figli, 2.000
Totale azioni sottoscritte 200.000, capitale patriotticamente non
interamente
versato.
(Fonte: Novacco, cit.)
Azioni delle Meridionali patriotticamente collocate fra i sudichi:
L’Aquila 0, Teramo 0, Pescara 0, Chieti 0, Campobasso 0, Caserta 0,
Benevento 0, Napoli 0, Avellino 0, Salerno 0, Foggia 0, Bari 0, Taranto 0,
Brindisi 0, Lecce 0, Potenza 0, Matera 0, Cosenza 0, Catanzaro 0, Reggio 0,
Trapani 0, Palermo 0, Messina 0, Agrigento 0, Caltanissetta 0, Enna 0,
Catania
0, Ragusa 0, Siracusa 0.
Zero più zero dà zero, ma zero meno zero dà che anche i sudichi, pur non
sapendo né leggere né scrivere, e nonostante mancassero di un’idea sia pure
pallida di quel che erano le ferrovie e la modernità, pagarono egualmente la
loro parte. Ma forse di più. Quando si dice patria! Su cantiamo in coro, con
Ciampi e l’eroica nazionale italiana, l’ Inno di Mameli!
Benché la gente avvertita ben sapesse che nell’intrallazzo erano impegnati
uomini del governo e gran signori di ricche province, non fu facile a
Bastogi
mettere insieme i 100 milioni. In tasca alla gente le lire scarseggiavano.
Si
osservino dettagliatamente le sottoscrizioni. Troviamo chi s’impegnò per
250.000 lire, chi per 500.000, chi per 1.000.000; cosa che poi, in termini
di
esborso immediato (e molto spesso anche finale), nelle società di capitali
si
riduce ai tre decimi, cioè a 75.000, a 150.000, a 300.000 mila lire. Solo
due
banche arrivarono a sottoscrivere 20.000 azioni - in lire 10 milioni
ciascuna.
Riportando l’esborso ai decimi obbligatori, i milioni scendono a tre.
Siccome,
poi, le banche toscopadane non raccoglievano depositi a risparmio (godevano
infatti di scarsissima fiducia), i loro mezzi bancari non possono non essere
arrivati da altra fonte che dalle banconote della Nazionale, cioè erano
danaro
inventato. Altra considerazione: Bastogi sottoscrisse per dieci milioni di
lire,
eppure non era la persona più ricca della Toscana. Il massimo sottoscrittore
toscano s’impegnò per un milione di lire. Tutti gli altri sottoscrissero
cifre
inferiori. E facile arguire, quindi, che anche i 3 milioni di Bastogi erano
fumo
cartaceo, un prodotto della rinomata Tipografia Bombrini & C.
Siccome i danari bisognava spenderli all’estero per comprare i materiali,
dietro il fumo delle obbligazioni toscopadane appare l’oro francese.
Logicamente l’estero, una volta fatto il lucro, rivoleva il suo oro. Chi mai
glielo
dava? Non certo Bombrini. A pagare in oro erano i prodotti dell’agricoltura
italiana; erano i titoli di credito tratti su una piazza francese, su
Parigi,
Marsiglia, Lione, che gli esportatori accettavano in pagamento, come è
consuetudine fra commercianti. Bombrini scontava questa valuta di buon
grado. Infatti otteneva valuta – oro, che pagava con carta, in più lucrava
un
interesse che andava dal cinque al dieci per cento. Con le tratte degli
agricoltori, ottenute doppiamente gratis, l’Illustre e i suoi accoliti
tamponavano
le domande di rimborso che venivano dall’estero.
L’iniziativa di Bastogi fu salutata in parlamento da grandi ovazioni
patriottiche. Ma, allora, gli italiani del tempo erano proprio dei fessi, o
cosa?
Essi sapevano perfettamente che Bombrini, Bastogi e l’intero gruppo dei
banchieri nazionali e nazionalisti componevano una combriccola di camorristi
che lucravano delle consistenti tangenti facendo da intermediari fra i
grossi
banchieri francesi e lo Stato italiano. Sapevano anche, e con sufficiente
chiarezza, che l’unità italiana era il governo di questi signori. Però
speravano
che prima o poi i benefici del potere si sarebbero estesi anche alle truppe
della
retroguardia, ancora non ben inserita nel giro. Che poi fosse la povera
gente a
pagare, a loro non importava granché, anzi era proprio quel che volevano. Lo
spirito del capitalismo lascia fuori la porta l’idea del pane altrui.
Oggi gli italiani (o meglio gli itagliani) viviamo in uno Stato ricco e
potente.
Quella fase della storia nazionale fu un passaggio obbligato onde pervenire
alla
presente, felice condizione? Debbo dire francamente che se fossi nato a
Milano
o dintorni, la risposta sarebbe sì. Una classe di onesti uomini di Stato
avrebbe
certamente fatto pagare agli italiani dei costi meno esosi, ma il cammino
del
capitalismo non conosce altro percorso che quello di fabbricare i
fabbricanti con
il sudore delle popolazioni e le lacrime di chi cade per strada. Inoltre, in
un
quadro mondiale in cui sedevano al tavolo da gioco soltanto i paesi
capitalisticamente attrezzati, la Toscopadana non aveva molte opzioni. Fra
le
scelte necessarie ci fu quella di usare il Sud come una colonia interna,
allo
stesso modo della Laconia oppressa da Sparta. La nostrana borghesia piegò la
testa in forza della regola: prima caritas e poi caritatis. Stupidamente
immaginò che il sistema padano non avrebbe toccato le sue rendite; che il
vero
nemico fossero i contadini e non i bersaglieri intervenuti a salvarla.
Nell’affare delle Meridionali, Pietro Bastogi, di suo, non mise una sola
lira. La
mirabolante sottoscrizione di 20.000 azioni, annunziata in parlamento, fu
solo
un bluf bombrinesco, in quanto le 20.000 azioni da lui sottoscritte furono
coperte dal dono di 17.500 azioni che gli altri soci, riconoscenti, gli
fecero. In
sostanza, queste, e le 2500 ancora mancanti, furono messe in conto dei
futuri
(e immancabili) profitti. Cioè pagate con l’argent des autres.
E c’è una terza osservazione. Nel momento in cui lo Stato si faceva
capestrare da Bombrini e soci, e dai banchieri francesi che li avevano
assoldati
(Bouvier, passim), al Banco di Napoli affluivano quei depositi che alle
banche
d’avventura toscopadane facevano totalmente difetto, a fronte dei quali –
come insistentemente accennato - il Banco metteva in circolazione fedi di
credito per un pari importo, avendogli Cavour vietato di effettuare le
operazioni
di sconto. Sul capitolo di questi soldi deve, patriotticamente, dominare una
spessa nebbia. E’ tuttavia un dato verificabile: nonostante la deminutio
capitis i
depositi superavano i cento milioni. D’altra parte, né prima, al tempo
dell’odiato borbone né dopo la revoca del diktat, le fedi di credito furono
mai
soggette alla tarantola del baratto, come i biglietti della Banca Nazionale.
A
Napoli circolava la fiducia, un profumo alquanto raro altrove. Sicuramente
il
padronato meridionale aveva i soldi per pagarsi il collegamento ferroviario
con
la fiera capitale piemontese. Ciò era noto al re Savoia, a Rattazzi,
presidente
del consiglio dei ministri, a Depretis, ministro dei lavori pubblici,
all’ineffabile
risparmiatore di calamai, Quintino Sella, ministro delle finanze, e a
chiunque
nella Toscopadana si interessasse di cose economiche, oltre che, soprattutto
al
prevaricatore Bombrini, che su quei soldi aveva messo gli occhi da tempo.
Per ottenere in modo normale, coretto e al prezzo giusto il capitale
occorrente per costruire le ferrovie da Napoli a Bologna, e da Napoli a
Palermo
e Agrigento, bastava che il Banco di Napoli avesse la facoltà di triplicare
i
depositi, come dire che gli fosse accordato di emettere fedi di credito nel
rapporto di uno di riserva argentea per tre di vaglia circolari, cioè lo
stesso
privilegio di cui godeva la Banca ex sarda. Per giunta, a Napoli i
capitalisti,
tradizionalmente, avevano dimestichezza con le operazioni di borsa. Né
mancavano gli imprenditori facoltosissimi. Per fare le ferrovie al Sud non
era
necessario (né fu conveniente) indebitarsi con i finanzieri francesi, tanto
più
che quel debito – era chiaro a tutti i contemporanei – sarebbe arrivato
presto
alla scadenza. Al primo stormire di crisi le cambiali sarebbero state messe
all’incasso, come avvenne in effetti dopo appena tre anni, tra il 1865 e il
1866.
L’oro c’era. D’altra parte i due miliardi necessari per costruire duemila
chilometri di ferrovie in Sicilia e nel Napoletano, non erano da spendere
tutti in
un giorno, ma in non meno di venti anni. Come abbiamo visto, nelle Due
Sicilie
circolavano ben 700 milioni di moneta argentea e aurea. Sarebbe bastato
consentire al Banco (divenuto) di Napoli di emettere biglietti per ottenere
quanto bastava. Ma Bombrini, da Napoli, voleva oro, e basta.
Neppure accenno all’idea che il Sud avrebbe avuto il diritto di valorizzare
i
surplus derivanti dalle sue esportazioni di olio, vino e agrumi;
esportazioni che
nei decenni successivi pagarono larga parte del debito estero contratto
dalla
Toscopdana.
Viene il vomito a insistere su tali argomenti, tanto sono ovvi. Se si voleva
veramente unificare l’Italia, e non fondare una colonia, come in realtà
avvenne, la prima cosa da fare era spostare subito la capitale a mezza
strada,
tra Ancona e Brindisi, valorizzando - oltre al resto - il versante adriatico
e
jonico, che una lunga dipendenza militare e commerciale dalla Spagna e dalla
Francia aveva sacrificato, e che l’Italia unita continuò a sacrificare fino
alla
correzione mussoliniana. Torino non era quella gran città che le successive
generazioni immaginano. Se proviamo a togliere dal conto la corte, la
pubblica
amministrazione e l’esercito, a livello economico non era più di Bari, e
forse
meno. Ma l’Austria, si dirà? La minaccia austriaca fu soltanto un alibi ben
confezionato dai padani. L’Impero absburgico, piegato economicamente, sul
piano militare era poco più che un cadavere, come si vedrà nel 1866.
E si dirà ancora: quando la capitale fu portata a Roma la condizione del Sud
peggiorò, anziché migliorare. Certo. Ma quando i toscapadani arrivarono a
Roma, il comando del paese era già in mano agli intrallazzisti genovesi e
toscani, che l’avevano largamente devastato e portato a tale stato di
degrado
morale che l’intera Europa ne era inorridita.
Tornando alle Ferrovie Meridionali, è assodato che quei cavernicoli dei
nostrani antenati - non migliori, ma sicuramente non peggiori dei loro
confratelli toscopadani, non vennero interpellati. Non uno di loro fu
chiamato a
tirare fuori una sola lira, cosicché i fratelli toscopadani fecero tutto
loro: ci
fornirono le rotaie e il materiale rotabile - bisogna dire, peraltro, di
qualità
eccellente, essendo tuttora quelli da noi utilizzati. Ovviamente, in una
prima
fase lo fecero sborsando banconote. Queste restavano in circolazione finché
Bombrini riusciva a reggere il baratto, rimettendo in circolazione l’argento
coniato dai maledetti Borbone. Quando non ce la fece più – o fece le viste
di
non farcela più – essendo i banchieri italiani richiesti di pagare in oro i
titoli
ceduti all’estero, pretese il corso forzoso dei suoi (non dello Stato)
biglietti.
Ma già prima, nel 1865, la circolazione cartacea della Banca ex sarda, che
era di 56 milioni nel 1861, era passata a 106 milioni, con un uno scatto
dell’indice da 100 a 189, gli sconti, da 63 milioni, nel 1861, erano passati
a
101 milioni nel 1865, con uno scatto dell’indice da 100 a 160, e le
anticipazioni
erano passate da 21 milioni del 1861 ai 42 milioni del 1865, raddoppiando
l’indice da 100 a 200.
L’esclusione programmata e programmatica (non potrebbe essere
altrimenti!) dei meridionali dall’affare ci fa capire almeno due cose. Una,
Bombrini mai avrebbe accettato che un'altra banca avesse le sue stesse
possibilità di lucro. Due, con l’affare Bastogi, le Ferrovie meridionali
diventarono cosa nostra di un crocchio di parrocchiani cavourristi, la cui
aspettativa non era certamente il collegamento di Napoli al Nord, ma erano i
sussidi governativi. Insomma i protetti dall’interno, fatta l’unità,
rinfocolarono i
loro appetiti, che passarono dai pochi milioni dell’era piemontese ai
miliardi
dell’era italiana.
Insomma, l’affare delle Ferrovie Meridionali portò alla luce il patto
municipalistico e antinazionale tra gli speculatori piemontesi, liguri,
toscani e
lombardi avente per oggetto l’uso dell’Italia, fondata con poca spesa, anzi
interamente a debito, quale terreno di pascolo abusivo. Il patto si
consolidò un
decennio dopo con l’inclusione dell’aristocrazia fondiaria laziale e delle
eminenze romane, e si stabilizzò per il tempo secolare attraverso il
controllo
della Banca d’Italia su ogni aspetto dell’economia produttiva degli
italiani.
L’affare ci aiuta anche a capire quante melensaggini raccontino i libri
scolastici
quando ci ammanniscono la bubbola di una patria comune. A un livello
accademico si è più prudenti. La bubbola si fa raffinata. Le popolazioni (i
proletari) non parteciparono al moto unitario. L’unità, si afferma, fu
voluta
dalla borghesia. Anzi, secondo il credo crociano, il popolo, mancando di
spirito
liberale, neppure entra in conto. A me pare che dal conto della borghesia
sia
scomparsa una componente importante. Al Sud abbiamo infatti la borghesia
idealista (e tuttavia bramosa di terre demaniali), appunto quella di don
Benedetto, degli zii Spaventa, di don Giustino e della sua famiglia di
patrioti.
Subito dopo ci sono i baroni vecchi e nuovi, per i quali "tutto deve
cambiare,
perché niente cambi". Di seguito i redditieri, i paglietta, la borghesia
clientelare, famelica di pubblici stipendi. Mancano gli imprenditori. Nel
gioco
delle tre carte, la donna di danari è scomparsa. C’era, non c’era? "Forse
che sì,
forse che no". Ma se c’era, chi l’ha nascosta? Non c’era sicuramente,
assicurano i vati della patria con gli applausi a Giovanni Verga, al
Gattopardo,
a Luchino Visconti e al frizzante valzer di Giuseppe Verdi. La verità?
Prendete
in mano un’enciclopedia e cercate le voci Messenia, Laconia, Iloti. La
spiegazione è tutta lì. E noi, secondo Carlo Azeglio Ciampi, dovremmo
inneggiare a Garibaldi, ai Savoia, a D’Alema, se non del tutto a Bossi?
6.6 Siamo nel novembre 1860: il Regno d’Italia non è stato ancora
proclamato, Francesco II è ancora a Gaeta, le piazzeforti di Messina e
Civitella
del Tronto ancora resistono, decine di migliaia di umili soldati non cedono
le
armi all’invasore, il Regno delle Due Sicilie esistente ancora per il
diritto
internazionale). A Cavour sembra della massima urgenza imporre al Regno
delle Due Sicilie la tariffa doganale piemontese. Il fine è fin troppo
evidente:
distruggere la mercatura duosiciliana, secondo una precisa richiesta
avanzata
dagli esportatori livornesi di stracci e secondo i più vasti auspici dei
mercanti
genovesi. Con tale defecazione politica, e con la successiva svendita dei
demani pubblici e dei beni ecclesiastici, l’antropologia sociale delle
popolazioni
meridionali venne ribaltata alla radice, senza peraltro dar luogo a una
diffusa
crescita di quel capitalismo terriero di matrice britannica, che era
l’opposto
delle idee di Antonio Genovesi, degli altri illuministi napoletani e dello
stesso
clero meridionale. Le enclosures britanniche, che in qualche modo imitavano
la
villa senatoriale romana a base schiavistica, erano l’opposto dell’ideologia
del
piccolo podere condotto da un uomo libero, non sempre coadiuvato da servi o
da schiavi, che risaliva all’età magnogreca ed era in qualche modo
coesistito
con i latifundia, condati da Plinio, e non solo da lui, come la vera rovina
del
Meridione.
L’agricoltura semischivistica apparteneva all’esperienza familiare e
personale
di Cavour, e aveva il suo redditizio modello nella bassa Valle Padana,
specialmente ad opera dei tanto celebrati padroni e fittavoli lombardi,
qualcuno
dei quali scese fino al Sud in camicia rossa, per "liberarlo dalla
schiavitù". Nelle
campagne merdionali, l’égalitè borghese aboliva la schiavitù feudale e
instaurava il diritto di morire di fame. L’affermazione di questo diritto fu
alla
base del giacobinismo e patriottismo meridionale. Al Sud, la tipologia che
corrispondeva al fondo chiuso (o alla villa romana) era la piantagione a
cultura
specializzata di ulivi, viti e agrumi, condotta con l’impiego di liberi
proletari, o e
non certamente il latifondo, che è meglio considerare l’involuzione del
feudo a
campi aperti alla proprietà aquilina, condotta estensivamente a pascolo
brado e
colture cerealicole; una realtà economica ibrida, che può sopravvivere in
forza
della fatica dei morti di fame.
Sul tema delle terre comuni è stata fatta già qualche annotazione e sarà
doveroso tornare, al fine di studiare le conseguenze che la loro svendita
ebbe
sulla collettività meridionale. Adesso ci soffermeremo a vedere soltanto il
grasso che cavò dall’eversione dei demani la matura borghesia toscopadana.
"Questa gigantesca operazione, che […] raggiunse nel 1868 il punto
culminante, era compiuta circa per metà nel 1870 e continuò con intensità
notevole fino al 1880 […] Nel complesso essa fruttò allo Stato circa un
miliardo
(somma certamente assai inferiore al valore reale dei beni) e riguardò
750.000
ettari di beni dell’asse ecclesiastico, 190.000 ettari di beni ecclesiastici
siciliani
[…] e 30.000 ettari di beni demaniali: in tutto 1.240.000 ettari"
(Candeloro,
vol. V, pag. 384 e 385). Ma non basta. Il padronato meridionale venne
gratificato anche dei 393.000 ettari usurpati dopo l’eversione della
feudalità
(ibidem) decretata nel 1807 dal re francese Giuseppe Bonaparte. Gira e
volta,
nel corso del secolo i possidenti s’impadronirono anche dei 461.000 ettari
quotizzati a favore dei coloni. Insomma: la paga per la devozione sabaudista
consistette in due milioni di ettari di terre pubbliche, o quasi.
Nell’autunno del 1864, incapace di far fronte alle follie del re, dei suoi
generali carnefici e al carnevale instaurato dai neo-banchieri del regime,
cadde
il Ministero Minghetti. Lo sostituì un ministero La Marmora, in cui Quintino
Sella
fece la parte del mattatore. Presentando il suo programma finanziario,
questi
dichiarò papale papale che in cassa non c’era un soldo e propose qualche
sconto a favore dei contribuenti, affinché pagassero di buon grado, con un
anno d’anticipo, le imposte per l’anno 1865. Tuttavia, neanche questi soldi
sarebbero bastati, affermò il grande risparmiatore d’inchiostro. E con un
volo
pindarico propose che i beni appartenenti alla Chiesa e i demani già
appartenuti agli ex Stati, tutti avocati al Regno d’Italia, fossero ceduti
per la
vendita a una società privata, la quale in cambio avrebbe anticipato subito
allo
Stato la cifra di 150 milioni. Per quanto asini o cinici o egoisti potessero
essere,
i deputati capirono che Sella aveva messo le cose in modo da regalare gli
ori di
famiglia agli usurai. Per la prima volta nella storia dell’Italia
cavourrista gli asini
presero a ragliare. Ma gli usurai reagirono. Se il parlamento non avesse
ceduto
entro il 25 di novembre, si sarebbero rimangiata l’offerta (Plebano, vol. I,
pag.
157). Evidentemente la minaccia era la scusa che serviva a Sella per forzare
la
mano ai suoi asinini colleghi e imporre la sua volontà (di risparmiatore di
calamai e di dissipatore di pubblica ricchezza).
L’ideologia di una Toscopadana scolante amor di patria va smontata con le
parole dei suoi stessi corifei. "Ma più grave ancora, per i patti che essa
racchiudeva, era la convenzione per la vendita delle proprietà demaniali,
che
aperse l’adito a quella serie di onerose operazioni finanziarie, attraverso
le
quali tutto il [recente] patrimonio dello Stato è a poco a poco venuto
sfumando, senza che la finanza abbia potuto trarne mezzo per la sua
sistemazione. Si trattava in sostanza di affidare a una Società, con larga
partecipazione di utili e senza alcun rischio, l’incarico di vendere, per
conto
dello Stato, i beni demaniali…" (ibidem). E’ dunque vero che la farina del
diavolo se ne va in crusca. Dalla dilapidazione del patrimonio pubblico
trasse
vantaggio la speculazione cavourrista e non certamente gli italiani del Sud,
che
ne avrebbero avuto il diritto.
Al centro di questa nobile e patriottica vicenda sta Domenico Balduino,
amministratore della Società di Credito Mobiliare con sede a Torino. Abbiamo
detto delle disgrazie di questa Società nelle fase sarda, e anche di come
Cavour l’avesse protetta fino al punto da spedire lo stesso Carlo Bombrini a
dirigerla (par. 4.5). Zio Carletto provvide a ridurre il capitale sociale,
come era
d’altra parte doveroso dopo le scoppole precedenti, e d’accordo con Cavour
la
consegnò nelle abili (e avide) mani del banchiere suo concittadino, Domenico
Balduino. Questi si alleò con i banchieri parigini fratelli Pereire, e
trasformò la
Cassa di Commercio e Industria in Credito Mobiliare (Pautassi, pag. 373).
Poco
prima dell’arrembaggio ai danari dell’erario nacquero dei dissapori tra i
soci
parigini e i locali, cosicché il nostro grande finanziere fu costretto a
contare su
risorse casalinghe, in primo luogo zio Carletto, che la carta la stampava, e
poi
il duca di Galliera che, avendo soldi veri, dovette salvarlo dal fallimento
portandogli 12 milioni in franchi sonanti.
Balduino era il tipo di filibustiere che piaceva a Cavour. Accenna alla sua
personalità Novacco (pag. 61, nota 11): "[…] nel gennaio del 1861 il Cavour
propose la candidatura del Balduino a deputato con queste significative e
gravi
parole, che contengono la giustificazione del metodo introdotto più tardi
dal
Bastogi nella questione delle ferrovie meridionali: ‘Perché mai non
candidiamo
Balduino, che è quasi riuscito a resuscitare il Credito Mobiliare? La sua
presenza alla Camera sarebbe di gran vantaggio per la banca che dirige. La
cosa potrebbe decidere il voto dei suoi azionisti, che a Genova sono
alquanto
numerosi’."
Domenico Balduino emulò sfacciatamente e superò in ingordigia lo stesso
Bastogi. Se, infatti, questi scroccò pubblico denaro, fece almeno la rete
ferroviaria promessa, mentre Balduino rubò solamente. Stranamente fu uno
dei pochi illustri malfattori dell’epoca che il re non fece conte.
La storia della svendita dei beni incorporati dallo Stato nel 1861 è spesso
sorvolata. Per degli storici colendissimi (e degni soprattutto, per la loro
equanimità, di una piramide di monumenti), come Gino Luzzatto, è
praticamente inesistente. Forse perché, più che una vicenda storica, fu un
gioco di prestigio. In sostanza avvenne che, esibito da Sella l’allarmante
discorso di cui sopra, Balduino ebbe le carte in regola per farsi avanti con
l’offerta di 150 milioni. Un’elemosina, ma quanto bastava al governo per
piangere in un fazzoletto!
Sicuramente, né Balduino né la sua banca avevano la cifra. D’altra parte è
certo che non fu anticipata dai Pereire, con i quali, proprio in quel
momento,
Balduino era in lite. Il nome del vero prestatore è rimasto ignoto. Però,
chi
scorre gli Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul corso forzoso
apprende che il Credito Mobiliare aveva un vecchio debito di circa 200
milioni
con la Banca Nazionale (Atti I, pagg. 257 e 258). Nessuno osa scriverlo nero
su
bianco, ma credo non sia da dubitare che Bombrini abbia consegnato a
Balduino - e che questi abbia girato al ministero delle finanze, dove c’era
lo
scrittoio di Sella con sopra il calamaio che si portava da casa - dei
biglietti
ancora freschi di stampa. In cambio dei quali Sella sottoscrisse 15 pagherò
di
14.140.000 lire cadauno, a scadere uno all’anno, per i quindici anni
successivi.
In tutto 212,1 milioni di lire, cosa che, rispetto a 150, fa una differenza
di 65
milioni.
La Società per la vendita dei beni demaniali fu autorizzata ad emettere
420.000 obbligazioni da 505 lire cadauna, pari complessivamente ai 212,1
milioni di lire che lo Stato avrebbe pagato. Probabilmente (nessuno storico
si
sbilancia a fare un commento) i 65 milioni di lire che lo Stato s’impegnava
a
pagare in più dovevano coprire la differenza tra il promesso prezzo di
rimborso
(lire 505) e il prezzo di collocamento dei titoli che la Società metteva in
commercio. La scommessa di Balduino e dei suoi sostenitori stava tutta nella
futura domanda di obbligazioni.
Comunque, come compenso della sua prestazione, la Società ricevette il 5
per cento d’interesse sui 150.000.000 (vai a capire se a scalare, o no!),
più il
3,5 per cento per il servizio dell’emissione. Più ancora il quinto del
maggior
prezzo tra quello minimo fissato per la vendita dei lotti e quello
effettivamente
realizzato. Sull’entità del guadagno di Balduino non ho visto indicazioni,
ma
potrebbero essermi sfuggite. A occhio e croce la cifra di 200 milioni mi
pare
indicativa; una cifra pari rispetto alla emissione di cartamoneta che sarà
consentita al banco di Napoli tre anni dopo.
Qualunque sia stato il guadagno di Balduino, a pagare fu il Sud. Annota
Nitti**(pagg. 330 e 331):
"Assai più che per mezzo miliardo l’Italia meridionale ha contribuito per
[ricomprare ] i suoi beni demaniali, così detti di demanio antico, e […] i
suoi
beni ecclesiastici al bilancio [dello Stato…Ma] quando si vendevano terre
per
diecine di milioni in Puglia erano sempre i cittadini pugliesi che
compravano.
Quindi la ricchezza [il potere di comandare lavoro, ndr] della Puglia
diminuiva
perché il capitale monetario disponibile si trasportava fuori [ndr]. E
mentre non
si operava che un passaggio di beni immobili da un ente collettivo a
privati, la
ricchezza mobiliare scompariva. Lo Stato a sua volta la destinava nelle
regioni
dove maggiori erano le spese, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria".
6.7 La formazione di piccoli surplus nella produzione contadina e la
rinascita
degli scambi di mercato hanno prodotto non solo la borghesia moderna ma
anche morale borghese in cui lo Stato è un generale e imparziale. Una norma
di questa morale dice che, chi opera come organo dello Stato, non è morale
che tragga profitto dalle sostanze pubbliche. Dunque un giudizio
d’immoralità
dovrebbe colpire chi ha diretto lo Stato nazionale italiano. Invece questo
gruppo sociale viene esaltato. Perché? Perché chi sopporta le conseguenze di
quelle immoralità viene inchiodato all’idea di aver contratto un debito
verso i
malfattori, come un galeotto al remo. A dirla in poche frasi, la
storiografia
nazionale è una truffa bella e buona, il capitalismo nazionale è stato
fondato da
una classe di intrallazzisti, le regioni toscopadane sono cresciute
sfruttando le
regioni meridionali, lo Stato italiano è un vero nemico per i meridionali.
Esternato il concetto politico, torniamo agli intrallazzi ricordando che lo
scopo di questo scritto è di dissipare il falso storico secondo cui i
miliardari che
dominano le popolazioni italiane fossero miliardari anche prima dell’unità.
Affidiamo la causa a uno straniero, Jean Bouvier, il quale ha compulsato le
carte conservate nell’archivio del Crédit Lyonnais, una banca sorta, come
egli
precisa, il 1863 nella città con cui la Toscopdana intrattenne le sue più
importanti relazioni commerciali fino al 1890 circa.
L’articolo di Bouvier non è importante solo per le notizie che dà, ma
principalmente per il fatto che le dà.
Nel dicembre si era costituita, intorno a Balduino e al Credito Mobiliare
Italiano una Società per la vendita dei beni del Regno d’Italia, con 50
milioni di
capitale. Questa società era l’espressione di un gruppo anglo-italiano, la
cui
composizione è poco conosciuta. Il gruppo aveva un credito con il Tesoro di
150 milioni di franchi. All’epoca, ministro delle finanze era Sella. A
titolo di
pagamento, il gruppo ottenne il mandato di provvedere alla vendita dei lotti
in
cui erano stati frazionati i grandi demani appartenuti ai principi
spodestati
dall’unificazione e le vaste terre della Chiesa. La società ebbe la facoltà
di
offrire al pubblico delle obbligazioni demaniali, il cui servizio –
interessi e
ammortamento – doveva essere regolarmente assicurato della progressiva
vendita dei beni. Nel 1865 è facile vedere come il Crédit Lyonnais, che
aveva
ricevuto un pacchetto di obbligazioni dal gruppo finanziario emittente, fa a
Lione grossi sforzi per promuovere tra il pubblico le nuove obbligazioni:
prezzo
di collocamento 391 franchi, rimborsabili in 15 anni a 505 franchi. La
stampa
locale era piena di articoli che reclamizzavano il nuovo titolo. Il giornale
conservatore la Salut Public, in un articolo dell’11 novembre, si sforzava
di
persuadere particolarmente i suoi lettori cattolici, ostili .nei confronti
del
governo italiano a causa della questione romana.
Le obbligazioni demaniali furono, in Francia, un titolo molto in voga per
parecchio tempo. La vendita dei lotti andava però male, come informava
l’emissario del Crédit Lyonnais in Italia. Ogni anno il governo viene in
aiuto alla
Società anticipando i fondi che le mancano. Si capisce, allora, come da
parte
dei banchieri, l’affare sia considerato eccellente […]
La guerra del 1866 [aggravò] il deficit permanente del bilancio italiano. Si
pensò di colmarlo con la vendita dei beni del clero. […] Una parte
dell’opinione
pubblica italiana è ostile al progetto del ministro delle finanze Scialoja
che,
all’inizio del 1867, pensa di liquidare un patrimonio ecclesiastico valutato
due
miliardi di franchi. Ma necessita danaro.
Rothschild, in accordo con il Crédit Foncier, propone una semplice
anticipazione, garantita sui beni ecclesiastici. Nel maggio successivo, il
nuovo
ministro delle finanze, Ferrara, avvia un contatto con la casa parigina. I
Rothschild […] sono interessati ai provvedimenti che possano aiutare le
finanze
italiane, in modo che tutto vada a finire sempre più nelle loro mani. In
aprile e
maggio, le conferenze si succedono presso la casa di via Lafitte. La Société
Générale, grande banca d’affari sorta nel 1864, si associa al barone James
[Rothschild, ndr] e al Crédit Foncier di Fremy. […] Alla fine di maggio,
entra in
scena un nuovo gruppo finanziario con il Comptoir d’Escopte di Parigi, il
banchiere Fould, e i banchieri di Francoforte Erlanger e Oppenheim –
quest’ultimo legato a Fould. [Resosi conto d’essere soltanto un pupazzo
nelle
mani degli usurai] nel giugno 1867, il ministro delle finanze Ferrara
denuncia
egli stesso l’accordo stipulato il 4 maggio con un rappresentante di
Langrand-
Dumonceau […e] si dimette.
Si intuisce a questo punto […] che il portafoglio delle finanze non doveva
essere estraneo alle dispute tra banchieri stranieri e italiani.
Nell’autunno del 1867, Rattazzi, che ha assunto l’interim del ministero
delle
finanze, emette sotto l’egida della Banca Nazionale d’Italia una prima serie
di
obbligazioni demaniali (250 milioni di franchi). Una seconda serie verrà
lanciata
nel 1868 da Canbray-Digny, tornato alle finanze […] All’inizio del 1869, il
tesoro italiano si trova di nuovo in difficoltà. In febbraio, il ministero
delle
finanze tratta contemporaneamente con Fould e James Rothschild attraverso la
mediazione di Landau. Il ministro – precisa un inviato del Crédit Lyonnais a
Firenze – si è servito dell’offerta di Fould per creare un concorrente a
Roschild.
Nel marzo del 1869, diverse banche e banchieri [sono in movimento con la
speranza di] partecipare all’affare dei beni ecclesiastici’. A Firenze (al
momento
capitale dello Stato italiano, ndr) si muovono: il Crédit Foncier, Edmond
Joubert (Banca di Parigi), Stern, il Crédit Mobilier, la Banque de Paris, la
Societé Générale, il Crédit Mobilier …Ogni gruppo manda suoi inviati nella
capitale: Fould, per esempio, rappresenta la sua ditta ma anche la Anglo-
Austrian Bank e la Wienerwechselbank. La casa Weill-Schoot & C.,
commercianti di Milano, è, dal canto suo, portavoce di un gruppo di
banchieri
di Francoforte: Renach, Erlanger, Oppenneim.
Anche la Banque de Paris e la Societé Generale hanno una propria
costellazione di amici… ‘Che interessi da soddisfare!’, esclama un
testimone.
Nel turbinio di discussioni e di opposizioni tra coalizioni bancarie, un
raggruppamento agisce rispettivamente a favore dei Fould e uno a favore
degli
Stern. L’affare sembra volgere verso una singolar tenzone […]
Da parte italiana, Cambray-Digny non fa nulla senza il parere di Bombrini,
direttore della Banca Nazionale e perno dell’operazione, né senza l’assenso
di
Balduino, del Credito Mobiliare Italiano. Alla camera ci si preoccupa delle
trattative tra il ministro e le banche.
[…] La lotta è aspra. Abbiamo potuto, ad esempio, analizzare i vani sforzi
del
Crédit Lyonnais per farsi ammettere in un gruppo, su basi di parità.
Bombrini e
Balduino vengono considerati alleati sleali dall’inviato di questa banca a
Firenze; i banchieri di Parigi serrano i ranghi e considerano il Crédit
Lyonnais
una banca di provincia, una specie d’intrusa […] L’inviato della banca a
Firenze
riceve l’ordine ‘di fare la corte’ a Bombrini, di ‘perseverare con calma e
dignità’.
A Lione, il direttore della ditta nota con amarezza: ‘il momento arriverà in
cui i
nostri nemici si accorgeranno della nostra esistenza e terranno conto di
noi,
comprendendo che i nostri capitali e la nostra clientela ci conferiscono una
posizione eccezionale’.
Nel settembre 1869 a Chambray-Digny riesce infine una nuova operazione
finanziaria. Un gruppo comprendente banchieri francofortesi, viennesi,
francesi
e italiani fa un prestito di 60 milioni al Tesoro per un anno all’8,25 di
interesse.
In contropartita il gruppo emette 130 milioni di obbligazioni garantite dai
beni
delle congregazioni religiose, soppresse dalle leggi del 1866/67, beni messi
in
vendita in lotti a partire da ottobre.
6.8 A nessuno capiterà di leggete che don Carlo Rothschild subornò i
ministri napoletani, facendo di Napoli la terra delle sue usure. Invece
capiterà
spesso di leggere espressioni come la seguente: "Il signor Rothschild re del
milione è, finanziariamente parlando, re dell’Italia"(riportate da Zamagni*,
211). Si tratta di lacrime di coccodrillo piante sulle pagine degli atti
parlamentari del 1865 dal senatore del Regno Siotto Pintor. "Su
2.573.000.000
di franchi pagati all’estero [dal] governo italiano a titolo di servizio del
debito e
altre spese, tra il 1861 e il 1882, i Rothschild sono iscritti per
1.971.000.000
franchi" (Bouvier, 226). Il servizio del debito pubblico fu il gran
protagonista
del patrio intrallazzo. E’ stato già annotato che i discepoli di Cavour
portano
all’esasperazione la triste e vergognosa pratica di offrire un forte sconto
ai
banchieri che acquistavano le cartelle del debito pubblico e i titoli del
tesoro
per ricollocarli fra il pubblico dei risparmiatori. Nella fase piemontese il
margine
speculativo si era attestato sulle 28/30 lire (fermo restando il debito
statale di
100). Nella fase del carnevale bancario il clima festivo invogliò agli
sconti, che
arrivarono fino a 48/50 lire, e forse anche sopra le 50 lire. Ai poveri, i
banchieri
non fanno dei normali prestiti, ma danno soldi a usura. E questo fu ciò che
fecero con il Regno sabaudo e poi malauguratamente con il Regno d’Italia. E
non solo i Rothschild, ma tutta la banca europea, dopo che Cavour le ebbe
spalancate le porte. Una banda di teatranti patrioti e veri truffatori,
servizievoli
con la speculazione internazionale, sottomise le popolazioni italiane, e si
arricchì alle spalle della povera gente. Da ciò la Toscapadana trasse un
gran
giovamento, in quanto anche il danaro rubato si trasforma in potere di
comandare lavoro. Il Sud fu mandato in rovina, e mai questa genia gli ha
permesso di riprendersi. Il vero volto di Garibaldi è questo. Questo fu
l’osannato Risorgimento: il trionfo di una consorteria di squallidi
lazzaroni, di
generali da operetta che, non sapendo vincere una battaglia, si rifecero con
gli
inermi cafoni napoletani, un re privo di decoro e povero d’intelligenza, che
roteava la spada solo se si trovava in camera da letto. Per la nazionale
meridionale fu il disastro.
Nel Regno delle Due Sicilie il governo delle finanze, come molte altre cose,
era nelle stesse mani del re. E l’infamato Borbone fu un vero galantuomo, un
saggio e trasparente amministratore delle pubbliche sostanze. A Napoli, i
banchieri stranieri facevano dei normali prestiti, gli stessi che facevano
in
Francia o in Inghilterra. Invece nella carnevalesca patria di Vittorio
Savoia e
dell’ampolloso Conte (con le braghe onte) il governo professava l’ideologia
speculativa, cosicché, per ben quarant’anni, gli usurai perpetrarono un
autentico saccheggio delle ricchezze pubbliche e private. Ovviamente, ciò
non
fu un caso, una disgrazia imprevista dovuta ai corsi e ai ricorsi della
storia, ma
la conseguenza voluta di un progetto criminoso concepito dalla fertile mente
di
un Mazzini con la bombetta del biscazziere e portato brillantemente avanti
dagli accoliti che gli sopravvissero. La posta consisteva nell’usare il
dolore e la
vita della gente come fertilizzante per la crescita capitalistica. Dai
magnifici
lombi degli intrallazzisti e dalle loro progressive sorti è nata la
patriottica e
italianissima borghesia attiva di Genova, Torino, Firenze, nonché il salotto
buono di Milano. Ovviamente il debito capitale e gli interessi di tali
profittevoli
operazioni sono tuttora messi in conto al contribuente italiano, finalmente
unito
e redento.
Riporto alcune tabelle. Mi autodispenso dalle spiegazioni. Si prega, quindi,
di
leggerle con attenzione.
Tab. 6.7a Consistenza dei debiti pubblici negli anni indicati (milioni di
lire
correnti)
Anno
finanziario |
Debiti
perpetui |
Debiti
redimibili |
Buoni
del
tesoro |
Conti
correnti |
Cartamoneta |
Totale |
| 1860 |
2.123 |
296 |
20 |
|
|
2.934 |
| 1861 |
2.762 |
330 |
39 |
|
|
3.131 |
| 1865 |
4.826 |
520 |
186 |
|
|
5.533 |
| 1870 |
6.045 |
1.953 |
265 |
|
550 |
8.815 |
| 1874 |
7.234 |
1.478 |
195 |
|
880 |
9.788 |
| 1885 |
9.380 |
2.104 |
256 |
13 |
340 |
12.094 |
Fonte: Repaci, pag.113
Tab. 6.7b Rendita pubblica italiana pagata all’estero:
| Anno |
Pagamenti
totali |
Pagamenti
all’estero |
% |
| 1861 |
151 |
32 |
21,2 |
| 1862 |
164 |
52 |
31,7 |
| 1863 |
197 |
66 |
33,5 |
| 1864 |
246 |
84 |
34,1 |
| 1865 |
311 |
90 |
28,9 |
| 1866 |
330 |
101 |
30,6 |
|
| Anno |
Pagamenti
totali |
Pagamenti
all’estero |
% |
| 1867 |
394 |
114 |
28,9 |
| 1868 |
393 |
117 |
29,8 |
| 1869 |
387 |
114 |
29,5 |
| 1870 |
274 |
94 |
25,1 |
| 1871 |
353 |
98 |
27,8 |
| 1872 |
340 |
85 |
25,0 |
|
Fonte: Zamagni, pag. 234
Una parte consistente di quanto gli italiani pagavano all’inverecondo nuovo
Regno stringendo la cinghia, se la beccavano i grandi usurai e i piccoli
redditieri
stranieri, principalmente francesi.
Tab. 6.7c Rapporto percentuale tra gli esborsi dei contribuenti e il lucro
dei
prestatori stranieri allo Stato, dal 1862 al 1870 (Lire correnti all’epoca):
| Anni |
Entrate
ordinarie
(riscosse) |
Rendita
pagata all’
estero |
% |
|
Anni |
Entrate
ordinarie
(riscosse) |
Rendita
pagata
all’ estero |
% |
| |
Milioni |
|
|
|
|
Milioni |
|
|
| 1862 |
771 |
32 |
4,1 |
|
1867 |
715 |
101 |
14,1 |
| 1863 |
511 |
52 |
10,1 |
|
1868 |
739 |
114 |
15,5 |
| 1864 |
565 |
66 |
11,7 |
|
1869 |
902 |
117 |
13,0 |
| 1865 |
637 |
84 |
13,2 |
|
1870 |
801 |
114 |
14,2 |
| 1866 |
609 |
90 |
14,8 |
|
|
|
|
|
Mia elaborazione su Izzo e Zamagni citati
6.8 L’affare che va sotto il nome di Regìa Cointeressata dei Tabacchi è
riuscito a scandalizzare anche i patriottici, nostrani storici. Lo Stato
italiano non
può essere definito con una parola diversa da quella usata da Dante per
l’Italia
dei suoi tempi. Le porcate note e meno note, le porcate che passano per
gesti
o eventi gloriosi sono state, in tempi recenti, e sono oggi molte di più che
sei e
sette secoli fa. Nel caso dei tabacchi, il protagonista universalmente
additato –
da alcuni come provvidenziale, da altri come colpevole- è ancora una volta
Balduino. Da un punto di vista dello storico gramscian-unitario, l’affare
funziona come il prisma newtoniano che scompone la luce solare in una scala
di colori: fa chiarezza sul fatto che il padronato degli ex Stati,
patriotticamente
unito intorno al re e al suo esercito contro la povera gente, è invece
profondamente diviso al momento di spartirsi le spoglie. Ora, la
speculazione è
consustanziale al sistema capitalistico, a qualsiasi latitudine e
longitudine.
Rispetto al carattere generale, c’è, però, in Italia la specificità
regionalistica (o
municipalistica, come si diceva cento anni fa), la quale ci appare
fortemente
esaltata nella fase genetica dello Stato unitario, allorché i padronati
delle
quattro regioni vincitrici vennero a contesa, fra loro, per la spartizione
delle
spoglie. Particolarmente vivace fu il contrasto tra vecchi piemontesi
(appellati
con il termine la Permanente) e i toscani (appellati la Consorteria). Sul
tema
degli appetiti toscani esiste una vasta letteratura; sulle malefatte dei
liguri e
dei piemontesi, molto meno. Per quel riguarda il nostro discorso, accanto
agli
scritti già citati di Ragionieri e di Salvestrini, merita attenzione un
articolo di
Coppini (cit.) che trae materia dalla corrispondenza intercorsa fra i gran
profittatori toscani nel corso del primo decennio unitario.
C’è però da dire che un’ingenua scomposizione del padronato toscopadano in
tanti padronati regionali depista l’analisi circa la genesi del dualismo
Sud/Nord,
quanto al potere di comandare lavoro. Più che l’imperversare della
speculazione e dei conflitti interni a quella parte del padronato che si era
appropriata dell’area governativa, l’affare dei tabacchi realizza un colpo
d’occhio d’ineguagliabile efficacia circa le procedure attraverso le quali è
stato
possibile l’arricchimento della classe padronale nelle regioni del futuro
Triangolo industriale. Gente che cinque anni prima non aveva i soldi per
pagarsi un cocchiere, nel volgere di appena mezzo decennio arriva a
controllare una buona parte della rete ferroviaria italiana, a impadronirsi
di
milioni di ettari di terra agricola e a venderli agli stessi proprietari, a
conseguire il diritto di battere moneta, a ottenere, come al tempo dei
signori
feudali, l’appalto delle imposte.
Chi si arricchì, prima non era ricco. Qui si intende capire come fece e se
lo
fece senza tradire il proclamato patriottismo, o all’opposto prendendo per i
fondelli la gente veramente desiderosa di uno Stato capace di farla vivere
meglio. Questo il quiz.
A di là delle ciance municipalistiche, bisogna dire che all’arrendamento del
monopolio dei tabacchi non si sarebbe arrivati se, due anni prima (nel
1866), il
ministro Scialoja non avesse decretato il corso forzoso dei biglietti della
banca
di Bombrini, facendo di lui il vero padrone d’Italia. Dopo sei anni di
conflitti,
prepotenze e ricatti, la Nazionale pervenne a essere quel che Cavour avrebbe
voluto. Infatti può spargere fra i suoi clienti crediti a volontà, può
pagare i
mandati del tesoro in biglietti senza più la remora che tornino il giorno
dopo ai
suoi sportelli, può anticipare agli amici ottanta o novanta lire a fronte di
un
titolo che in borsa costa solo 50 lire. Il giocattolo è un vero prodigio.
L’oro che
la Banca incassa sulle piazze estere, per conto degli esportatori, non le
evapora più fra le dita, ma può trattenerlo sui suoi conti esteri e quindi
prestarlo al tesoro italiano che, ogni anno, chiude la bilancia dei
pagamenti con
centinaia e centinaia di milioni di debiti. Con in mano la carta di Bombrini
gli
italiani pagano le imposte a due potentati, lo Stato e i soci della Banca
Nazionale (nota familiare).
Tuttavia Bombrini, come tenutario della pubblica fede, non può infangare
coram populo la sua candida toga. Deve stare all’erta specialmente nelle
operazioni che taglieggiano lo Stato, di cui, ufficialmente, è fiduciario.
Per
procedere nel malaffare senza sporcare la marsina ha bisogno di un complice
segreto (o quasi). A tale bisogna aveva già provveduto Cavour, il quale
aveva
classificato Domenico Balduino come un uomo capace di fornire le gambe ai
suoi progetti liberal-protezionisti. Come spiega, con una melliflua frase,
Novacco (Rodolico, vol. 18, pag. 54) "le speculazioni in cui Balduino
preferì
impegnare il proprio istituto furono quelle che dovevano essere sostenute
dalla
Banca Nazionale, come massimo istituto di emissione: in pratica le
operazioni
connesse ai lavori pubblici (costruzione ed esercizio di tronchi ferroviari)
e le
anticipazioni al governo delle somme relative all’appalto e alla vendita di
beni
ecclesiastici".
In effetti il Gatto e la Volpe si accordarono con reciproco vantaggio. "Era
un
terreno fecondo […]. Naturalmente non tutte le opinioni concordavano nel
giudizio sul Credito Mobilire. Alcuni osservavano che l’istituto era troppo
marcatamente speculativo e perciò, mentre riusciva bene in operazioni
finanziarie […] riusciva male nelle intraprese industriali". Infatti "grossi
guai
erano venuti al governo per la gestione delle ferrovie liguri assunte dal
Credito
Mobiliare" (ibidem).
Bombrini e Balduino mica erano dei fessi!. Perché faticare quando, con la
speculazione e il ricatto, il piatto era più grande e la portata meglio
condita?
Peraltro la voglia di lucrare spennando i compatrioti non era un’esclusiva
dei
due vampiri. Era anzi molto diffusa in tutta l’area compresa tra le nevi del
Monte Rosa e le sponde dell’Arno, fertili di geni insigni. Le varie
alleanze,
consorterie, massonerie, ‘ndrine di patriottici speculatori erano tutte
impegnate
a farsi reciprocamente le scarpe. Nel passaggio storico in questione, a
vincere
il palio è la Consorteria toscana, a favore della quale va a cadere la
designazione a ministro delle finanze di Luigi Guglielmo Cambray-Digny, già
sindaco di Firenze quando la città era stata elevata a capitale d’Italia. I
fondali
della scena sono dunque montati. Come al solito lo Stato ha bisogno di
soldi.
Questa volta, però, l’ammontare non è di quelli che mozzano il fiato;
intorno ai
duecento milioni, una cifra ormai relativamente facile da trovare. Infatti,
i
ministri delle finanze hanno fatto la mano con l’emissione di cartelle del
tesoro,
le quali sono ben accette perché a breve scadenza, ma sono anche molto
comode per il tesoro che paga quelle in scadenza con i soldi che ricava da
una
nuova emissione. Con questo sistema lo Stato incetta una cifra che è di 39
milioni nel 1861, di 186 milioni nel 1865 e di 265 milioni nel 1870 (Repaci,
113). Duecento milioni, dunque, sarebbero stati una cifra di normale
amministrazione.
Prima dell’affare dei tabacchi, il comune di Firenze fu nelle mani del
nobile
Ubaldino Peruzzi e del cooptato nella nobiltà, Luigi Guglielmo
Cambray-Digny.
E’ possibile constatare che, nel governo della Città, furono "seguiti gli
stessi
metodi e principi che si riscontreranno nella Regìa dei Tabacchi. Gli
aspetti
fondamentali di tale comportamento furono i favori accordati a determinati
gruppi e la lotta condotta contro altri […] L’unione sempre più stretta fra
classe
la dirigente e gli interessi finanziari e imprenditoriali diventa adesso un
aspetto
così rilevante della lotta politica, che ogni avvenimento politico si compie
sotto
la stretta sorveglianza dei grandi banchieri" (Coppini, 192, e sg.). Il
padronato
toscano, che in precedenza aveva investito preferibilmente nella
speculazione
sulle costruzioni ferroviarie, ora "scopre nella banca il trampolino di
lancio
verso un’infinità di altre attività" (ibidem). Il fatto che i nostri storici
non
mettono in chiaro è che per banca adesso non s’intende tanto il banchiere
che
moltiplica due o tre volte il risparmio privato depositato presso di lui,
quanto il
banchiere che sputa carta fiduciaria, moneta inventata, capitale fittizio.
In
effetti, il padronato toscano, che prima, per far sentire il suo peso
nazionale,
armeggia con i banchieri inglesi e ne utilizza il credito in
contrapposizione ai
banchieri francesi che, sentendosi padroni d’Italia, hanno la mano pesante,
create le proprie banche, può sentirsi pienamente realizzato nel suo
patriottico
sogno di fare a meno degli uni e degli altri, in modo da appropriarsi di
tutto il
valore degli intrallazzi.
Il cielo fu buon amico dei baroni toscani. Infatti calò a Firenze-capitale
l’arcangelo Gabriele, nelle umane e intrallazzistiche spoglie di Domenico
Balduino, presidente, padrone e mente fertile del Credito Mobiliare
Italiano. Tra
Balduino – con Bombrini dietro il paravento – e gli intrallazzisti toscani –
con
Bastogi dietro il paravento – nacquero delle lucrose convergenze parallele.
Ma
fu Balduini a usare i consorti, o furono i consorti a usare Balduino? A noi
poco
importa. Quel che conta è il clima di facili arricchimenti che fertilizza il
padronato toscopadano. Il Sud paga e tace. Deve tacere perché i cafoni
combattono a viso aperto l’esercito piemontese e non è ancora certo che i
massacri, gli incendi, gli stupri, il genocidio delle donne, dei bambini e
degli
inermi, basteranno a domarli.
Alla camera dei deputati, il progetto di legge presentato dal consorte
Cambray-Digny fu avversato dalla Permanente e dalla sinistra. "In verità la
sinistra non combatteva il progetto in nome di un principio di politica
economica, dato che la maggior parte dei suoi esponenti erano in ultima
istanza inclini al privatismo e perciò condividevano la motivazione del
ministro.
Ma agiva su tutti il ricordo dello scandalo delle Meridionali. L'eventuale
costituzione di una società finanziaria a cui il governo fosse cointeressato
non
avrebbe stimolato una nuova febbre speculativa? E non c'era il pericolo che
tale febbre investisse anche i deputati, così come era avvenuto all'epoca
del
Bastogi e del Susani?
"Un deputato piemontese, il Chiaves, facendosi portavoce del Lanza, chiese…
una discussione approfondita del progetto. Egli dichiarò la sua ostilità
alla
pratica dei contratti tra lo Stato e i banchieri, e citò in proposito
l'aforisma del
Montesquieu, " les financiers soutiennent l'Etat, comme la corde soutient le
pendu ". Questo in linea di principio: in linea di fatto poi il Chiaves
respingeva "
un disegno di convenzione il cui effetto indubitabile sarebbe stato questo
di
fare entrare nelle casse di una società di speculatori e industriali una
somma
anco maggiore (cosa vera, ndr) di quella a cui ascendevano i nuovi balzelli
"
recentemente votati, e cioè, in particolare, il macinato" (Novacco, in
Rodolico
18, p. 57 e sgg.).
Chiaramente per un motivo meno nobile, all’opposizione si ritrovò anche il
barone James Rothschild, il quale avvertì Cambray-Digny del fatto che le
entrate più certe su cui un governo poteva fare assegnamento venivano
proprio dal monopolio sui tabacchi
L’affare consisté nell’arrendamento del Monopolio dei tabacchi per anni
quindici a favore di una società anonima, con 50 milioni di capitale
(ovviamente solo in parte versato), la quale era padroneggiata da Balduino.
Secondo Candeloro (vol. V, p. 343) lo Stato ricavò, al netto di ogni
angheria
bancaria, 171 milioni di lire. Gli italiani ne pagarono 237. Tra l’avere e
il dare
c’è una differenza di 66 milioni, che rispetto a 171 fa il 38,6 per cento e
non il
sei per cento, come viene conclamato dai patrii storici. Più il lucro sul
monopolio. Il sei per cento, più 90 lire di premio d’emissione, venne
lucrato
invece da chi prestò soldi a Balduino. In sostanza un cappello con la
coccarda
tricolore per nascondere l’intrallazzo governativo, in quanto 171 milioni
oro
furono apportati, per circa un terzo, da un vasto parentado di banchieri
tedeschi, rivali di Rothschild, e , per il resto, ovviamentedon da don
Carletto
Bombrini, che adesso si ritrova lo scrigno ricolmo.
Nicola Zitara
|