 |
|
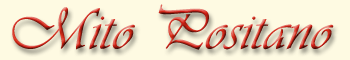 |
|
L'UNITA' D'ITALIA
E I SUOI PROBLEMI
|
|
|
|
IL CAPITALISMO PADANO E
LA QUESTIONE MERIDIONALE
Di Nicola Zitara |
| |
L’origine politica del capitalismo padano e del disastro meridionale:
Capitolo primo. Lo scontro politico per i demani
1.1 Chi, con animo onesto, cerca le origini del disastro meridionale, sbaglia se crede di trovarle nell'assetto, tutt'altro che speciale, del governo borbonico, o nel carattere, anche questo nient'affatto speciale, della società meridionale. Si tratta soltanto di alibi messi in piedi dalla storiografia patria per assolvere la classe dei capitalisti padani per la sua ingordigia e le sue storiche malefatte. La iattura di dovere ottemperare ai precetti di uno Stato edificato a immagine e simiglianza della collettività toscopadana, alla quale ci legano soltanto la lingua, i poeti e i romanzieri, ma non anche i santi e gli eroi; la sventura di essere, da oltre cent'anni, un popolo senza lavoro e senza produzione deriva da un solo fatto, che è questo: la formazione della cosiddetta borghesia attiva del Nord si è realizzata con il viatico di squallide operazioni orchestrate non da un qualche privato con le mani lunghe e scarso senso morale, ma propriamente dai governi nazionali, i quali hanno programmaticamente saccheggiato – e fatto in modo che malfattori indigeni e forestieri saccheggiassero - risorse al Sud per destinarle al Nord. Non solo, essi hanno anche deliberatamente fatto in modo che fossero cancellate le attività esistenti e quelle nascenti, stroncando la naturale spinta del Sud a crescere, affinché le aziende del Nord non avessero concorrenti. L'accumulazione preliminare, necessaria al concepimento del capitalismo padano, non è stata (né avrebbe potuto essere) il prodotto di un movimento di libere forze di mercato, ma è stata realizzata con una serie di violenze. Contemporaneamente i processi di appropriazione coloniale sono stati abilmente mascherati, così che apparissero il frutto del naturale evolversi delle cose e dell'egalitaria applicazione delle leggi.
La trattazione di questi argomenti non presenterebbe difficoltà di natura oggettiva. Si tratterebbe, infatti, di ricordare eventi politici e di presentare situazioni effettive e dati incontrovertibili nella loro giusta luce. Solo che questi sono tenuti nascosti e si fa fatica a trovarli. Dopo l’ultimo, stravagante passaggio della morale padana dall’unità alla disunità, o se più piace al federalismo, l’idea di un Meridione usato dalle regioni toscopadane – capitalisti e proletari uniti in un blocco colonialista – trova finalmente ascolto fra i meridionali, nonostante il secolare e devastante impegno delle scuole e dei mass media volto a far loro introiettare l’idea d’essere loro stessi i responsabili delle proprie disgrazie, oltre che brutti e cretini.
Spesso si sente ripetere che la storia è scritta dal vincitore. Sicuramente l’osservazione coglie con le mani nel sacco quasi tutti gli storici patrii, i quali, a proposito del Sud vecchio e nuovo, mentono programmaticamente. L’esempio più sfacciato, ma anche il più mortificante è quello di Benedetto Croce, il quale in due libri celebri, quali la Storia del Regno di Napoli e la Storia d’Italia, addita ai meridionali – proprio lui che uno più napoletano di lui non c’è mai stato - l’integrazione nell’Italia restante come la via da percorrere per portare il loro paese fuori dalle secche del sottosviluppo; un concetto non solo ridicolo, in quanto il suggerimento andava a un’area sociale che dopo l’unità, per sopravvivere, aveva dovuto spedire all’estero un terzo della sua popolazione, ma anche immorale, in quanto riferito a un popolo la cui storia civile e culturale è descritta, meglio che altrove, proprio nei suoi libri.
Però, le falsità degli accademici non avrebbero fatto un gran male ai meridionali. L’opinione della gente non si forma sulla base delle idee dei filosofi e sulla scia di ciò che viene insegnato negli atenei. Il guaio lo hanno fatto i musicisti, i poeti, i narratori – non sempre in buona fede – e sulla loro scia i maestri di scuola. Delle anime perse, come Edmondo De Amicis, Giosué Carducci, Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Renato Fucini e un’intera schiera di loro epigoni hanno infettato l’aria di una surrettizia africanità meridionale e di una abusiva grandezza degli eventi e degli uomini dell’unità: di Garibaldi, delle camicie rosse, dei Mille, dei Conti di Cavour, degli eroici generali Lamarmora e Cadorna, dei Quintino Sella, dei Marco Minghetti, dei Giovanni Giolitti, dei Filippo Turati, dei Vittorii Emanueli, degli Inni di Mameli. Qualunque carusu o scugnizzo o figghiolu si sia seduto su un rozzo banco di scuola è stato costretto a bere la bugia patriottica, insieme alle lettere dell’alfabeto e alla tabellina del tre.
In questo ethos da provincia emarginata, dire la verità sull’Italia-una era un andare controcorrente. Per fortuna molte mitologie sono crollate dopo l’apparizione sulla scena politica dello stronzobossismo1 Non che i rapporti tra meridionali e settentrionali siano avvelenati. Sia al Sud sia al Nord, la gente è fatta di boni taliani, di italiani brava gente, incline al quieto vivere, a lasciar correre, alla tolleranza e anche al cinismo, ma la deriva stronzobossista disancorerà le due barche e rinverdirà la storica inimicizia che risale alle Guerre Pirriche e alla distruzione della Magna Grecia per mano romana.
1.2 L’argomento che mi accingo a trattare credo sia ostico per il comune lettore. Io invece vorrei farmi capire da tutti. Perciò, in aiuto a chi incontra per la prima volta l’argomento, inserisco qui di seguito qualche annotazione di storia economica. L’informato può tranquillamente saltare le genericità.
Dopo i secoli bui delle scorrerie barbariche e dello scontro tra bizantini e barbari, la colonizzazione araba della Sicilia riportò sui territori regrediti dell’Italia peninsulare gli elementi della tecnologia, della cultura e dello scambio mercantile elaborati nell’età classica. A partire da Palermo e passando per Napoli, Amalfi, Salerno, la penisola cominciò il suo faticoso ma brillante ri-nascimento. Già nel XII secolo Milano, Venezia, Genova, Firenze, Roma erano di nuovo al centro delle nazioni europee ab antiquo civilizzate da Roma, le quali, nonostante avessero cambiato il nome nel corso del Medioevo, conservano elementi della loro antica condizione. Nell’Europa feudale, che andava assumendo un suo proprio volto, di nuovi inseriti ci furono soltanto quei Germani responsabili di aver portato indietro l’Occidente mediterraneo di tremila anni, e il piccolo gruppo nazionale dei Normanni.
Agli albori della rinascita italiana, la Chiesa Romana, al fine di conservare la propria indipendenza, impose la divisione della Penisola in due aree politiche: un’area frantumata in signorie regionali e municipi al nord di Roma; al Sud un regno unitario destinato a far da dado militare, a volte francese a volte spagnolo, da giocare contro l’eventuale emergere di una potenza nazionale italiana. Roma e le province adiacenti, lo Stato di San Pietro, saranno implicitamente difese dalla non convergenza politica tra Sud e Nord.
Intorno al 1000, il contadino occidentale a stento riusce a produrre il minimo necessario per sopravvivere. Il rapporto percentuale tra chi può non lavorare la terra e il numero dei contadini impegnati nella produzione di alimenti sta sotto l’un per cento. Solo in Sicilia e in qualche altro luogo del Sud – e solo fino all’arrivo degli angioini – detto rapporto potrebbe essere stato migliore; cosa attestata dalla presenza di realtà urbane – Palermo in testa - che fanno da parametro civile per l’Europa barbarica. Nei secoli successivi, i paesi occidentali transitarono dalla servitù della gleba, dal tributo signorile allo scambio monetario, alla libertà greco-romana di vendere le eccedenze agricole e il tempo di lavoro, alla proprietà piena ed esclusiva dei beni mobili, compreso il danaro, e dei beni immobili; facoltà tipiche del diritto quiritario, le quali indirettamente attestano che, nel rapporto statistico tra contadini e non contadini, il dividendo si andava abbassando e la produttività del lavoro innalzando. L’esperienza storica insegna che questo risultato va assegnato a pari merito alle migliorie colturali e alla produzione di manufatti; progressi che a noi sembrano appartenere alla preistoria, ma che, poi, tanto lontani non sono.
La maggior produttività del lavoro ci dovrebbe mostrare un significativo cambiamento nell’esistenza materiale e morale del contadino, ma ciò non avvenne nei fatti. Infatti, se il potere del re-Stato va sottomettendo il feudatario-dux nell’esercizio del potere politico e militare, in compenso i signori terrieri resuscitano un’altra e più antica legittimazione, quella del restaurato diritto romano di proprietà e da questa cattedra rincarano l’esazione delle rendite. E ciò mantenne il contadino in una condizione di crudele povertà. Tecnicamente, l’erario statale e i padroni estraevano surplus da astinenza dai produttori agricoli. Detto surplus passava dalle mani del re e dei redditieri a quelle dei mercanti, che lo trasformavano in accumulazione primaria. I loro affari ri-nascimentavano divenendo sempre più moderni e proficui.
1.3 Per spiegarmi compiutamente debbo introdurre due concetti economici: la produzione e la riproduzione. Quest’ultima è l’atto di investire una risorsa sottratta al consumo (ad esempio le sementi) onde avviare un nuovo ciclo produttivo. Produzione e riproduzione sono entrambe atti fondamentali della nostra esistenza, ciò che sta alla base della specialità dell’uomo rispetto agli altri esseri animati. Sembrerà persino banale, ma è il caso di ricordare che il produttore realizza entrambe impiegando beni della natura: i vegetali, gli animali, i minerali, i composti gassosi. Bisogna aggiungere che, nel produrre, l’uomo si serve di un sapere. Il quale un tempo tendeva ad essere ripetitivo, mnemonico, professionale, come filare o tessere, mentre oggi è in continuo e spesso veloce rinnovamento e sempre più massicciamente fissato in strumenti, macchine e impianti capaci, su comando umano, di dare aiuto alla mano e alla mente dell’uomo. Detto complesso di beni ha un costo, che insieme alle materie prime e ai semilavorati forma il capitale dell’impresa. Non è necessario scomodare David Ricardo per ricordare che, in qualunque produzione, l’apporto del capitale accresce la produttività del produttore. Se un prato qualunque produce per cento, un prato a cui viene addotta l’acqua con un sistema di chiuse, produce tre, quattro volte tanto. Un muratore che, per gettare una soletta, impasta cemento con una pala, arriverà alla fine del suo lavoro solo dopo parecchie settimane. Se invece impiega una piccola betoniera, ce la farà in qualche giorno. Se poi è fornito di un camion con betoniera, se la sbrigherà in qualche ora.
Ma perché un muratore investe i suoi risparmi per comprare una betoniera? Evidentemente lo fa solo se gli conviene. Il connesso presupposto è che, nella sua specifica professione, la domanda sia alta e alquanto insoddisfatta. Poniamo, allora, che egli chieda 20 euro per impastare un quintale di cemento, e poniamo altresì che con una pala riesca a impastarne tre quintali al giorno, ottenendo così un fatturato giornaliero di 60 euro. Se l’impastatrice costa 5.000 euro ed ha una vita lavorativa di tre anni, avremo che il capitale fisso si ammortizza al tasso di euro 4,57 al giorno. Aggiungendo i 5 euro necessari per acquistare il carburante o la corrente elettrica, avremo in totale un costo giornaliero di euro 9,57, una cifra che il lavoratore recupera producendo appena cinquanta chili di cemento. In conclusione, al nostro produttore conviene acquistare la macchina. Il solo rischio da sopportare è che la domanda cali. Nella realtà storica, l’attività produttiva che si avvale di un sapere tradotto in macchine ha cambiato radicalmente la vita degli uomini.
Se, nella produzione dell’acciaio, saltiamo dall’incudine del fabbro ad un altoforno a ciclo continuo, la rilevanza del capitale si rappresenterà nella sua immensa portata. Eppure, neanche in questo caso, caratterizzato da un’elevatissima produttività del lavoro, siamo usciti dai cardini che regolano la produzione: il lavoro umano e le sostanze ricavate dalla natura. Il capitale stesso altro non è che lavoro/sapere umano incapsulato in prodotti vegetali, animali e minerali (lavoro morto – cioè già fatturato – diceva Marx). Per questo motivo un sapere umano più avanzato può determinare la sua obsolescenza.
Allorché la fatica del contadino era il solo fattore umano della produzione, la riproduzione del capitale aveva due sole esigenze: (prima) che il contadino mangiasse a sufficienza per continuare a faticare e generare figli; (seconda) che fosse conservata abbastanza semente per rinnovare il ciclo produttivo. Questo tipo di riproduzione tendeva ad essere statica (semplice), cioè difficilmente il ciclo successivo dava un prodotto maggiore del ciclo precedente. Se poi dava, come a volte accadeva, un prodotto minore, era la carestia. Quando il lavoro umano si avvale anche di un sapere incorporato in macchine e in attrezzi – cioè di un capitale - la sua produttività aumenta. Non solo, al tempo stesso l’agricoltura libera uomini che potranno dedicarsi ad altre produzioni. Oggigiorno siamo al punto che anche l’industria libera uomini, che vanno ad accrescere la produzione di servizi. Più numerosi sono gli uomini resi liberi dalla produzione agricola e manifatturiera, più cresce la massa delle conoscenze umane, fra cui quelle utili alla produzione. Laddove il sapere è molto cresciuto, anno dopo anno, il ciclo si riproduce in misura più ampia e i produttori danno prodotti qualitativamente migliori. E’ ciò che noi chiamiamo progresso materiale, o soltanto progresso, o anche ricchezza, altre volte benessere. Se a volte il processo s’inceppa, ciò accade perché i capitalisti hanno distolto risorse che sarebbero dovute andare alla riproduzione.
1.4 Dal punto di vista del rapporto giuridico, il capitalismo cosiddetto moderno non presenta caratteri nuovi rispetto al diritto di proprietà greco-romano. La differenza è essenzialmente economica, in quanto la proprietà antica, che era mediata prevalentemente dalla terra, poteva usufruire ciclicamente del magro gettito della riproduzione semplice, mentre il moderno capitale sapiente gode ciclicamente del surplus derivante dalla riproduzione allargata. Neanche nell’antichità mancavano i profitti derivanti dall’attività bancaria, commerciale, navale e industriale. Ma, per esempio, a Roma, eccezionalmente i capitalisti erano più ricchi dei latifondisti. L’Impero Romano, esteso, potente, fortemente fiscale, poteva allargare le entrate solo espandendo geograficamente le conquiste. Così che, una volta giunto al massimo dell’espansione, i frutti imperiali presero a decrescere significativamente. Invece il moderno capitalismo – nei luoghi in cui si è affermato – realizza cicli in cui il prodotto è ininterrottamente crescente. Tuttavia, a ben duemila e cinquecento anni di distanza, niente è cambiato nell’antropologia della proprietà. Il possidente è sempre al centro della produzione. Oggi come ieri, il ricco comanda al nullatenente di eseguire un lavoro a suo vantaggio, ripagandolo con un salario, o una cosa di simile, il cui livello è condizionato dalla concorrenza che i poveri si fanno sul mercato del lavoro. Cosicché tra i costi che il padrone sopporta e i ricavi che ottiene c’è, di regola, un sovrappiù. Se tale sovrappiù manca, il padrone perde la sua capacità di comandare lavoro, e la proprietà, capitalistica o precapitalistica che sia, passa a qualche altro.
Bombr 1.5 La presente ricerca ha per oggetto la connessione tra l’emissione di moneta cartacea in un paese – l’Italia - in cui la moneta ufficiale era in metalli preziosi, e l’espansione della ricchezza mobiliare soltanto in alcune regioni del paese – la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e la Toscana. Forse oggi esistono gli italiani, ma l’Italia non è ancora fatta2. Figuriamoci centoquaranta anni fa! Gli italiani di quel tempo erano la somma di una decina di popolazioni regionali, simili solo per una cosa: erano popolazioni contadine condizionate dalla loro storia specifica (De Rosa**, pag. 295 e segg.) e dal clima diverso. A tal ultimo riguardo, Giuseppe Cuboni scriveva quanto segue.
“ Non si tiene mai conto abbastanza delle differenze profonde, essenziali, che distinguono una regione dall‘altra; e troppo spesso si legifera, si discorre, si agisce come se l’unità politica dell’Italia significasse anche uniformità del clima e nella natura del suolo. Eppure vi sono al mondo poche regioni così differenti l’une dalle altre quanto il nord dal sud dell’Italia!
L’Italia settentrionale, per il suo inverno rigido e l’estate caldo-piovoso, non è molto dissimile, quanto alle condizione climatiche, dalle regioni dell’Europa media. L’Italia meridionale, per il suo inverno mite, per il suo estate asciutto, tranne le zone montuose, appartiene a quella che i botanici chiamano regione mediterranea, che forma un tutto con l’Africa settentrionale e le coste dell’Asia minore fino alla Palestina. Di qua e di là dell’Appennino vi è un contrasto climaterico tra i più forti che s’incontrino al mondo. Da una parte è l’Europa che finisce, dall’altra è l’Africa che comincia. La vallata del Po, come afferma il Fischer, è comparabile al litorale tedesco del mare del Nord; il freddo nell’inverno vi è intenso fino a 17 gradi sotto lo zero: il terreno quasi sempre ricoperto di neve, rimane gelato dalla seconda metà di novembre fino alla fine di marzo. In Alessandria, nell’inverno 1887-88 il termometro, per trenta giorni consecutivi, non risalì sopra lo zero e per 46 giorni durò il gelo; mentre nella Germania del nord, a Berlino, nello stesso periodo il gelo durò solo 34 giorni. Appena valicato l’Appennino, la scena cambia come per incanto: la neve scompare; la temperatura, da una media di 0 (che è la temperatura media della pianura padana nel gennaio) sale alle temperature di 8.6 nella Liguria, 6.8 a Roma, di 8.3 a Napoli, 10 a Cagliari, 11 a Palermo, mentre a Milano si hanno in media 59 giorni di gelo, a Palermo in una lunga serie di anni, non figura mai una temperatura inferiore allo zero. Nell’estate succede il fenomeno sorprendente e quasi paradossale che la temperatura diminuisce procedendo da settentrione verso il mezzogiorno: Milano, il cui clima che si più prendere come tipo medio per la grande pianura padana, ha una temperatura media nel mese di luglio di 24,7 mentre Napoli nello stesso mese non ha che 24,3. Qualora poi si tenga conto dell’abbassamento notturno della temperatura, si trova che Milano, nelle notti estive, ha una temperatura notevolmente superiore a quella di Roma, di Napoli, e perfino della Sicilia. E’ per questa ragione che nella pianura padana è possibile la coltivazione del riso come nell’India, mentre questa coltura, per deficienza di temperatura, non riesce nella Sicilia.
Ma non è soltanto nei riguardi della temperatura che vi è un contrasto così marcato tra l’Italia continentale e l’Italia peninsulare. Vi è un altro fattore che ha una importanza maggiore della temperatura nei riguardi dell’agricoltura: e questo è la grande diversità nella distribuzione delle pioggie. Nella vallata del Po, piove più o meno in tutte le stagioni, ma si hanno due massimi: uno autunnale e l’altro estivo, di poco inferiore al primo; anzi nel Piemonte ed in tutta la zona alpina meridionale il massimo delle pioggie cade in estate. Non vi è bisogno d’insistere per dimostrare quanto sia importante per l’agricoltura questa coincidenza della pioggia più copiosa colla temperatura più elevata per intensificare l’energia della vegetazione. Nell’Italia meridionale, invece, il massimo della piovosità coincide coll’inverno, quando per la insufficienza della temperatura l’energia di vegetazione è quasi nulla o per lo meno molto ridotta; l’estate invece è privo affatto di pioggia, e quindi la vegetazione tranne i casi fortunati di terreni molto profondi ed umidi è arrestata dalla siccità. Nell’inverno vi sono nell’Alta Italia, in media, 29 giorni sereni, mentre a Palermo ve ne sono soltanto 13. Viceversa a Milano cadono in estate circa 30 centesimi della quantità totale della pioggia annuale; a Palermo invece ne cadono solamente 5 centesimi (59,1 mm.). In altri termini, a Milano, durante l’estate, cade in media una quantità di pioggia venti volte maggiore di quella che cade a Palermo. Naturalmente, le regioni intermedie fra la Lombardia e la Sicilia rappresentano delle zone di transizione dove l’estate è sempre più secco man mano che si procede verso mezzogiorno. Il fortissimo contrasto climaterico fra le regioni al di qua e al di là dell’Appennino esercita una influenza spiccatissima sulla vegetazione, che si manifesta nel modo più evidente anche all’occhio del profano, per poco che prenda a considerare gli elementi costitutivi della flora spontanea. La flora della grande valle padana, eccezion fatta delle piccole oasi speciali sui laghi di Lombardia o sui colli Euganei, appartiene al dominio della flora dell’Europa centrale. Le specie spontanee che fioriscono nel dolce piano che da Vercelli a Marcabò declina, sono pressoché identiche a quelle che fioriscono nella pianura germanica fino ai dintorni di Berlino e di Vienna. Ma appena traversato l’Appennino, la flora muta e come per incanto si entra nel dominio che la geografia botanica ha distinto col nome di dominio mediterraneo, caratterizzato dai vegetali legnosi a foglie sempreverdi. L’olivo, il leccio, il lauro e, nelle parti vicine al mare, l’arancio, il limone, le palme, subentrano alle quercie, agli olmi, alle betulle, ai pioppi propri dell’Europa Centrale. Insieme con queste specie arboree cresce lussureggiante una flora stupenda di arbusti, di piante bulbose, di erbe perennanti come i mirti, i lentischi, le filliree, gli asfodeli, gli acanti e le mille altre forme di quella meravigliosa bellezza ed eleganza che ha ispirato l’arte nell’antichità e nel Rinascimento. Queste specie sono identiche o molto affini a quelle che fioriscono sulla costa settentrionale d’Africa, nella Tunisia e nell’Algeria. Non si può immaginare un contrasto più forte di quello che si presenta all’occhio del viaggiatore quando, nell’inverno in treno diretto, viene trasportato dalla pianura alessandrina, traverso il traforo dei Giovi, sulla riviera ligure. In poco più di mezz’ora egli passa dalle grigie brume del Settentrione nello splendido cielo sereno del Mezzogiorno: da una parte è la flora germanica che finisce, dall’altra è la flora africana che comincia! Questo appellativo diviene sempre più giustificato man mano che si procede verso il mezzogiorno fino alla Calabria e alla Sicilia dove le siepi di fichi d’India, le agavi gigantesche, i boschetti d’agrumi, le palme da dattero, rendono ancora più sensibile all’occhio questo trapasso dalla flora germanica alla flora decisamente africana. Questi due mondi vegetali così diversi, sono la più evidente espressione del profondo cambiamento nel clima dominante al di qua e al di là dell’Appennino nell’Italia continentale e nell’Italia peninsulare” (cit. in Valenti, pag. 2 e sgg.).
1.6 “ Nel 1860 il Sud era agricolo e il Nord industriale”, si legge nei libri di storia che vengono ammanniti ai ragazzi meridionali perché introiettino, sin dall’infanzia, il complesso d’inferiorità del figlio spurio. Il fanciullo sudico (e non solo il fanciullo) immagina la vecchia Milano, ancora austriaca, pullulante di fabbriche; Genova, nel cui porto ogni giorno approdano centinaia di navi; la capitale dei Savoia, Torino, in effetti una città ancora rustica e provinciale, che sforna vagoni e locomotive a migliaia.
In realtà soltanto Milano mostrava una qualche ripresa per merito della produzione serica sviluppatasi dopo la caduta del Regno napoleonico, mentre Genova scontava un non rassegnato declino. Anche peggiore era la condizione di Venezia, un tempo gloriosa. La sua emarginazione era appena nascosta dal fatto che il porto faceva, insieme a quello di Trieste, da base alla flotta austriaca. A un punto di non ritorno era avviata Firenze. Comunque, nessuna delle altre città italiane aveva niente di paragonabile agli splendori culturali e commerciali di una capitale mondiale come Napoli. E poi, per la verità storica, in quei fotogrammi su cui si costruisce l’immaginario industriale di uno scolaro, come navi e treni, il Sud non stava dietro al Nord; al contrario lo sopravanzava, e di parecchio. Un solo esempio: quando il Piemonte prese la decisione di dotarsi di ferrovie, Napoli gli fornì un bel numero di locomotive (Ferrovie dello Stato, cit., pag. 96). Tuttavia i confronti in termini di cavalli-vapore impiantati o di società anonime registrate alla cancelleria di un tribunale danno luogo a una falsa rappresentazione dell’Italia del tempo. Fanno immaginare una modernità che non c’era. Le novità erano ancora tentativi costosi, in vista di un futuro che pareva imposto dall’esterno e al quale l’Italia si accostava senza entusiasmo. Se qualcosa di nuovo, di vivace, c’era in Italia in materia economica e quanto a cultura, questo qualcosa stava sicuramente di casa a Napoli.
In verità, l’Italia del Risorgimento era ancora ferma a un assetto in cui la fatica degli uomini si rivolgeva alla sopravvivenza. Conseguentemente una consistente parte della produzione non era destinata al mercato, ma all’autoconsumo delle famiglie contadine e padronali. Questo è esatto non solo per l’agricoltura, ma anche per la fabbricazione dei panni con cui ricoprirsi e per gli oggetti d’uso corrente. Sicuramente il vecchio era già entrato in crisi, ma il nuovo veniva avanti a pezzi e a bocconi, sollecitato dall’immagine dei manufatti stranieri. Quando la moderna industria, con i suoi impianti a motore e i suoi bassi prezzi è ancora di là da venire, capitale e lavoro si presentano come alternativi. Infatti, se mancano i mezzi per creare un impianto moderno, si ricorre al lavoro del mastro artigiano, il quale produce sicuramente a costi più alti, ma colma il vuoto dell’altro fattore. La borghesia italiana dell’età risorgimentale non ignorava la funzione (per lei) redentrice del capitale, e tuttavia l’accumulazione primaria non si realizza da un giorno all’altro. E poi il livello della domanda era alquanto basso. In quei decenni le merci dell’industria moderna erano cose da ricchi, che, nonostante il feroce protezionismo di quasi tutti gli ex Stati, venivano dall’estero. L’Italia aveva perduto da tempo il posto tenuto nei secoli d’oro. L’idea stessa di modernità giungeva da fuori: dalla Francia e dall’Inghilterra. Ma non bastava vedere e capire: per partire bisognava che ci fossero delle esperienze preliminari, quelle forme di rodaggio tecnologico che in ogni tempo sono molto costose.
L’accumulazione preliminare è detta da Marx con un termine che i traduttori rendono a volte con selvaggia a volte con primitiva. In ogni caso corrisponde al saccheggio brutale e/o all’espropriazione resa legittima da leggi dello Stato. Essa viene estorta dagli aspiranti capitalisti a un altro paese, a un’altra regione, a una diversa classe sociale. Qui impiego una parola diversa non perché nel caso nostro manchi il saccheggio, ma solo per rappresentare il particolare momento storico in cui l’Italia transitava dalla ricchezza fondiaria alla formazione del capitale finanziario (cfr. Sereni**, pag. 101 e segg.), ma non all’industrializzazione
La ricchezza preliminare deve tuttavia esistere. E’ sulla base di tale elemento - la ricchezza preesistente nel Sud e nel Nord, quella reale e quella realizzabile - che va misurato il saccheggio tosco-padano e vanno identificate le cause del disastro meridionale3.
Nel quarantennio che va dal 1860 al 1900, l’arricchimento fa notevoli progressi in Liguria, in Lombardia, nella parte alta della Toscana, nonché nella città di Roma, molto meno in Piemonte (Castronuovo, passim). Al contrario, le regioni facenti parti del Regno delle Due Sicilie, specialmente la città di Napoli, registrano un impoverimento catastrofico. Le regioni adriatiche, Veneto, Emilia, Romagna, Marche, nonché le provincie meridionali della Toscana (tranne Livorno), l’Umbria, il resto del Lazio e la Sardegna, se proprio non retrocedono, sicuramente ristagnano.
L’analisi che intendo condurre non si estende all’intero paese, mira a confrontare soltanto l’area avvantaggiata, la Valle Padana, con quella più fortemente danneggiata, il Meridione. Entrambe erano aree agricole, nelle quali il settore manifatturiero 4 si presenta legato al consumo locale (diversamente da quel che sarà in appresso per la fabbrica). In effetti la manifattura configurava una specie di produttore di servizi fisici resi alle popolazioni, di cui migliorava l’esistenza. La sua funzione nazionale stava nel realizzare un risparmio verso l’estero, rendendo produttive le frange eccedenti del lavoro agricolo. Allo steso tempo, la terra e le miniere erano gli unici produttori di surplus esportabili; una posta a cui era legato il progresso economico, in quanto il paese era totalmente dipendente dall’estero per l’eventuale dotazione di macchine e impianti. Ma, se lo Stato indipendente delle Due Sicilie era libero di usare i propri surplus per acquistare all’estero macchine e impianti industriali, nell’area padana godevano di tale libertà soltanto la Liguria e il Piemonte sabaudi, mentre ne erano esclusi il Veneto, i Ducati e la Lombardia.
Pertanto, solo le Due Sicilie e il Regno sabaudo si muovono verso l’industrializzazione. A partire dal 1851, lo fanno, però, seguendo procedure e perseguendo finalità sociali diverse. I Borbone – ancorché sarebbe stato facile per loro ottenere credito, in virtù della stabilità finanziaria di cui il Regno godeva - non amano indebitarsi. Cavour, invece, vedeva nell’indebitamento degli agricoltori, presenti e futuri, la fonte per la formazione del capitale industriale. Però, maldestramente, intendeva il progresso come la liberazione del profitto da ogni impaccio, cosicché spinse i capitali oziosi verso la speculazione, e non verso l’industria. Al contrario Ferdinando II preferiva vedere le opere concrete (chiavi in mano, si dice oggi) anche a costo di naturalizzare e finanziare degli stranieri. Di conseguenza il primo costruì quanti più chilometri di ferrovia poté. Avendo fatto in proprio l’esperienza del mercante, aveva una gran fiducia nella mano invisibile che, secondo i liberali, reggerebbe il progresso economico. Perciò liberalizzò come pochi altri paesi. Ferdinando II sapeva di essere avanti ai suoi sudditi. Era assolutista e paternalista. Pur adoperandosi a far progredire l’iniziativa privata e il capitale mobiliare, a cui accordò l’esenzione dalle imposte, si rendeva conto che la libertà di mercato sarebbe stata pagata dal popolo basso, la parte politicamente più affidabile e fedele alla dinastia. Saldo in tale visione, rimandò sine die le costruzioni ferroviarie – lui che per primo le aveva avviate in Italia! – pur di tenere leggere le imposte. Peraltro ai traffici bastavano i diecimila bastimenti che navigavano lungo le estesissime coste del paese.
A voler sintetizzare, siamo di fronte a due linee di sviluppo, una di tipo mercantilista e protezionista, e l’altra mista: liberista sul lato del mercato delle derrate agricole, e interventista sul lato finanziario e industriale (protezionismo dall’interno). La linea ferdinandea venne sconfitta militarmente e diplomaticamente dalle potenze marittime europee, quella cavouriana era solamente assurda e si sconfisse da sé. Infatti il protezionismo dall’interno5 (come vedremo meglio in seguito) si risolse in una colossale speculazione e in un’insanabile spaccatura nella nazione unificata. In astratto, a vincere fu la linea di Ferdinando II, alla quale l’Italia-una dovrà piegarsi trenta anni dopo l’unità, quando la speculazione toscopadana avrà esaurito la possibilità di continuare il suo carnevale.
1.7 Diversamente da quel che in appresso il servitorame dei Savoia ha sbandierato ai quattro venti, il Piemonte aveva contribuito poco alla formazione koinè italiana. Anzi sono parecchi a sostenere che di Piemonte ce n’erano due: il primo costituito dalle città e dalle terre che i Savoia avevano rosicchiato alla Lombardia e alla Liguria6, il secondo fatto dai fondivalle alpini e dai borghi frontalieri, attraverso cui una parte del commercio italiano arrivava in Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra. Alla confluenza di questi due Piemonti, stava Torino, antica città romana e poi italiana, ma infrancesata ad opera dei Savoia, che come è noto vi arrivarono d’Oltralpe. La prima, e forse anche l’ultima ribellione all’infrancesamento del Piemonte lombardo fu quella di Vittorio Alfieri, che si fece legare a una sedia per imparare a pensare e a scrivere in italiano.
Siamo al tempo della Rivoluzione Francese, la cui prosecuzione napoleonica lascia il Piemonte sabaudo in una totale sudditanza economica e culturale verso la vicina Francia. Le popolazioni sabaude di qua e di là delle Alpi intrattengono consistenti scambi mercantili e relazioni intense con la Francia. Il fatto nuovo è che nell’età della Restaurazione l’idea risorgimentale, di cui i lombardi di qua e di là del Ticino sono i più interessati, va a impastarsi con le mire espansionistiche dei Savoia. Per il resto il Piemonte è francese. Parla il francese e pensa in francese. La Savoja, che è una regione propriamente francese, rappresenta una parte vitale del regno sabaudo. Inoltre le classi proprietarie e nobiliari, che tengono in riga l’intera società, provengono dal vastissimo rinnovamento sociale verificatosi nel corso della dominazione napoleonica. La nobilitata famiglia dei Cavour rappresenta l'esempio che più può colpirci di detto rivolgimento. I ricchi mandano i figli e le figlie in Francia sin da bambini, per la normale educazione scolastica. I giovani compiono l’istruzione superiore a Parigi e, una volta adulti, continuano a leggono libri e i giornali francesi, interessandosi alle vicende francesi come di cose del loro mondo. Era tanto infrancesita Torino, che il famoso Statuto - prodotto di una cultura giuridica appena abbozzata7 e ciò nonostante coccolato come legge fondamentale dello Stato italiano fino al 2 giugno del 1946 - fu redatto in francese e solo più tardi tradotto in italiano.
Accennando alla popolazione del Piemonte, Bolton King (vol. I, pag. 66) scrive; "Appena italiani, parlavano ancora il francese o il loro dialetto semi-provenzale, non si sentivano eredi del passato dell'Italia, trascuravano la lettura e le arti e vivevano felici un quel pesante torpore che opprimeva gli stranieri di passaggio a Torino. Più industriosa che innovatrice, la loro agricoltura era ancora arretrata, e le industrie cominciavano appena a svilupparsi. Le masse popolari non erano sensibili alle libertà politiche e religiose". Questo giudizio - forse esatto - non deve spingerci, però, a considerare la Liguria, il Piemonte, la stessa Sardegna come appartenenti a una civiltà primordiale. Restando nell'ambito del nostro discorso, basterà ricordare l'esistenza di un tessuto di monti di pietà e di casse di risparmio diffuso su tutto il territorio8.
I conti di Savoja, poi duchi di Savoja, poi re di Sardegna, venuti da questa parte delle Alpi sulla scia della loro intraprendenza di capitani di ventura, non avevano, nel quadro delle famiglie regnanti, il rango dei Borbone o degli Asburgo, né il carisma di Napoleone salente dagli eserciti che schierava sui campi di battaglia. Come gli altri regnanti seduti sui troni italiani avevano obblighi morali e politici verso l'Austria e verso la Francia. La loro sollevazione contro l’Austria, che nella fase quarantottesca non ricevette l’aiuto delle due potenze marittime, come avverrà undici anni dopo, ma solo quello dei patrioti italiani, è connessa in modo diretto e immediato con l’ambizione di papparsi il Lombardo-Veneto.
Asceso Cavour al potere, la monarchia diventa, contemporaneamente, la beneficiaria e uno strumento della sua ben nota impostazione politica: il Regno sabaudo si affaccerà sulle sonde dell’Adriatico, le classi agiate (soltanto quelle padane o tutte le classi agiate italiane, non si capisce bene) riusciranno a emancipatesi dal loro ritardo storico appoggiandosi a uno Stato nazionale. Tuttavia la modernità politica del modello cavouriano non va oltre quel che suggeriva la Francia al tempo dei governi corrotti e corruttori di Luigi d’Orleans e di Napoleone III. In fondo Cavour non è un patriota italiano, né si sbracciò poi tanto per farsi passare per tale. E’ piuttosto uno speculatore cosmopolita di cultura francese e di solide amicizie elvetiche. E’ noto che essendo francese di madrelingua, per mettersi in politica, l’italiano lo dovette imparare. E’ anche noto che era il padrone di una contea che si scrive e si legge in francese. Colto e ricchissimo, conosceva Parigi meglio di Torino, e a Parigi rimase a lungo per giocare (e perdere) in borsa; non ignorava Londra e neanche Edimburgo, capitale della massoneria. Non girò l’Italia come aveva fatto Massimo d’Azeglio. Non fu mai a Palermo o a Napoli, non vide mai Roma, che voleva come capitale d’Italia al solo scopo di non lasciare spazi scoperti attraverso cui potesse infilarsi l’azione di Mazzini e dei repubblicani; non andò mai a Venezia, che pure cercò arditamente di portare nei territori del nuovo regno. Solo una volta fu a Firenze, per sbrigare un affare di governo e forse due volte a Milano, per lo stesso motivo. Da buon speculatore sapeva, però, vita e miracoli delle borse di Londra e Parigi.
1.8 L’Italia del 1860 è un paese agricolo e manifatturiero, nei cui opifici solo nell'ultimo decennio hanno fatto capolino i primi motori. In tutte le sette zone politiche in cui la penisola è divisa, l’economia si sviluppa su due piani: quello naturale - della produzione contadina per il consumo familiare - che è il settore preponderante, e quello mercantile, al quale partecipano di tanto in tanto anche i contadini più poveri, sia per vendere qualche eccedenza sia per acquistare qualcosa, dopo aver venduto un surplus, il più delle volte occasionale. In tale assetto, il proletariato meno sfavorito dovrebbe essere quello della Valle Padana, che è la più grossa produttrice europea di seta greggia. Ma nella Bassa esso subisce una doppia usura, quella del padrone e quella del suo fittavolo. I rapporti di classe sono meno duri in Toscana e nei decenni pre e post risorgimentali è fama che i mezzadri toscani stiano meno peggio degli altri contadini italiani.
I governanti e le menti più vivaci dell’aristocrazia terriera e della borghesia alta e media guardavano con spirito d’emulazione ai progressi che altri paesi d’Europa andavano compiendo. I più accorti si rendevano conto che si trattava non solo di disporre di macchinari moderni, ma anche, e soprattutto, di nuove istituzioni politiche e di una nuova cultura economica che le sapesse usare con vantaggio. Peraltro la realtà su cui applicare l’ingegno e la passione non era incredibilmente difficile, come la storiografia sabauda si è compiaciuta d’insinuare.
Il discorso introduttivo tende a mostrare quale fosse l’Italia economica intorno al 1860. Secondo l’ISTAT* (pag. 36) il reddito nazionale lordo privato, nei primi anni di unità, era così ripartito: agricoltura 56,7 per cento, attività industriali 20,3 per cento, attività terziarie 23,0 per cento. Centocinquant’anni fa, agricoltura, industria e servizi avevano un contenuto infinitamente diverso da quello odierno. Sotto l’aspetto lavorativo e produttivo la parola agricoltura corrispondeva alla parola contadini, che dal punto di vista economico era il mondo dell’autosostentamento familiare, separato dalla città verso cui affluiva solo una parte della quota padronale. Altrettanto sicuramente la parola industria significava, almeno al 90 per cento dei casi, manifattura artigianale e produzione domiciliare dei contadini: essenzialmente la confezione di tessuti di lana, di lino e di cotone. Infine, terziario significava non più di 100/150 mila burocrati, qualche decina di migliaia di professionisti e per il resto della povera gente che lavorava con i velieri piccoli e grandi, nei porti e nelle darsene, nei depositi, sulle spiagge, intorno alle cisterne; e in percentuale ancora maggiore voleva dire facchinaggio, trasporto con i carri, con bestie da soma, con barconi fluviali; voleva dire specialmente uomini e donne impiegati come muli.
Relativamente all’agricoltura, le ricostruzioni statistiche e le stime tramandateci riguardano essenzialmente le produzioni aventi un largo mercato, come il grano, le granaglie, le patate, le castagne, la seta, l’olio e il vino; i tre ultimi oggetto della domanda estera. Le derrate agricole interessavano tutti i livelli del mercato, dalla bottega cittadina all’import/export mondiale. C’erano poi i prodotti dell’orto e dei boschi, che a quel tempo contribuivano grandemente all’alimentazione familiare. Essendo però molto diffuse, entravano nel consumo diretto o, al più, passavano per il mercato vicinale, e perciò erano considerate piuttosto un reddito bruto che un valore. Altrettanto la caccia e la pesca, a cui i consumatori prestavano parecchia attenzione, ma non le statistiche.
La produzione orticola e la frutta non davano luogo (meno qualche frutto come i limoni) a larghe forme di commercio a causa della onnipresenza dell’orto. Si tratta di beni, in ogni tempo, centrali della cultura alimentare di tutte le regioni italiane. Al tempo non avevano un mercato di tipo capitalistico e perciò interessarono poco gli statistici. Il ruolo dell’economia naturale è tratteggiato in una bella pagina di Emilio Sereni* (pp. 14 e 15).
In realtà, nelle campagne e nei villaggi lontani che il capitalismo italiano vien collegando tra di loro e con i centri economicamente più progrediti, un’economia precostituita si trova spesso soltanto in uno stato embrionale. Specie nel Mezzogiorno, ma anche in altre parti d’Italia, la mancanza di vie di comunicazione, i forti residui feudali nelle campagne, la stessa politica delle vecchie classi dominanti e dei vecchi governi, han spesso mantenuto una gran parte dei produttori agricoli in uno stato di quasi assoluto isolamento, e li han lasciati imbozzolire in forme di economia seminaturale, in cui la produzione per il mercato non ha che una parte secondaria, mentre l’attività produttiva si è rivolta essenzialmente al diretto soddisfacimento dei bisogni dei produttori e della sua famiglia. Non solo il piccolo proprietario o il piccolo affittuario della Basilicata o della Calabria, ma anche il mezzadro di regioni assai più progredite, come la Toscana e la Lombardia, all’epoca della unificazione ha ancora un legame assai debole col mercato, anche locale: produce e consuma direttamente la maggior parte del prodotto che non deve consegnare al proprietario terriero. Di qui quella estrema varietà e frammistione di colture nello stesso podere, che costituisce la caratteristica agronomica di tanta parte d’Italia, e che è un serio ostacolo al perfezionamento delle colture: perché ogni contadino deve produrre il suo grano, i suoi ortaggi, la sua canapa, la sua frutta. Per gli stessi prodotti industriali, il ricorso al mercato è in genere assai limitato, l’industria domestica della tessitura, e molte altre minori, sono estremamente diffuse in tutta Italia all’epoca dell’unificazione, e provvedono per una parte assai notevole al soddisfacimento dei limitati bisogni della popolazione.
D’altra parte, anche le economie dei capitalisti agrari e dei grandi proprietari terrieri presentano ancora, al momento dell’unificazione, un grado di sviluppo mercantile tutt’altro che elevato. Certo, proprietari e capitalisti agrari portano sul mercato una parte importante del prodotto che costituisce la loro rendita o il loro profitto. Ma una parte non meno importante viene molto spesso reinvestita nel fondo nella sua forma naturale, senza passare per il mercato. Sementi, concimi, materiali da costruzione, combustibili ed attrezzi agricoli vengono generalmente prodotti e consumati nel fondo, senza ricorso al mercato; e un’altra parte assai considerevole del prodotto lordo non passa neanch’essa per il mercato ed è impiegata, nella sua forma naturale, alla rimunerazione dei lavoratori agricoli, mezzadri, salariati o avventizi: anche queste due ultime categorie, in effetti, ricevono ancora, molto spesso, soltanto una piccola parte del loro salario in denaro, mentre la maggior parte viene corrisposta in natura”.
Se questo è lo stadio economico della gran nassa dei produttori, non è detto, però, che il livello d’esistenza sia uniforme nelle varie regioni, né che le varie regioni siano mancanti di una vita commerciale. Anzi, fu questo uno dei passaggi non infrequenti nella storia italiana, in cui città e campagna si contrappongono fortemente per modelli esistenziali e per prospettive materiali e ideali9.
L’Annuario Statistico di Maestri e Correnti compilato e pubblicato qualche anno prima del 1861, e riveduto successivamente, appartiene a quella categoria di prodotti culturali che non hanno subito il ricatto morale di dovere svalutare, per amor di patria, le Due Sicilie e di dover rivalutare, per amor di patria, le cose riguardanti le regioni padane. Bastano due tabelle per poter affermare che ci troviamo di fronte a un eccezionale esempio di equanimità e onestà intellettuale. La prima riguarda le principali produzioni agricole di ciascuno degli ex Stati. Nella mia presentazione la tabella va letta tenendo conto che nel 1861 il vecchio Regno delle Due Sicilie rappresenta il 36,7 per cento della popolazione italiana, mentre la voce Italia restante comprende il 63,3 della popolazione, ivi incluse le regioni non ancora entrate nello Stato italiano10. Di conseguenza le cifre 36,7 e 63,3 sono, rispettivamente per il Sud e per il Centrosettentrione, il punto in cui produzione e popolazione si confrontano; cosa che ci dà un’idea sia pure sommaria circa l’abbondanza o la deficienza di una produzione destinata alla sussistenza, e indirettamente della connessa autosufficienza alimentare di ciascun ex Stato.
|
|
Tab.1.8a Produzioni agricole italiane intorno al 1860: |
|
Prodotti
|
Due Sicilie.
Migliaia di ettolitri |
Pro-capite Ettolitri |
Italia restante. Migliaia
di ettolitri |
Pro-capite Ettolitri |
|
Grano |
18.060 |
1,97 |
17.760 |
1,10 |
|
in % su Italia |
50,4 |
|
49,6 |
|
|
Granturco |
2.802 |
0,3 |
14.098 |
0,9 |
|
in % su Italia |
16,6 |
|
83,4 |
|
|
Riso |
6 |
. |
1.427 |
0,1 |
|
in % su Italia |
0,4 |
|
99,6 |
|
|
Orzo e avena |
6.254 |
0,7 |
1.543 |
0,1 |
|
in % su Italia |
80,2 |
|
19,8 |
|
|
Castagne |
1.929 |
0,2 |
3.466 |
0,2 |
|
in % su Italia |
35,8 |
|
64,2 |
|
|
Patate |
5.068 |
0,6 |
4.490 |
0,3 |
|
in % su Italia |
53,0 |
|
47,0 |
|
|
Legumi secchi |
1.704 |
0,2 |
2.404 |
0,2 |
|
in % su Italia |
41,5 |
|
58,5 |
|
|
Olio |
937 |
0,1 |
628 |
0,04 |
|
in % su Italia |
59,9 |
|
40,1 |
|
|
Vino |
4.052 |
0,4 |
19.951 |
1,3 |
|
in % su Italia |
16,9 |
|
83,1 |
|
|
Popolazione italiana 25.017.
000
|
9.179 |
|
15.838 |
|
|
in % su Italia |
36,7 |
|
63,3 |
|
Fonte: Correnti e Maestri,
Annuario statistico italiano 1864, cit. da Ghino Valenti
|
|
Il quadro è amaro. Mediamente un meridionale ottiene 2,15 ettolitri l’anno,
pari a 161,25 chilogrammi, tra grano e granaglie; totale che diviso per 365
giorni dà una razione quotidiana di grammi 418 di carboidrati. I grammi
scendono a 270 nell’Italia restante. Naturalmente il Centronord importa
grano dall’estero, la Sicilia l’esporta legalmente o di contrabbando, mentre
l’area napoletana ne importa e ne esporta. |
|
La tabella che viene subito dopo, relativa alla consistenza del bestiame, oltre che realizzare un confronto numerico, mette in evidenza due diverse vocazioni. Scrivono gli studiosi di ieri e di oggi che le Italie agrarie sono tante, ma le diversità si possono ridurre a due assetti agronomici generali, quello dell’albero, tipicamente appenninico e quello del prato, tipicamente padano, in cui, sin dai tempi di Virgilio, primeggia l’allevamento bovino. Queste due Italie si separano (e si separavano anche allora) dalle parti del Rubicone, o forse meglio sui passi montani tra Bologna e Firenze. Ma potremmo dire anche che si congiungono, perché la coltura dell’albero, saltata la Bassa Pianura Padana, ricompare nelle aree acclivi e in montagna, e va a lambire l’arco alpino. Allo stesso modo, ma in senso opposto, l’allevamento del bove s’insinua nella collina appenninica, diminuendo di consistenza man mano che si scende verso sud, ma senza scomparire. Non per niente il nome Italia si dice provenga dai vitelli che pascolavano numerosi e liberi nell’attuale Calabria. |
|
Tab. 1.8 b Dotazione di capi di bestiame
|
|
Bovini
Numero dei capi |
Equini
Numero dei capi |
Pecore
Numero dei capi |
Capre
Numero dei capi |
Maiali
Numero dei capi |
|
Due Sicilie |
400.000 |
*770.000 |
4.531.753 |
1.000.000 |
2.000.000 |
|
Italia restante |
3.308.635 |
421.626 |
4.274.761 |
1.233.825 |
1.886.731 |
|
Totale Italia |
3.708.635 |
1.191.626 |
8.806.514 |
2.233.825 |
3.886.731 |
|
Numero di persone per ogni capo di bestiame |
|
Due Sicilie |
23 |
12 |
2 |
9 |
4 ½
|
|
Italia restante
|
5 |
37 ½ |
4 |
13 |
8 ½ |
*Di cui 600.000
asini
|
Mia elaborazione su Correnti e Maestri, Annuario statistico italiano 1864 e SVIMEZ, cit.
La divisione climatica portava a due concezioni agro-economiche. Secondo la maggior parte degli economisti post-unitari, il deficit bovino corrispondeva a una forma di arretratezza colturale, in quanto all’abbondanza di bestiame era connessa una maggiore disponibilità di concimi organici, e quindi una maggiore produttività granaria. Fino al fascismo e oltre, l’importazione di grano fu una necessità vitale. Ne consegue che gli economisti del tempo non facevano che piangere sulla bassa produttività granaria del Centrosud, causata – oltre che dalla scarsità di piogge estive – secondo loro anche dalle limitate disponibilità di stallatico.
Lo spazio occupato dal grano nelle importazioni italiane deprime lo spirito eletto dei patrioti – specialmente di quelli che sono vicini all’industria e che vorrebbero le masse italiane capaci di nutrirsi d’aria, come i celebri cavalli di Monsieur Perrelle. Nelle importazioni, il grano toglie spazio al ferro e ai macchinari. Il Sud, legato all’Italia in posizione ilotica12, avrebbe dovuto far meglio il suo dovere. Ma alla cosa si arriverà solo con il Duce, il quale, fregandosi del patrio notabilato, metterà a grano il Tavoliere di Puglia. I suoi predecessori democratici e liberali - non diversamente da lui, inclini a porre al centro della vicenda italiana il Settentrione, benché sappiano che a pagare le importazioni sono la seta, l’olio, il vino e gli agrumi - vorrebbero che il ricavato non fosse sprecato ad acquistare grano. Su un punto i critici non sbagliavano: anche la produzione arboricola ha bisogno di concimi organici e, di conseguenza, del sostegno della stalla. Perché di questo si trattava. Infatti non era il numero dei capi di bestiame che faceva la diversità tra Sud e Nord, ma la non attitudine degli animali che il Sud allevava a fornire concimi in abbondanza.
Nella fase protezionistica inaugurata tra il 1878 e il 1888, la produzione arboricola meridionale venne pesantemente punita. Eppure l’Italia dell’albero reagì con insospettato vigore. Perduta la Francia come cliente, andò a cercare nuovi consumatori lungo il Danubio e il Reno (Vöchting, pag. 189 e sgg.). Intanto, con tetragona petulanza l’economicismo nordista continuava a imputare al Sud la colpa di una scarsa estensione del prato. A rileggere le sottili polemiche antimeridionali di cent’anni fa viene solo da ridere. E però viene anche da piangere di fronte alla supinità del padronato meridionale presente in parlamento. Ma il tema – peraltro di notevole pondo - trapassa i limiti di questo racconto13.
1.9 La produzione - considerata agricola ai fini statistici ma effettivamente tra agricola e manifatturiera - che faceva la differenza a vantaggio dell’agricoltura padana, era la seta. Osservano Correnti e Maestri (cit. in Valenti, pag. 26): “Siamo alla miniera dell’oro, che da molti anni ci si è fatta un po’ restia, ma che pure, anche così, è stata la fonte principale della ricchezza italiana. Il quadro che diamo qui ci riporta al 1855, prima che l’atrofia dei bachi avesse diminuito questa abbondanza. Il malore che da otto anni imperversa nei bachi, o nei gelsi, ha stremata d’una metà la produzione della seta. E v’è chi afferma averne la sola Lombardia perduti in questi anni, per mancato guadagno, più che 400 milioni di lire. Ma a badare che, se le sete furono scarse, i prezzi ne corsero vantaggiosissimi, si capisce come le perdite non debbano essere state senza qualche alleggerimento. Ad ogni modo ecco le cifre:”
Tab. 1.9 a Produzione della seta nell’Italia pre 1860:
|
|
|
Quantità
Kg. |
Valore
Lire |
|
Provincie
dell’antico Regno* |
10.902.400 |
46.822.554 |
|
Lombardia |
15.060.350 |
67.247.845 |
|
Parma e Piacenza |
374.082 |
1.906.160 |
|
Modena, Reggio e
Massa |
824.900 |
3.299.000 |
|
Romagna |
754.957 |
4.370.000 |
|
Marche, Umbria |
900.278 |
5.220.000 |
|
Toscana |
1.875.000 |
7.500.000 |
|
Provincie
napoletane |
5.120.000 |
23.852.000 |
|
Sicilia |
2.200.000 |
8.800.000 |
|
Provincie romane |
133.227 |
440.000 |
|
Venezia |
10.920.000 |
39.000.000 |
|
Distretti
mantovani |
152.600 |
648.411 |
|
Totale |
49.217.794 |
209.141.970 |
|
Percentuale del
Sud sul totale delle regioni restanti |
Produzione:
17,5 |
Valore:
15,6 |
*
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Sardegna
Correnti e Maestri, op.cit.
|
|
Come la tabella ci fa ben notare, la differenza non è tra il Sud e il Nord, ma tra tre regioni - Lombardia, Piemonte e Veneto – che da sole producono 37 milioni di chilogrammi di seta su un totale nazionale di 49 milioni. La produzione di seta greggia era, in assoluto, il punto alto dell’economia italiana. Neanche la produzione agrumaria, nel momento in cui raggiungerà il massimo del suo apporto alle esportazioni nazionali, avrà un identico peso e un’identica funzione propulsiva. Inoltre, al consistente valore del prodotto e all’entità del surplus esportato bisogna aggiungere, come ulteriore fattore positivo, il riflesso sociale che la produzione aveva sulla società padana, specialmente in Lombardia, dove l’attività era più pronunciata. Dal punto di vista propriamente sociologico, non era di poco conto che, in primo luogo, una gran massa di contadini e braccianti, diciamo meglio di famiglie campagnole includenti anziani/e e ragazzi/e, si applicasse a una produzione squisitamente esportabile; cosa che comportava sicuramente un coinvolgimento nell’idea di manifattura e di mercato più incisiva che altrove. In secondo luogo, intorno alla seta ruotava un arcobaleno di piccoli, medi e grandi mercanti, nonché di banchieri, di generici prestatori di danaro, di trasportatori, di vettori e di esportatori che il mestiere metteva in contatto con gli ambienti mercantili dei luoghi d’importazione, principalmente la Francia e l’Inghilterra.
1.10 I dati forniti dall’analisi di Maestri e Correnti ci offrono un profilo attardato e infelice del paese italiano. |
|
Tab. 1.10 Valore lordo totale e
pro-capite dei prodotti agrari
riparto per regioni o grandi regioni
omogenee ai prezzi correnti
|
Regioni o grandi regioni |
dei prodotti vegetali
(milioni) |
dei bestiami
(milioni) |
Valore del prodotto
lordo
(milioni) |
Abitanti al.
Censimento del 1861
(migliaia)
|
Valore
pro-capite
|
In lire 1994* |
|
Due Sicilie
|
650 |
220 |
870 |
9.179 |
95 |
572.090 |
|
Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto |
809 |
412 |
1.221 |
9.136 |
134 |
806.948 |
|
Emilia, Romagna, Umbria, Marche,
Lazio e provincia di Massa |
342 |
121 |
463 |
4.186 |
111 |
668.422 |
|
Toscana (meno Massa) |
162 |
80 |
242 |
1.967 |
123 |
740.706 |
|
Sardegna |
- |
- |
48 |
588
|
82 |
493.804 |
|
Totale |
|
|
2.844.000 |
25.056 |
113,5 |
683.497 |
*Una lira del 1861 è calcolata pari a lire
6.022 del 1994
|
|
Mia elaborazione su dati forniti dall’Annuario Statistico Italiano 1864 di Correnti e Maestri e riportati in Valenti (pp. 26 e 27), da Svimez , Cento anni di vita nazionale attraverso la statistica delle regioni, Roma 1961, pag. 18, Istat, Annuario Statistico Italiano 1938, pag. 438
Tenendo conto che nel 1994 il reddito lordo pro capite in Italia era di circa 25 milioni, si desume matematicamente che intorno al 1861 gli italiani avevano la quarantesima parte di quel che hanno avuto negli anni novanta del secolo XX. Bisogna però aggiungere che se la povertà, anzi l’autentica miseria, affliggeva i contadini, anche il tenore di vita di tutti era enormemente arretrato rispetto ai nostri standard. Non dico l’acqua corrente, ma i WC, erano primitivi e carenti persino nei palazzi gentilizi con cinquanta o cento stanze, e a fare il bagno in vasca, a quel tempo, in tutt’Italia non erano più di tre o quattro principesse reali. Sul versante pubblico, il Regno delle Due Sicilie, che pure era lo Stato più grande e ricco della penisola, aveva un bilancio di poco superiore ai cento milioni, circa il tre per cento del prodotto interno lordo.
Intorno al 1860, i contadini erano più della metà della popolazione italiana14. Ciò non significa che la componente contadina della popolazione fosse strabocchevole. Mediamente tre contadini, oltre a produrre per sé, davano da mangiare a due persone esterne all’agricoltura. Chi esamina i dati di quella fase storica deve collocarli nel contesto economico dell’epoca. L’annotazione riguarda principalmente categorie economiche e statistiche come valore aggiunto e industria. Solo alcune sezioni dell’agricoltura, particolarmente la seta, l’olio, il vino, i formaggi, e alcune produzioni minerarie, quali lo zolfo siciliano e i marmi toscani, davano luogo a dei surplus esportabili, permettendo alle varie regioni italiane di partecipare al commercio mondiale. La manifattura artigianale - benché largamente diffusa e a volte d’eccellente qualità, comunque di grande rilievo sociale – aveva uno scarso peso commerciale persino a livello locale, per la semplice ragione che si trattava, di regola, della commessa di un singolo consumatore a un singolo artigiano. In sostanza, l’artigianato forniva una specie di servizio manuale alla comunità d’appartenenza. Spesso i mastri erano pagati in natura, con le eccedenze agricole; le quali a volte erano il risultato di dure astinenze familiari. Pertinentemente il diritto non riconduce tali relazioni al contratto di compravendita, ma li include nei contratti di risultato (locatio operarum). Il barbiere, il maniscalco, il carradore, la sartina non appartenevano al mercato, inteso nel senso di luogo dove si scambiano le merci e nel senso di atto (scambio di una merce contro danaro), perciò parecchie attività secondarie (dell’industria e dell’artigianato) in effetti realizzavano un servizio (terziario) .
Non tutte, ovviamente. La piccola produzione mercantile aveva da tempo larghi spazi, dando luogo sia al lavoro dipendente sia al lavoro a cottimo, specialmente dei contadini, che lo svolgevano a casa propria (manifattura domiciliare). Le maestranze meridionali si applicavano preferibilmente alla tessitura della seta e, per i bisogni familiari, a quella della lana e del lino; quelle settentrionali alla produzione di seta greggia. L’arrivo del telaio meccanico determinò dei cambiamenti. La sua introduzione non fu opera dell’artigiano indipendente, ma di piccoli e medi imprenditori. Erroneo sarebbe, però, immaginare l’Italia del 1855/1860 come mancante di qualunque industria. Sicuramente era presente quella delle cotonine. La produzione artigianale di una pezza di cotone, a quel tempo, costituiva già un non senso economico. Chi si applicava al telaio aveva modo di valorizzare il suo lavoro con tessuti che sul mercato costavano più del cotone, come il lino, la lana, la seta. I tessuti di cotone erano già una merce di massa. Di qualche rilievo era anche la produzione industriale di tessuti di lana. In questo settore, l’industria dava un prodotto medio di gran lunga migliore del prodotto medio dell’artigiano. I gusti della borghesia urbana orientavano il mercato verso le importazioni inglesi, ma a Napoli, in Piemonte e in Veneto cominciava a farsi vedere la fabbrica moderna. La fabbrica tessile, sia motorizzata sia solamente meccanizzata, occupava, in tutti gli ex Stati, forse centomila dipendenti e godeva dovunque di una protezione daziaria e dell’assistenza governativa. Ciò anche dopo l’avvento del liberista Cavour al governo del Regno di Sardegna. Un settore al quale Napoli pareva decisa a inserirsi positivamente era quello della metallurgia; un settore ancora con costi di produzione non concorrenziali, ma egualmente importante per le esigenze militari. Arretrata era la produzione dell’utensileria metallica. Insieme al cotonificio, questo comparto della produzione costituiva il vero metro del progresso industriale, in quanto l’artigiano non è tecnicamente in condizione di offrire un prodotto medio a prezzi calanti e soprattutto non è capace di produrre utensili innovativi, come fa l’industria inglese.
Con quanto sopra non s’intende dire che le categorie industria e valore aggiunto siano impropriamente impiegate per classificare la produzione manifatturiera. Anzi sono appropriate come non mai. Solo che la terminologia non deve indurci a vedere fabbriche quando leggiamo la parola industria e immaginare capitalisti quando leggiamo l’espressione valore aggiunto. Dato il carattere seminaturale dell’economia, anche l’espressione reddito nazionale va intesa come una generica produzione di beni aventi un valore resocontabile in moneta, e non necessariamente beni venduti in cambio di moneta. In effetti si tratta ancora di costi fisici, di utilità o comodità destinate a migliorare un’esistenza alquanto semplice, piuttosto che di input commerciali.
Come sopra annotato, i settori in cui avvennero le prime, impegnative modernizzazioni furono la siderurgia e la meccanica, i cui acquirenti erano essenzialmente gli Stati, che si dotavano di fucili, cannoni, navi da guerra; una politica costosa ed improficua che i nostrani capitalisti imporranno allo Stato per ottant’anni, prima che lo Stato abbia il consenso sociale necessario per liberarsi di loro e delle loro ladronerie, e fondare l’IRI. Al tempo, soltanto le fabbriche napoletane erano in condizione di lavorare anche per l’esportazione, ma dubito che i ricavi coprissero il costo delle agevolazioni statali.
Un carattere spiccatamente commerciale ebbe la cantieristica tradizionale, particolarmente fiorente nell’hinterland napoletano, a Palermo e in tutta la Liguria.
1.11 La bassa produttività agricola del Sud preunitario è un tema che fornisce alla storiografia accademica il destro per edificare il castello di bugie con cui viene spiegato il fallimento dell’unità. Raccontare la verità15 non costituisce una gran difficoltà; difficile è invece riuscire a offrire un discorso comprensibile a chi vive la condizione presente e per sua fortuna non conosce la fame. In appresso accenneremo alla rivoluzione colturale che, dopo l’unità portò all’aumento del prodotto lodo vendibile all’esportazione (Zitara, pag. 36 e sgg.); quel che va detto subito è che l’infelice condizione delle campagne era (ed è tuttora) il male profondo del Sud. Il fatto, di per sé antico, emerge prepotentemente con l’illuminismo napoletano. Ovviamente l’aggettivo infelice non va inquadrato in una logica feudale, allorquando la prosperità dei regni veniva misurata dalla potenza militare del re e dal lusso che la corte poteva permettersi. S’inquadra, invece, in una cornice economica che mette in primo piano le risorse disponibili per la popolazione e un proficuo impiego del tempo di lavoro. Gli illuministi napoletani, a cominciare da Antonio Genovesi, fanno corrispondere il progresso – direi meglio, la libertà – con la penetrazione del mercato a livello contadino (Chorley, pag. 177 e sgg.). Purtroppo, seppur coinvolti nel mercato e divenuti essi stessi merci, i lavoratori meridionali non sono mai passati alla condizione di esseri liberi e felici. Tentarono, però, di esserlo. I centocinquant’anni che vanno dal 1740 al 1890 furono per il Sud una specie di acceleratore nucleare, in cui il paese attraversò drammaticamente sette secoli di storia, nel tentativo di somigliare a coloro che esso stesso aveva iniziato alla moderna civiltà, fallendo completamente però l’obiettivo, e di conseguenza finendo con l’essere la periferia coloniale e maledetta dell’Italia toscopadana e dell’Europa industrializzata.
Motore di detta accelerazione fu la rivoluzione del commercio mondiale, che fece lievitare anche al Sud la borghesia degli affari. I Borbone, i contadini, i padroni di terre, i giudici e i paglietta napoletani vengono considerati come la massa refrattaria: la reazione o la controrivoluzione.
Ricapitoliamo gli eventi. Come è noto, la storia politica, al Sud e al Centronord, ha camminato per strade diverse sin dalla prima unificazione, cioè sin dall’espansione dei romani in Italia (Scarfoglio, pag. 29 e sgg.). Quando Roma emerse dalla barbarie pastorale, il Sud, specialmente il Sud rivierasco, già da tre o quattrocento anni, viveva la splendida civiltà materiale e morale delle colonie greche. La violenta e distruttiva conquista dei Romani portò indietro il Sud fino al loro minor livello, e anche più in basso (idem). L’assetto mercantile venne annientato per far posto al latifondo senatoriale di cui parla Plinio. Nella sostanza il Sud venne degradato a una colonia di approvvigionamento dell’Urbe e della provincia laziale. Le splendide città greche vennero annientate, le campagne furono ripopolate con barbari deportati come schiavi, dopo che le popolazioni autoctone erano state così impoverite che per sopravvivere alla miseria e alla ferocia romana centinaia di migliaia e forse milioni di loro si erano dati spontaneamente in schiavitù ai notabili romani. L’espressione “Graecia capta ferum vincitorem cepit” vuol effettivamente dire che Roma fu portata alla civiltà dai magnogreci vinti e ridotti in schiavitù.
Forse, a partire dall’omologazione augustea, le cose migliorano un poco, ma in ottocento anni di dominazione romana non compare, nell’empireo dei luoghi che contano, il nome di una sola città meridionale. La stessa Napoli, la più antica città dell’Italia peninsulare, ci viene tramandata come se fosse l’odierna Sardegna balneare. In effetti il Sud italiano non è Europa, né lo è mai stato, sibbene il cuore del continente mediterraneo. Per tal motivo prese a riemergere sulla scena della storia che si fa e non si subisce - sebbene in un contesto mediterraneo molto arretrato – dopo il crollo di Roma imperiale, durante la secolare ritirata dell’esercito bizantino incalzato dagli invasori. Data al quel tempo l’emersione alla modernità di Amalfi, di Napoli, di Bari, di Salerno. In detti centri, praticamente indipendenti, vengono gettate le basi economiche e giuridiche del futuro comune libero. Intanto va nascendo l’Europa, originariamente marcata da un carattere tribale e chiaramente non mercantile. Poco avrebbe giovato al Continente affiorato alla storia dalle nebbie dell’a-storia, l’opera della Chiesa, benché ispirata e guidata dalla romanità orientale. Molto più efficace – e non solo per la penisola italiana - fu la funzione civilizzatrice degli arabi, che dal loro avamposto siciliano ri-insegnarono agli italiani il commercio, l’uso della moneta, le tecnologie manifatturiere, l’economia agraria, l’impiego delle acque, la musica, l’architettura, l’urbanistica, lo svago, il sapere antico dei greci e dei romani, che essi avevano assimilato dalle popolazioni bizantine. Per molti secoli, Palermo fu la più ricca e splendida città del mondo; splendide e ricche erano anche le altre città siciliane, che oggi esistono nella geografia politica nazionale solo perché vi risiede un prefetto e un questore; città ormai spente a causa dei saccheggi unitari e definitivamente affossate e date in mano alla mafia, fruttifera di narcodollari.
Aderisco convintamente alla tesi di Benedetto Croce* (pag. 1 e sgg.) secondo cui la rovina del Sud ha inizio con l’arrivo dei normanni, responsabili di avervi introdotto il feudalesimo proprio quando l’Italia rimanente usciva dal sistema barbarico. Il precedente rapporto tra il Sud manifatturiero e la restante Italia agricola si capovolge (Cipolla, pag. 21 e sgg.). Il feudalesimo angioino, aragonese e castigliano distrusse il paese, ne annientò i commerci, l’agricoltura mercantile e le manifatture, in particolare l’arte della seta, in cui il Sud primeggiava. I tessitori si salvarono emigrando in Lombardia, in Francia, nelle Isole britanniche, persino in Svezia, e dovunque trapiantarono l’arte loro. La fiscalità spagnola, l’esternazione d’ingenti somme, la cessione di terre in feudo agli usurai liguri e toscani, creditori dei re stranieri, furono come aceto sulla piaga. Una spoliazione avviata con la calata di Carlo d’Angiò - cioè prima che nascesse Dante - imboccò la strada del tramonto soltanto sei secoli dopo, negli anni in cui si spegneva Gianbattista Vico, allorquando il Viceregno di Napoli e il Regno di Sicilia vennero staccati e resi indipendenti dal Regno di Spagna, per essere assegnati, prima, all’Impero d’Austria e poi al figlio di Eleonora Farnese, da cui ebbe inizio la dinastia dei Borbone di Napoli.
Siamo nel 1734. La domanda mondiale di olio lampante, cioè per alimentare le lucerne, per ungere le macchine e i fili di cotone in fase di tessitura meccanica, era in crescita. Una ricerca famosa - e patriotticamente contestata - di Ruggiero Romano16 connette la nascita della borghesia meridionale con il commercio oleario. Secondo Chorley, esiste anche una visibile coincidenza temporale tra lo sviluppo delle esportazioni olearie e il prendere corpo dell’illuminismo napoletano. Quel che avvenne nei settanta o ottanta anni seguenti è controverso: da una parte il servitorame dell’unità biforcuta e ambivalente, dall’altra il patriottismo meridionale. E’ quindi opportuno che spieghi cosa penso io a riguardo.
A) Il padrone politico del paese era immancabilmente un re o un viceré straniero. Quando il trono andò a Carlo, il Regno, che da ultimo era stato in mano all’Austraia, diventò indipendente. L’illuminista Antonio Genovesi vide nell’evento la nascita di una dinastia nazionale. In effetti, Carlo si comportò coerentemente alle aspettative degli illuministi napoletani. Si liberò delle pretese austriache suonandole all’esercito imperiale e insediò alla direzione del suo governo Bernardino Tanucci, un politico toscano, molto abile e dalle idee aperte. Da subito si accordò con gli illuministi.
B) Ma per quanto Carlo potesse essere il re, e un re moderno, il potere che controllava effettivamente e quotidianamente il territorio - cioè le città, i borghi e il contado – nella parte continentale del Regno (di qua del Faro) veniva esercitato dalla Chiesa, padrona più o meno di un terzo delle campagne. Le terre ecclesiastiche erano nel godimento di un esercito sterminato di frati, suore e parroci (più di centomila), che bene o male ci campavano sopra. Per tal motivo e perché la religiosità era incarnata nell’animo popolare, essi godevano di un fortissimo ascendente. Si pensi, ad esempio, che l’esercito contadino del Cardinale Ruffo fu messo in piedi in poche settimane, e si pensi anche all’opposto: alla remissività popolare verso Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, inspiegabile in termini di psicologia delle masse dopo quel che era accaduto qualche anno prima con il moto di Santa Fè; una rassegnazione certamente imposta ai vescovi e ai parroci da Roma, politicamente bloccata nell’attesa che arrivasse alla decisione finale lo scontro in atto tra Napoleone e le dinastie di diritto divino.
Invece di là del Faro, cioè in Sicilia, i parrini e i monaci non avevano l’esclusiva. Anche i principi latifondisti esercitavano un largo potere sui coltivatori mediante l’impiego di compagnie di bravi, gente adusa al sopruso e al delitto su commissione. Come nel Napoletano, anche in Sicilia - essendosi elevato tra il Seicento e il Settecento, il livello dei consumi vistosi - il costo di essere aristocratici era molto cresciuto. La parte privata – i beni cosiddetti burgensatici - dei patrimoni nobiliari stava evaporando. I fondi passavano nelle mani dei parvenu più avveduti, tanto che, un secolo dopo, ai tempi in cui Giovanni Verga si esibiva nel solleticare l’orecchio ai toscopadani (Moe.), ormai i nobili erano nobili più per spagnolesche albagie che per sostanziose rendite.
Certo i baroni del Regno non ignoravano che gli investimenti in agricoltura avrebbero aumentato la produzione per unità fondiaria, ma, in materia di spese, avevano, prima di tutto, una diversa gerarchia di valori; in secondo luogo il mercato delle derrate agricole, prima della rivoluzione commerciale, subiva annualmente, e anche mensilmente, delle paurose oscillazioni. L’investimento di oggi poteva risultare sbagliato domani. E per la nobiltà17, che a differenza dei coloni poteva ottenere credito, era più profittevole speculare aspettando il momento propizio per vendere il prodotto, anziché investire al fine di aumentare la produzione.
Alquanto diverso, sicuramente peggiore, era lo spirito che animava il padronato di basso rango. Al possesso della terra ci arrivava, qualche volta, anche con la fatica intelligente, ma più spesso con il raggiro, con i brogli ai danni del barone assenteista, usurpando fondi demaniali o parti di essi, rubando nell’amministrazione locale o al patrimonio di un convento, di una parrocchia, di un vescovado. Fra i ranghi della Chiesa, il nepotismo era una pratica corrente, come l’evasione fiscale. Certo, a petto del nepotismo di certi papi romani e di certi cardinali di Curia, era cosa da ridere, ma il Regno non distribuiva indulgenze e non godeva di tributi stranieri, né s’era formato un ceto di grossi banchieri capaci di rubare ai papi e ai fedeli. Diversamente che a Roma, dove rappresentava un consumo produttivo, per l’economia sociale del Regno il nepotismo era un puro costo.
C) In agricoltura, la classe dei produttori era composta da contadini poveri che ottenevano di poter lavorare su una porzione di terra in base a un contratto (non sempre verbale) di colonia o di affitto. Si trattava di fattispecie molto articolate a secondo della tradizione locale, della natura dei terreni e delle colture. In linea generale si può dire che i contratti a lungo termine, le colonìe ad meliorandum, le enfiteusi erano i più favorevoli per la famiglia colonica, e spesso erano l’origine di una minuscola proprietà. A causa della mancanza - dopo la distruzione feudale dell’arte della seta - di città con forti tradizioni urbane e manifatturiere, il contadino meridionale appariva più rozzo, primitivo e povero di quanto non fosse. D’altra parte, tranne che nell’hinterland napoletano, era il contado a influenzare la cultura del padrone, del borgo e della città, e non viceversa come accadeva nel
Lombardo-Veneto e in Liguria.
Pare, tuttavia, che al Sud ci fosse una minore distanza economica tra ricchi e poveri (Malanima.). Sicuramente vigeva anche in secoli lontani una “democrazia culturale” oggi non facile da rinvenire altrove, tranne che nelle regioni venete. Volendola dire giornalisticamente, per il padrone meridionale, il contadino era un uomo, anche se un uomo da sfruttare, non una merce. Ciò non esclude che nelle città minori e nel contado le classi lavoratrici fossero povere e rozze. Sporcizia, abituri, stracci non sono letteratura, ma fatti. Tuttavia la miseria vera, quella registrata dalle commissioni parlamentari d’inchiesta e dai meridionalisti toscopadani, fin troppo commossi per non potere trarre altro sugo dal Sud impoverito, fu un prodotto dell’unità e del buongoverno dei Savoia.
Le masse erano regolarmente analfabete. Il sapere agricolo era ancora quello dei tempi di Esiodo. Si tramandava di padre in figlio. La conoscenza dell’alfabeto non serviva ai contadini, anche se le scuole domiciliari dei preti erano aperte a tutti e praticamente gratuite. Difatti, appena si saliva un solo gradino sociale, i numeri e qualche scarabocchio li sapevano fare tutti (la biografia di Antonio Genovesi, figlio di un sarto-contadino, è esemplare a riguardo). Anche in questo campo, l’unità portò il Sud indietro di un millennio.
Ma il tema nostro sono i rapporti di produzione. Il contadino preunitario aveva di fronte a sé parecchi tipi di padroni. Il padrone migliore era la Chiesa. Trattandosi di roba non loro, parroci e frati inclinavano al lassismo. Incassate le prestazioni contrattuali, che si può dire fossero standard, poco si curavano del resto. Chi era colono della Chiesa se la passava meglio dei compaesani, e se ci sapeva fare riusciva anche a mettere da parte qualche ducato per fare una piccola dote alle figlie.
Dura era invece avere come padrone un gran barone. Questi se ne stava a Napoli o a Palermo e demandava la gestione delle terre al suo amministratore (l’erario, un sostantivo pieno di promesse), di solito uno per luogo. In virtù della sua privilegiata mansione, questi doveva arricchire. Era l’ambiente stesso a pretenderlo. Cosicché rubava al barone e pelava i coloni. Il gruzzolo non veniva sprecato, ma investito nell’acquisto di un qualche fonduscolo, magari messo in vendita dalle stesso barone.
D) I patrii cantastorie hanno ragione di lamentare la presenza, ancora dopo l’unità, di forti residui feudali nelle campagne meridionali. L’eversione della feudalità fu decisa, per la parte continentale del Regno, da un re francese, Giuseppe Bonaparte. Disposizioni borboniche successive l’abolirono anche in Sicilia. A proposito dei residui feudali, che tanta ala pongono ai cantori della cosiddetta questione meridionale, dobbiamo badare a non prendere fischi per fiaschi. Intanto vediamo di cosa si trattava e se presentassero quegli aspetti negativi che la fraseologia unitaria ci porterebbe a supporre. Per prima cosa è opportuno ricordare che non ci sono più i guerrieri bardati di ferro, in marcia verso la Terra Santa, alla testa di pedoni muniti di lunghe lance, ornate di una bandierina con il colori del barone. Ci sono ancora i manieri, ma funzionano da spaziose, anche se cadenti abitazioni di un ricco padrone e della sua ricca famiglia. Magari codesti signori, come qualunque borghese più o meno ricco, tipo Carlo Marx, ingravidano le fantesche o possiedono sull’erba fresca una compiacente contadinella, ma il jus primae noctis non esiste più (se mai è esistito).
Quando si parla di residui feudali, la cosa a cui si pensa di solito sono le corveé a cui il contadino era tenuto in base a un patto negoziale. Per esempio la prestazione di un certo numero di giornate lavorative, di polli, di uova, di panieri di frutta, di forme di formaggio, etc; prestazioni poi non così gravose da provocare due rivoluzioni sociali (secondo i liberali, controrivoluzioni). Ciò che invece Giuseppe Bonaparte abolì, o tentò d’abolire, furono i diritti promiscui e gli usi civici. Oggi tutti hanno le idee chiare sulla proprietà, che è un diritto pieno ed esclusivo (cioè la giuridica impossibilità che altri abbia identico potere sulla stessa cosa). Se teniamo a base tale nostra, comune nozione, il diritto promiscuo era quello che ignorava tale pienezza ed esclusività. Faceva anzi l’opposto. Separava orizzontalmente il diritto di proprietà fra due soggetti: il padrone del bene e una collettività determinata, che aveva il diritto di trarne utilità.
Il titolare del diritto eminente era il feudatario o un ente, diciamo un comune (universitas). Con il consenso del re, il feudatario poteva vendere la terra, o donarla. Alla sua morte era normale che il feudo passasse al suo primogenito. Di regola il re benediceva18. Anche l’universitas, sempre con l’alta autorizzazione del re, poteva alienare il diritto eminente, ma in entrambi i casi il diritto all’uso seguiva il bene, a simiglianza di un diritto naturale della collettività utilista. In linea di massima neppure il re osava revocarlo. Il nostro sistema giuridico conosce gli istituti dell’uso, dell’usufrutto, dell’abitazione (di una casa altrui), ma si tratta di diritti che si estinguono con la morte del beneficiario19. Al contrario l’uso civico era anonimo e atemporale, essendo di regola spettante ai residenti in un certo luogo. Economicamente consisteva nel diritto degli abitanti di un feudo determinato o di un determinato demanio comunale, di accedere al campo per farvi legna, per pascolarvi gli animali (o alcune specie determinate di animali, per esempio, le mucche e non le pecore) e persino per coltivarne un piccolo lotto, per un ciclo o più cicli produttivi.
Questa proprietà monca, come di due proprietari sulla stessa cosa, angosciava gli illuministi napoletani che, però non stavano dalla parte dei baroni, ma della piccola proprietà coltivatrice. Per tal ragione propugnavano una maggiore diffusione del contratto d’enfiteusi. Al contrario, i padroni chiedevano l’abolizione delle promiscuità (chiusure, chiudende, recinzioni, enclosures, non necessariamente erette, ma soltanto giuridicamente poste) a loro esclusivo favore. Su una scena della periferia europea, che non aveva la forza di stabilire l’ora in cui il sole si alza e quando tramonta, la Rivoluzione francese innescò un’ enorme confusione di idee e di lingue. Alcuni prìncipi e duchi si proclamarono giacobini e si misero a urlare insieme agli illuministi. Dal canto loro, i Borbone nicchiarono fino alla fine, onde tenere in piedi il patrimonio ecclesiastico, la cui eversione avrebbe fatto perdere loro il consenso dei preti e dei contadini.
I contadini napoletani volevano la terra, ma non potendola avere si opponevano fieramente alla soppressione dei diritti promiscui. Per come viene raccontata la cosa, il postero si fa l’idea che si trattasse di uno scontro su dei principi politici. Per la gente del tempo era invece una cosa attuale e visibile a tutti, come oggi uno sciopero generale. Intorno alla pretesa del padronato d’ottenere l’abolizione dei diritti popolari si svolsero due autentiche guerre contadine (1799 e 1860-1873), che furono anche due guerre patriottiche20.
Giusta o ingiusta quella resistenza? A quel tempo la terra si lavorava ancora con la zappa in mano, per cui la capacità produttiva di un uomo corrispondeva a poco più della sopravvivenza familiare. Stringendo fortemente la cinghia, se tutto andava bene, una famiglia contadina riusciva a stento a nutrire una famiglia non contadina. Perché un signorotto di paese avesse da magiare a ufo, e perché potesse possedere uno o due abiti di rozza lana, era necessario che avesse terra a sufficienza per concedere trenta o quaranta colonìe. Per fare un ricco signore, i coloni dovevano essere parecchie centinaia. Per mantenere un barone con palazzo a via Toledo dovevano essere migliaia. Per fare il rivoluzionario principe di Sanseverino bisognava si toccasse una cifra con quattro zeri, o forse con cinque.
Il contadino aveva bisogno di legna, di prati spontanei dove far pascolare la capra e di radure nel bosco perché il maialetto potesse grufolare; se un figlio era cresciuto, un altro po’ di terra avrebbe allargato il pane in famiglia. Abbiamo già notato che nell’età feudale di terra (il capitale nell’economia di sussistenza) c’era a sufficienza (sicuramente fino al 1750), i guai arrivavano se c’era insufficienza di braccia. Per farne arrivare delle altre occorrevano tempi molto lunghi. E’ chiaro quindi che i diritti promiscui erano vitali per l’economia feudale. Suo malgrado, il padrone doveva soggiacervi, se voleva disporre di coloni, come il padrone di un decennio fa era costretto dalle cose a sopportare le rivendicazioni operaie.
Come si è detto, al Sud il feudalesimo arrivò con i normanni, i quali sovrapposero la loro concezione giuridica della proprietà a quella quiritaria sopravvissuta durante l’occupazione bizantina, durata più di sei secoli. Peraltro la concezione feudale non cancellò il diritto classico, il quale sopravvisse dove la terra non era infeudata. Cosicché sia in Sicilia sia nel Napoletano coesistevano padroni appartenenti a epoche storiche diverse: il padrone feudale e il padrone di diritto pieno. Anzi l’ambivalenza poteva concentrarsi nella persona di un singolo barone, il quale era obbligato alla concezione feudale in relazione al beneficio regio, ma seguiva il diritto aquilino per i possessi entrati nel suo patrimonio in conseguenza di un negozio d’acquisto o per effetto di una successione o di una donazione. Pertanto, nel Regno, non c’era alcuna rivoluzione culturale e giuridica da far trionfare. Il diritto borghese non era la novità, ma propriamente l’antichità, una sopravvivenza dei millenni trascorsi, quando vigeva la codificazione giustinianea21.
Il passaggio ideologico e pratico – peraltro parziale - dall’economia dei campi aperti a quella dei campi chiusi è collegato alla rivoluzione commerciale e alla cresciuta domanda proveniente dai settori extragricoli e dall’estero. Sollecitato dall’incasso di contante, il padrone vorrebbe estendere, sulla sua terra, le colture mercantili a danno di quelle dirette alla sopravvivenza dei coloni. E vorrebbe anche le terre della Chiesa e dei comuni. Credo che ci sia da aggiungere un altro fenomeno. La popolazione cresce a un buon ritmo e ciò cambia il valore sociale del proletario. Prima la morte di un colono era una perdita economica per il padrone, ora, invece, se un cafone muore, c’è un altro affamato pronto a prenderne il posto. Il diminuito peso sociale del cafone è indirettamente attestato dal successivo modo di pensare. Eleonora Fonseca Pimmentel, che sul Monitore Napoletano descrive i contadini come cannibali e incivili da rieducare, plaude ai massacri che i francesi vanno compiendo e al metodico incendio dei villaggi.
Ma adesso spostiamo per un solo momento il discorso sull’antica dinastia. Un politico, un re, un ministro, un papa, persino i carabinieri hanno bisogno di una platea consensiente. I Borbone avevano il consenso della Chiesa, e per essa degli ecclesiastici; i parroci ispiravano nei contadini l’amicizia e il consenso per i Borbone; i Borbone ricambiavano lasciando in pace le campagne, non torturando gli agricoltori con pesanti tributi. La modernità la cercavano nell’industria - logicamente fin dove poteva arrivare un paese povero. Dall’altra parte del mare non c’era l’America, ma il Nordafrica. Al di là del Volturno e del Pescara non c’era l’Inghilterra, ma un’Italia povera quanto il Regno di Napoli. Perché avrebbero dovuto condividere i progetti borghesi? Se hanno una colpa di fronte alla nostra storia – e ce l’hanno – fu di non avere fatto una vera politica contadinista. Comunque la loro freddezza verso il padronato fondiario è avallata dalla storia. A Italia-una e a demanio smantellato, tra il 1880 e il 1914, il Sud registrò una media di 250 mila emigrati all’anno. Più di otto milioni di emigrazioni in 34 anni, la metà del numero degli abitanti. A questo punto non tanto dei Borbone dovremmo dubitare, quanto della razionalità, oltre che dell’umanità, del sistema liberale e liberista.
E) La cosiddetta eversione della feudalità – leggi meglio, l’abolizione degli usi civici – dopo qualche accenno di riforma di Ferdinando IV, fu decretata nel 1808 da Giuseppe Bonaparte. Un evento giuridicamente chiaro, ma economicamente equivoco. In pratica successe che i contadini cominciarono ad essere espropriati dei loro antichi diritti, senza che nelle campagne venisse fuori un soddisfacente assetto, non dico piccolo-proprietario, ma solo capitalistico22. I crociani (o crocisti) dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza prima di lodare acriticamente la decisione del Napoleonide. Messa, poi, in mano ai Savoia e ai governi nazionali italiani, l’eversione provocò un disastro epocale. Sui demani si abbatté la speculazione dei banchieri toscopadani. Le terre vennero spezzettate, senza sostenere i contadini con il capitale occorrente – come aveva paventato Carlo Cattaneo in una lettera a Garibaldi, dittatore in Sicilia – e comprati, o più comunemente rubati, dai patrioti con o senza camicia rossa.
Al Sud, già nel Settecento, l’olio era la gran magia per chiunque avesse tre piante d’ulivo, la mano di quella Provvidenza, che se non assiste i poveri, benefica sicuramente i ricchi. Nelle province di Bari, Taranto, Lecce, Reggio, nel secolo successivo esistevano vasti impianti a coltura specializzata. Ad avviarli fu l’aristocrazia più avvertita e sana. In Calabria, i Grimaldi si fanno ricordare da sé, per i loro scritti, che anticipano e convalidano le loro opere, ma per fare un solo altro esempio, qui, nella zona in cui vivo, si serba ancora memoria del principe di Gerace come di uno dei più grandi piantatori del Regno. Il valore delle botti da lui vendute toccava nell’annata buona (l’ulivo fruttifica un anno sì e un anno no) i 500.000 ducati, quanto bastava per mettere in campagna una divisione di fanteria.
Ma una rondine non fa primavera. L’agricoltura pretende, a volte, investimenti grandiosi, che solo uno Stato può effettuare; investimenti di lungo respiro, come quelli che fanno la gloria dei Signori di Milano, o come le recenti: Canale Cavour, Bonifica Ferrarese, Bonifica Pontina, Bonifica del Tavoliere di Puglia. Indubbiamente esistono anche territori regionali in cui basta una bonifica di piccola portata per migliorare l’opera del piantatore, come nella collina toscana, veneta, umbra e marchigiana. Ci sono state anche bonifiche mediamente impegnative, alla portata della borsa di un ricco padrone privato, o della fatica dell’umile zappatore, come i terrazzamenti della Penisola Sorrentina, la redenzione dai sassi delle Murge, la liberazione dagli acquitrini di quelle frange costiere, su cui oggi sorgono le Marine Joniche, etc. Nella maggior parte delle valli meridionali, come ben sapevano gli ingegneri idraulici al servizio dei due Ferdinando, la sistemazione delle terre deve partire dalla dorsale montana, devastata del suo manto boschivo sin dal Secondo secolo a. C., e arrivare proprio sulla sponda del mare23. Troppo per un solo privato; e troppo anche per suscitare l’aggregazione di privati socialmente disomogenei: chi assenteista, perché di terra ne ha fin troppa, e chi un nuovo arrivato, speranzoso di ingrandirsi e raggiungere, attraverso più vasti possedimenti, empirei nobiliari.
La bonifica avrebbe creato dei salariati pagati dalla fiscalità generale, e in questo senso extragricoli, dando luogo a un aumento delle entrate monetarie presso le famiglie proletarie. Ma Ferdinando II, anche quando si trovò nella possibilità di spendere, preferì aiutare la crescita dell’industria macchinistica. Sarebbe però ingeneroso mettere due volte l’accento sull’errore . I soldi, che aveva, potevano essere raddoppiati, ma non senza strozzare gli agricoltori. Una terza scelta non c’era, tranne che conquistare Milano e mettere l’operazione in conto ai toscopadani. Nell’ottica di ogni azienda-nazione, l’industria era divenuta un impegno improrogabile. Se il Regno aveva grandi ritardi da sanare, il mondo liberista non era certo d’aiuto. Al contrario stava agguatato per saltare addosso al ritardatario. Sicuramente la Gran Bretagna avrebbe colonizzato il paese e ingozzato le sue migliaia di botti d’olio, come già aveva fatto con lo zolfo. Ferdinando le salvò dagli appetiti d’oltralpe solo per qualche decennio. All’ombra del tricolore, le banche falsarie di Genova e di Firenze le agguantarono intorno al 1890, e da allora non l’hanno più mollate.
F) Quando, l’opposizione ai diritti promiscui di origine barbarica e feudale, il Codice Napoleone eleva a norma di legge il diritto di proprietà nella forma aquilina della assoluta e piena disponibilità del bene (nel caso che ci interessa del fondo rustico), trova l’Italia toscopadana indifferente alla novità, in quanto il problema era stato risolto nel corso dei secoli precedenti, attraverso una transizione qualche volta violenta, altre volte inavvertita e indolore. Non così nel Sud, dove era tutt’altro che ben avviata, a causa della sopravvivenza di una nobiltà che amava i danari, ma non amava doverli lavorare. Da parte loro, in un assetto agrario pochissimo produttivo, i contadini avevano interesse vitale a veder conservati i diritti di pascolo, di legnatico, l’uso a rotazione dei demani feudali e universali (dei comuni regi). Più di tutto, avevano interesse che le terre della Chiesa non passassero in mano borghese. La Chiesa era una buona (cattiva dall’angolo visuale dei liberali) padrona. Era transigente, paziente con i debitori, incline a non vedere i piccoli furti, non era esosa e soprattutto, nel rapporto con i coloni, non ricorreva all’intermediazione di coloro che oggi chiameremmo fattori, che furono la vera peste della società meridionale, in quanto dediti a rubare sia in basso, al contadino, sia in alto, al nobile padrone.
La nobiltà, tranne poche e ricordate eccezioni, non investiva sulla terra per costume; i proprietari borghesi vivevano more nobilium. Nonostante la fiacchezza del padronato la politica riformatrice, gradualista, industrialista e protezionista dei Borbone avrebbe egualmente prodotto risultati felici se non fosse sbattuta contro la rivoluzione borghese e sedicente giacobina del 1799 e se non fosse stata poi rifiutata e tradita dallo stesso padronato. A favore di Ferdinando non si può sorvolare sul fatto che l’unità politica d’Italia venne realizzata quando già il capitalismo commerciale e industriale andava a vele spiegate in parecchi paesi europei e in USA. I cannoni industriali sparavano ad alzo zero le loro merci di massa e i loro bassi prezzi dovunque una nave, un battello fluviale potesse ormeggiare. Ma quei cannoni da cui Ferdinando aveva protetto le popolazioni duosiciliane poi spararono su suo figlio, mandandolo a morire in esilio. Cavour fu invece così abile da portarli dalla sua parte, però gli italiani pagarono la mazzetta d’uso a carico delle piccole potenze industriali per un secolo almeno.
1 Bossi è indubbiamente uno stronzo. Il giudizio riguarda la morale. Bossi è una cosa lorda, come si dice con una pittoresca espressione siciliana e calabrese. La morale, che si applica anche alle formazioni politiche, dice che chi rompe paga. E la Lombardia, dal 1848 al 1940, è costata un fiume di sangue e tre fiumi di danaro agli altri italiani. Nel più perfetto stile dell’imbonitore lombardo, Stronzobossi rivolta la frittella. Dice che non gli basta. L’ingratitudine dei settentrionali verso il Sud, pesantemente umiliato e spennato dall’unità sabauda e da quella resistenziale, repubblicana e partitocratica, li classifica per quello che sempre sono stati: degli usurai.
Se lo stronzobossismo volesse veramente la separazione, non dovremmo che essere felici. Finalmente! Purtroppo non è così. Vuole solo più soldi, e sulla base di uno stronzoconcetto, degno dell’alto spirito meneghino, afferma che i soldi sono i lombardi a farli. Niente di nuovo sotto il sole. Centoquarant’anni fa una congiura tra toscani e lombardi portò il parlamento di Torino ad accollare il peso dell’imposizione fondiaria quasi tutta sulle spalle dei meridionali e dei piemontesi. Oggi, nonostante la mancanza di stile, siamo ancora in quell’ambito politico. Se i meridionali non sanno liberarsi di una classe politica che li svende a ogni passaggio legislativo, paghino pure. Ciò che non può né mai potrà essere accettato è l’insolenza gratuita, il vaniloquio ingiurioso dello stronzobossismo. La questione è tutt’altro che chiusa e prima o poi qualcuno romperà le corna a Stronzobossi e ai suoi logorroici interpreti.
2 Non potrà mai esserlo, stante l’avanzata civiltà degli italiani, i quali non sempre sono solleticati dal desiderio di servire i capitalisti, che in effetti sono la sola classe a cui serve uno Stato nazionale.
3 Nonché, volendo, il debito che prima o poi il Centronord dovrà pagare al Sud.
4 Da sempre le statistiche assegnano la trattura della seta all’agricoltura, ma credo che, considerato il livello delle altre arti, questa produzione, almeno nella Valle Padana, abbia un carattere propriamente manifatturiero.
5 Sulla differenza tra protezionismo e assistenza, cfr. Travaglini, cit.
6 "Lo stato subalpino, per buona parte, non si compone soltanto di piemontesi; si compone anche dell'elemento italico; perciocché non sono piemontesi, quantunque aggregati al Piemonte, i liguri, i sardi, gli abitanti di Novara, Casale, Alessandria…" scisse il marchese Giorgio Pallavicino, esule lombardo in Piemonte. Citato da Romeo**, p.145.
7 Così nel confronto tecnico-giuridico e politico con la costituzione concessa da Ferdinando II ai napoletani.
8 Vincenzo Pautassi (p. 222 e sgg.) fornisce un "quadro sintetico delle casse di Risparmio istituite negli Stati Sardi dal 1827 al 1861". Ne trascrivo l'elenco: Torino, Chambey, Alessandria, Oneglia, Annecy, Pinerolo, Asti, Bra, La Spezia, Savona, Gagliari, Ivrea, Genova, Alghero, Sassari, Vercelli, Chieri, Novara, Rumilly, Casale, Alba, Cuneo, Biella Chiavari, Vigevano, Voghera, Savigliano. Alle stesso settore delle banche caritative apparteneva La Compagnia di San Paolo, che oggi è uno delle massime banche capitalistiche italiane.
9 Si pensi per esempio alla contrapposizione tra padroni e contadini al tempo dell’insurrezione detta Brigantaggio.
10 Per la popolazione Svimez, p. 18.
11 Un ettolitro corrisponde a circa 72/77 chilogrammi per i solidi e a circa 82 chilogrammi per l’olio. Il recipiente che fa da misura ha sempre la stessa dimensione. Sono le granaglie ad avere un peso specifico maggiore o minore. Per esempio il grano, i cui chicchi sono piccoli, ingombra meno dell’avena, i cui chicchi sono pagliosi e leggeri, per cui un ettolitro di grano pesa più di un ettolitro d’avena.
12 Gli iloti sono le popolazioni asservite alla polis di Sparta. Abitano la Messenia e la Laconia, dove sono il residuo di stirpi predoriche.
13 Tommaso Pedio (cit.) incolpa i parlamentari meridionali del fatto di aver piegato la testa di fronte al saccheggio del Sud. La cosa è vera solo in parte. Si tratta comunque di un’interpretazione degli eventi tesa ad assolvere i settentrionali, i quali furono i consapevoli e i determinati artefici di mille trappole fregatorie.
14 Oggi un agricoltore dà da mangiare, a secondo della diversa fertilità della terra e dell’organizzazione sociale dei vari paesi, a 10, 20, 25 persone. C’è però anche una totale improduttività in larga parte del mondo. Cosa da attribuire alle virtù nascoste del liberismo.
15 La storia è una scienza che attiene alla politica. Raccontare la verità storica è cosa diversa che ristabilirla politicamente, essendo ciò compito dei facitori di cultura sociale. In pratica delle forze politiche.
16 Purtroppo non conosco il libro. Il titolo è riportato in bibliografia.
17 La grande aristocrazia regnicola era di varia provenienza: quale normanna, quale angioina, quale aragonese, quale castigliana, quale genovese, quale fiorentina. Spesso il nome del feudo, usato in luogo di cognome, in alcuni casi nasconde detta origine. Sintetizzando fino alla rozzezza il giudizio di Croce*, (pag. 58 e sgg.) si trattava nel complesso di una classe di poca dignità e di scarso onore, assolutamente mancante di patriottismo, piuttosto incline all’intrigo e a trarre vantaggio delle disgrazie dei suoi pari.
18 Vi risparmio qualunque accenno in materia testamentaria, per soffermarsi sulla quale sarebbe, peraltro, necessario il soccorso di un avvocato della Corte della Sommaria.
19 Esempio: nel suo testamento, Tizio lascia al suo fedele servitore Caio il diritto di abitare, fino alla morte, due stanze del vecchio palazzo.
20 Da secoli, i cantastorie del benefico liberalismo ci spiegano che, portato tutto a misura di soggetto privato (e all’interesse del soggetto privato), la mano di Dio – dopo una fase di sacrifici popolari, non si quanto lunga – provvede a creare il bengodi, la ricchezza e il benessere per tutti. Ma la cosa è risultata vera solo per qualche popolo liberale e liberista. Negli altri casi - per esempio nel caso degli africani, degli asiatici, dei latinoamericani, che assommano a circa cinque miliardi di uomini, e persino nel caso di noi meridionali - il Diavolo ci ha messo la coda. Quindi i su lodati cantastorie cantano una storia falsa. E non solo, ma anche bestiale, completamente disumana.
Inoltre non si capisce bene quale Dio, tranne il Dio di Abramo, è tanto poco divino da chiedere il sacrificio delle generazioni viventi perché Rocco e i suoi fratelli vincano l’Enalotto milanese. In realtà, quella delle generazioni future è una storiella per gli allocchi, simile alla concione che il Gatto e la Volpe indirizzano a quel sempliciotto di Pinocchio.
Sono penetrato in un territorio che volevo lasciare fuori dal discorso. Ma a volte capita che certe cosi si mettano a girare per autopropulsione. Oltre al resto, so bene che i nostri progenitori greci dicevano “grosso libro, brutto libro”. Ma visto che ormai mi trovo in difetto, aggiungo che l’unità - se altrove fu cosa diversa - qui fu essenzialmente reazione anticontadina. Il fatto che poi non sia stata accompagnata dal trionfo della borghesia si spiega richiamando l’altro volto del liberalismo e del liberismo, cioè l’imperialismo e il connesso problema degli sbocchi. Al Sud, l’Italia toscopadana conquistò la sua prima colonia, e non solo la saccheggiò, ma impedì anche che i suoi conflitti interni arrivassero a conclusione. Tale e quale ciò che un secolo prima aveva fatto la Gran Bretagna in India. Noi possiamo fare anche un minestrone mettendoci dentro la massoneria, il tradimento organizzato, il principio di nazionalità, Napoleone III e gli zuavi, la sconfitta dell’Impero austriaco, gli intrighi della perfida Albione, la questione degli zolfi, Luigi Settembrini e Carlo Pisacane, l’ingegno di Cavour, l’indipendentismo dei Siciliani, persino il pupazzo Garibaldi, ma la verità vera è che l’unità sabauda al Sud ebbe gli stessi motivi politici e sociali che avevano ispirato sia gli insorti giacobini del 1799 sia i loro avversari, i contadini di Santa Fede, cioè l’abolizione dei diritti promiscui; un evento paventato in basso, contro il quale, a partire dall’unità, i cosiddetti briganti si batterono per più di dieci anni, pagando con decine e forse centinaia di migliaia di morti.
21 Nell’età moderna (feudale per il Sud), la scienza giuridica napoletana, la più affinata al mondo, si sviluppò praticamente - e gli avvocati prosperarono - su detta ambivalenza.
22 Per arrivare a qualcosa di positivo, bisognerà aspettare la rivoluzione agraria centrata sulla produzione vinicola e agrumaria, che presero a svilupparsi a partire dal 1835, sospinte dalla domanda estera, a sua volta connessa all’innalzamento del tenore di vita in Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda, USA, Argentina, Svizzera, Austria e Germania. Fu una grande occasione per il Sud conquistato, che tuttavia svanì in un baleno, follemente bruciata, intorno al 1885, dal governo nazionale.
23 La Cassa per il Mezzogiorno, pur fra tante critiche (confindustriali e non), ha sicuramente il merito di aver predisposto piani particolareggiati di bonifica integrale, e in più di un luogo (per esempio la Sibaritide e il Metapontino) è potuta intervenire efficacemente e risolutivamente.
|
| |
| <- Indietro -
Continua -> |
|
|
|
|
|
 | |