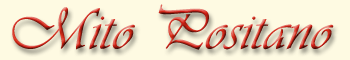|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricoltura | Industria | Terziario |
| 4.200.000.000 | 1.500.000.000 | 1.700.000.000 |
| Totale nel settore privato | 7.400.000.000 |
| Settore pubblico | 400.000.000 |
| Totale Italia | 7.800.000.000 |
| Per abitante | 312 |
In un assetto economico, in cui industria era sinonimo di manifattura
artigianale per almeno il 90 per cento dei 3.390.000 addetti, non c’è altro
modo per farsi un’idea del valore regionale, che quello di partire dal
numero
dei censiti (come ha fatto certamente l’Istat relativamente all’intero).
Assunto questo dato, ho applicato ai produttori industriali di ciascuna
regione l’identica produttività accertata in agricoltura, diminuita del 6,4
per
cento, in forza del fatto che la produttività media nazionale in agricoltura
risulta pari a lire 487, mentre la produttività media nell’industria risulta
pari a
442 lire. La più bassa media pro capite assegnata all’industria conferma che
sarebbe difficile concedere alla manifattura di quei decenni le attuali
virtù
produttive. Come ho ripetuto spesso, si tratta essenzialmente di artigiani,
e gli
artigiani non stavano certo peggio dei contadini. Ma diversamente da oggi,
la
bottega artigiana del tempo era affollata di garzoni e di apprendisti, i
primi
poco pagati, i secondi solitamente non pagati in virtù del fatto che
imparavano
il mestiere. Ciò abbassa la media, cosicché la cifra indicata dall’Istat
sembra
pertinente.
Utilizzando i dati assunti a base del calcolo, si ottiene la seguente
tabella.
Tab. 2.2b Valore della produzione nel settore manifatturiero calcolato per
regione o macroregione
| Regioni o macroregioni | Addetti all’ industria(migliaia) |
Prodotto procapite nell’industria Lire |
Area di mercato dei prodotti industriali per regione |
| Area padana | 1.140 | 542 | 617.800.000 |
| % su Italia | 33,6 | ||
| Toscana | 277 | 531 | 147.087.000 |
| % su Italia | 8,2 | ||
| Stato Pontificio | 346 | 317 | 109.682.000 |
| % su Italia | 10,2 | ||
| Due Sicilie | 1.596 | 384 | 612.864.000 |
| % su Italia | 47,1 | ||
| Sardegna | 31 | 417 | 12.227.000 |
| % suItalia | 0,9 | ||
| Arrotondamento del decimale |
340.000 | ||
| Italia | 3.390 | 442,48 | 1.500.000 |
| Percentuale degli attivi nell’industria sul totale Italia |
23,6 |
Come si vede, non ho tenuto alcun conto della maggiore presenza, nell’area
napoletana, di impianti industriali funzionanti con moderne caldaie a
vapore,
praticamente le uniche in Italia, e del fatto che tra l’hinterland
napoletano e la
Calabria detti impianti occupavano non meno di 10 mila operai. Si trattava,
in
effetti, di promesse per l’avvenire (un avvenire che patriotticamente non ci
sarà), ma non certo delle fonti di un apprezzabile surplus sociale.
Ovviamente,
ciò che vale per le Due Sicilie, dove le novità industriali scendono dai
forzieri
del Banco omonimo, vale anche per Genova e Torino, dove le pochissime
novità industriali scendono anch’esse dall’alto, e per la precisione dalle
non
linde pieghe dei bilanci del Regno sabaudo, cioè dalle brache del liberal
(ma
solo per i fessi) conte di Cavour. In verità l’encomiastica che ciascuno di
noi ha
inghiottito ingenuamente a scuola non ha altro significato che il servilismo
degli
storici nei confronti del vincitore.
Comunque la si metta, i numeri dicono che nel Sud, al momento della
disastrosa unità, gli addetti all’industria erano una percentuale più alta
che
nell’Italia restante. Lasciamo da parte le caldaie a vapore, a cui badiamo
soltanto per avere un’idea della politica industriale dei vari governi, e
fermiamoci alla produzione tradizionale. Ora, c’è manifattura e manifattura.
Come abbiamo visto c’è quella costituita da un servizio fisico alle
famiglie, c’è
quella di lusso e ci sono aziende manifatturiere che hanno carattere
preindustriale.
La prima – in buona sostanza l’artigianato locale – essendo al
servizio di gente povera, dava luogo a prodotti certamente non raffinati,
anche
se poi niente esclude che fossero buoni e solidi. A Napoli, l’artigianato
era di
qualità elevata. Non così in provincia: solo i damaschi catanzaresi avevano
celebrità. Di Napoli erano famosi in tutto il mondo le carrozze, gli abiti,
i
guanti, le scarpe. Anche in questo campo la Napoli borbonica stava parecchie
spanne sopra le altre città italiane, non escluse Venezia e Firenze. Non
bisogna
peraltro dimenticare che Napoli è a quel tempo una metropoli europea, di
gran
lunga la prima università italiana, oltre che la capitale della filosofia,
della
storiografia, del diritto, della medicina. E’ tanto più avanti la cultura
moderna a
Napoli, che solo quando Antonio Scialoja e Raffaele Piria si rifugiano a
Torino, il
Piemonte può fondare le cattedre di Economia Politica e di Chimica. Nel
campo
musicale Napoli fa da caposcuola. Il San Carlo è prestigioso almeno quanto
l’Opera di Parigi e i teatri di Vienna. La corte napoletana è del massimo
rango
dinastico. Queste cose bastano a provare ampiamente il livello della
manifattura di lusso.
Ma ciò che più importa ai fini del futuro sviluppo economico riguarda il
fenomeno della preindustrializzazione (Deane) e quelle imprese che già
offrono
merci di massa a un consumatore anonimo. Pur senza il nome, questo filone di
studi è antico in Italia, ma dopo il trionfo toscopadano la storiografia
unitaria
(specialmente servili gli storici nati al Sud) si è accanita fino al
ridicolo a voler
negare l’evidente primato napoletano nella manifattura. Un lavoro che ha
dato
risultati perché, man mano che si è andati avanti con lo Stato nazionale,
l’apparato ha provveduto a cancellare i segni del passato, persino i beni
artistici e monumentali, a cominciare dalla reggia di Caserta e dalla
Certosa di
Padula, usati come caserme, stalle, prigioni, o letteralmente lasciati
andare in
rovina. Un accurato panorama della preindustria meridionale si trova nella
prima parte del primo volume di Arias (cit.). Altra opera che suppongo ben
documentata è Corrado Barbagallo, Origini dell’industria contemporanea, che
conosco solo per sentito dire.
Caduto il fascismo, che aveva messo il bavaglio al pensiero meridionalista,
a
cento anni circa dall’infausta unificazione, lo storico Domenico Demarco ha
inaugurato un’equanime ricerca sull’economia preunitaria che, direttamente o
indirettamente, mette a confronto l’economia duosiciliana con quella
dell’Italia
restante. Una valorizzazione in chiave polemica delle ricerche precedenti
sono
due libri di Capecelatro e Carlo usciti intorno al 1970 (citati), che ebbero
vasta
eco politica e culturale. Nelle università di Napoli, di Palermo, di
Catania, in
altre sedi accademiche, il lavoro va avanti. Trascrivo qui di seguito delle
pagine
che riassumono i risultati acquisiti.
"Nel 1839, durante il regno di Ferdinando II di Borbone […] tutta la costa,
fra Napoli e Castellammare, era punteggiata da manifatture industriali
legate
alla trasformazione dei prodotti locali, alla ricchezza di acque e alla
vicinanza
del mare. Tra le attività più diffuse si annoverava la lavorazione delle
pelli; nel
1864 nella sola provincia di Napoli si contavano 21 fabbriche di pellami,
delle
quali 2 a Resina, 3 a Castellammare e ben 16 nei pressi del ponte della
Maddalena. Numerose erano anche le fabbriche di materiali da costruzione e
di
cristalli, le distillerie di alcolici, nonché i pastifici che, sebbene
diffusi un po’
dovunque nel regno e nella provincia di Napoli, erano particolarmente
concentrati nel territorio compreso tra Gragnano e Torre Annunziata.
Una notevole consistenza avevano le industrie cartarie e tessili.
Quest’ultima
comprendeva l’artigianato, la piccola e grande industria, presente
soprattutto
nella Terra di Lavoro e nel Salernitano […]. Nel 1851 la Schlaepfer e Wenner
impegnava oltre 1.400 operai nelle fabbriche di Angri e di Ponte della
Fratta.
A Solofra si sviluppò l’industria conciaria, un’attività che molto
verosimilmente risaliva all’età alto-medioevale; nel 1857 le concerie
censite
erano 51, delle quali 37 di notevoli dimensioni. La concia industriale si
diffuse
in tutta la regione ed in vaste aree del regno, fondandosi anche
sull’imponente
patrimonio zootecnico disponibile. Napoli, in particolare, era famosa per la
produzione del guanto bianco che, intorno al 1860, raggiungeva il numero di
circa 850.000 paia annue.
La siderurgia e la metalmeccanica rappresentavano, tuttavia, il ramo
industriale più consistente con una struttura assai differenziata che
variava
dalle piccole fonderie private, presenti per lo più nella zona Mercato, al
complesso di Pietrarsa, la più importante industria italiana del tempo. La
sua
fondazione risale al 6 novembre 1840, in seguito all’acquisto dei suoli nei
pressi della "Batteria francese", ai quali si aggiunse, nel 1844, un’area
compresa tra la spiaggia e la linea ferroviaria; l’orografia stessa del
terreno
determinò l’andamento planimetrico del complesso. Il reparto più antico, la
Torneria, a due navate ritmate da massicci arconi a sesto acuto, fu
realizzato
nel 1842 e vi trovarono lavoro 200 operai. Nel 1847 l’opificio era in pieno
sviluppo e assorbiva 500 operai che raggiunsero col tempo le 1.250 unità.
Si erano intanto aggiunti alla Torneria l’officina per il montaggio delle
locomotive, la gran sala costruzioni con macchine utensili, l’impianto di
trasmissioni e grandi gru, la fonderia con forni fusori per la ghisa e getti
di
bronzo, il reparto per la lavorazione delle caldaie, la fucileria e la sala
modelli.
Nel 1853 il complesso di officine era completo in tutti i suoi reparti;
nasce così
il più importante stabilimento industriale di tutta la Penisola, che precede
di 44
anni la fondazione della Breda e di 57 quella della Fiat.
Al complesso di Pietrarsa si affiancava l’opificio dei Granili, destinato
alla
fabbricazione di caldaie fisse marine e di locomotive, che aveva sede
nell’enorme edificio costruito da Ferdinando Fuga e occupava un’area di
20.000
metri quadrati, di cui 10.160 coperti dalle officine fabbri e calderai.
Questi complessi industriali, insieme alla Real fonderia, all’Arsenale e ai
cantieri navali di Castellammare, costituivano la struttura portante delle
industrie siderurgiche statali.
Molti imprenditori privati erano di nazionalità straniera, in qualche caso
personalità di spicco del mondo industriale europeo, attratti nel Meridione
dalle
considerevoli possibilità di guadagno offerte dalla politica protezionistica
perseguita in quegli anni. Richard Guppy, ad esempio, nel 1852 fondò un
opificio meccanico sulla strada della Marina ritenuto uno dei più importanti
del
regno sia per capacità produttiva che per qualità dei prodotti. La fabbrica
occupava un’area di 16.000 metri quadrati di cui 8.000 coperti ed impiegava
500 operai (Alisio, pag. 6).
"Nel 1863 lo stabilimento fu ceduto in fitto dallo Stato unitario
all’industriale
di Piombino Jacopo Bozza che, dopo i noti episodi dello sciopero represso
nel
sangue e dell’attentato subìto qualche giorno dopo a Napoli, preferì
prudentemente rinunciare al contratto. Si formò allora una società di
imprenditori e capitalisti napoletani, la Società d‘Industrie Meccaniche che
rilevò lo stabilimento e l’edificio ai Granili e li amministrò in fitto fino
alla crisi
del 1877, sopravvivendo stentatamente grazie alle poche ma preziose
commesse governative destinate all’ammodernamento della marina e delle
costruzioni ferroviarie. Ritornata allo Stato, Pietrarsa fu infine ceduta
alle
Ferrovie Meridionali e quindi alle Ferrovie dello Stato continuando la
costruzione di locomotive a vapore, carri e vetture ferroviarie fino
all’ultimo
conflitto.
Negli stessi anni di Pietrarsa si avvertì anche un certo sviluppo della
iniziativa privata, concentrata nella sola capitale, giacché la mancata
meccanizzazione dell’agricoltura ed il persistere di vecchi metodi di
produzione
sconsigliarono analoghe iniziative nelle varie province. Anche questa fu
opera
di stranieri: Guppy, Pattison, Corradini ed altri e di tecnici meridionali
formatisi
all’estero, come Alfredo Cottrau.
Thomas Richard Guppy, industriale inglese di Bristol, si stabilì a Napoli
nel
1849 e quattro anni dopo fondò la Guppy & Co, in società con il connazionale
di Newcastle Giovanni Pattison, architetto macchinista impiegato nella
società
Bayard. La nuova ditta costruì il suo stabilimento nella zona del Ponte
della
Maddalena, divenuta ormai area di sviluppo preferenziale del primo
industrialesimo napoletano ed iniziò la sua attività producendo chiodi,
presse e
pompe idrauliche, ferro in verghe ed acciaio in barre, lamiere e tubi,
ampliando
successivamente la gamma dei suoi prodotti fino a costruire macchine a
vapore, caldaie e macchine per battelli e ponti in ferro. Allo scadere del
contratto decennale, la società si sciolse ed il Pattison, con i figli
Cristofaro e
Thomas Taylor, costituì la C. & T.T. Pattison, mentre la Guppy conservò il
suo
nominativo. La consistenza del mercato interno non era però talmente
migliorata da favorire l’attività di due stabilimenti di media grandezza ed
in
effetti entrambi stentarono a sopravvivere, sia prima che dopo la crisi
degli
anni Settanta e ne vennero fuori anch’essi grazie alle sole commesse
governative. La situazione economica generale si era nel frattempo aggravata
con l’abolizione delle tariffe doganali, mentre le grandi imprese di
trasporti
ferroviari, a prevalente capitale straniero, preferivano rifornirsi
all’estero,
privando così delle commesse il mercato napoletano, ove peraltro operavano
ormai anche alcuni stabilimenti minori: l’Opificio meccanico Luigi Oomens,
la
fonderia dei Fratelli Delamorte, la Fonderia Matherson & Co. e lo
stabilimento
metallurgico dello svizzero G. Corradini sul litorale di San Giovanni.
Nel 1885 la Guppy aumentò il capitale e l’anno dopo si associò con
l’importante azienda metalmeccanica inglese R. W. Hawthorn - Leslie and Co.
di Newcastle-upon-Tyne, intervenuta in Italia in previsione delle commesse
governative destinate al potenziamento della marina militare. Dalla fusione
nacque la Società napoletana Hawthorn-Guppy che si sciolse nel 1904 per
cedere definitivamente i suoi stabilimenti alle Officine Meccaniche di
Milano.
Anche la Pattison abbandonò la propria ragione societaria e si trasformò,
nello
stesso anno, nella Officine e Cantieri napoletani C. & T.T. Pattison S.p.A.,
mentre, sempre da Newcastle, un’altra grande industria inglese di motori
marini ed armamenti, la Armstrong, Mitchel & Co. decise di aprire una
propria
linea produttiva in Italia: nel 1886, sull’arenile di Pozzuoli, sorgerà così
il
Cantiere Armstrong, che inizierà immediatamente la produzione di materiale
d’artiglieria con l’impiego di oltre mille operai.
Con l’approvazione alla Camera della legge speciale per lo sviluppo
industriale di Napoli, varata nel 1904, convergeranno infine al Sud anche i
capitali settentrionali. L’Ansaldo di Genova e l’Armstrong di Pozzuoli
daranno
allora vita alla più grande industria meccanica italiana specializzata in
produzioni belliche e nel 1909-11, nell’area di Bagnoli, sorgerà uno
stabilimento dell’ILVA, primo impianto siderurgico italiano a ciclo
completo.
Entrambi passerano poi sotto il controllo dell’IRI e nel 1961 infine, dalla
fusione
dell’ILVA con la Cornigliano, nascerà l’ITALSIDER, delle cui vicende più
recenti
sono piene le cronache di questi ultimi anni (Rubino, pag. 9 ).
"La concentrazione della lavorazione, le tecniche ed i macchinari impiegati,
il
numero degli operai occupati, la consistenza dei capitali, la produttività e
la
commercializzazione dei manufatti raggiungono ben presto proporzioni tali da
collocare queste fabbriche al primo posto nell’industria meridionale del
periodo
e all’avanguardia nel settore in Italia.
Il successo è dovuto ad una propria, se pur limitata, disponibilità di
capitali,
alla capacità di collegamento col capitalismo tedesco ed inglese, ai
contatti
commerciali e tecnici instaurati con aziende e mercanti di tutta Europa, al
felice
sfruttamento delle opportunità di sviluppo fornite dal protezionismo
borbonico
e dalle potenzialità autoctone (la manodopera a basso costo, il mercato
napoletano, l’energia idraulica). La solidità è tale da assicurare la
continuità
della crescita quando con l’Unità d’Italia il protezionismo ha fine. I
progressi
postunitari riguarderanno soprattutto tre nuclei cotonieri salernitani,
attraverso
il continuo aumento dei capitali sociali, la creazione di nuovi impianti, il
potenziamento di quelli originari: il Vonwiller, poi Aselmeyer, a Fratte di
Salerno, Pellezzano e Nocera; lo Schlaepfer-Wenner ad Angri, Pellezzano e
Fratte; i Meyer e Zollinger, poi Freitag e poi Roberto Wenner a Scafati e
Castellammare. I tre gruppi, collegati tra di loro fin dalle origini, grazie
ad una
accorta politica di vincoli matrimoniali e societari si fonderanno agli
inizi del
Novecento nelle Manifatture Cotoniere Meridionali, inglobando anche due
grosse fabbriche sorte a Poggioreale. Nasce così uno dei più grossi
complessi
tessili d’Italia, che, passato presto in mano a capitalisti italiani,
sopravviverà,
in alcune fasi stentatamente, fino ad oggi (De Majo, pag. 12).
I fatti raccontano ciò che gli storici hanno voluto tacere. E cioè che il
paese
meridionale non solo era attrezzato di un’industria, di una cantieristica,
di un
sistema creditizio più avanzati che negli altri ex Stati, ma disponeva di un
apparato di manifatture preindustriali alquanto largo e forse
percentualmente
più consistente che nell’Italia restante. Chi governava aveva cura di
preparare
al passo successivo. Ed era quanto Cavour e i suoi accoliti dovevano
distruggere, al fine di usare le risorse del paese e assoggettarlo agli
intrallazzi
padani.
2.3 Le attività del settore terziario non erano nuove come il nuovo Stato
truffaldino, bensì antiche e molto più sviluppate della manifattura -
realmente
capaci di valorizzare il prodotto in agricoltura; cosa che era l’idea che
ispirava
Cavour, anche se, poi, questi s’impappinò e divorò Piemonte e Italia senza
ottenere altro che di portare l’Italia indietro di buoni vent’anni. Una
ripartizione
bruta della produzione regionale, simile a quella fatta per la manifattura
sarebbe ingiustificata, non corrispondente alla realtà. L’intensificarsi
degli
scambi europei e mondiali aveva imposto a tutti i vecchi Stati di riversare
sul
settore trasporti investimenti significativi. Un dato su cui gli
storiografi-patrioti
preferiscono sorvolare è che il paese investiva nel settore trasporti da
molto
prima che Cavour conclamasse l’importanza delle ferrovie. E lo aveva fatto
nel
trasporto marittimo, creando delle dotazioni di rilevante impegno
finanziario e
di notevole produttività. Difatti nel 1850 la marina italiana,
cumulativamente
considerata, era parecchie volte più potente che al tempo di Napoleone.
E’ bene ricordare che il secolo XIX è solo in parte, e sicuramente non nella
massima parte, il secolo delle ferrovie. E’, piuttosto, il secolo in cui gli
scambi
mondiali raggiungono un livello mai conosciuto prima. E’ il secolo della
grande
emigrazione europea in America e degli imperi coloniali; un secolo, quindi,
di
navi e di marineria, quanto mai altri periodi della storia. Intorno al 1860
le
ferrovie - le piemontesi, le lombarde, le toscane, le napoletane –
rappresentavano soltanto un costoso investimento per il futuro. Al momento
non realizzavano neanche le rate annue di ammortamento del capitale.
Relativamente alle ferrovie piemontesi è persino difficile parlare di
investimenti
sabaudi, in quanto la rete piemontese venne costruita a debito, e il debito
venne caricato sul resto degli italiani. Comunque, nel 1861, le tratte la
cui
gestione non era in perdita erano solo quelle in cui il treno faceva da
tranvai –
la Napoli-Portici, la Milano-Monza, la Torino-Savigliano, la Firenze-Pisa -
in
tutto un paio di milioni all’anno di fatturato.
Non ho alcuna voglia di fare le coccole a Cavour, un liberal-imperialista,
un
patriota-clown, che in pochi mesi riuscì a gettare nel caos l’economia
duosiciliana e a portare al disastro il lavoro meridionale; uno sfacciato
colonialista, un giocatore perdente, un faccendiere la cui folle politica
precipitò
tutta l’Italia in miseria. Per più di quarant’anni, le ferrovie furono
soltanto una
passività di bilancio (Pala, pag. 337), l’occasione per tali e tanti
intrallazzi che
è persino difficile raccontarli. Al Sud, poi, non furono un servizio allo
sviluppo e
alla civiltà, ma un mezzo di conquista e di dominio, utile soltanto alle
armate
sabaude per mettere a ferro e fuoco il Sud. L’esempio classico è la
repressione
dei Fasci Siciliani, che non sarebbe stata così pronta e facile (per loro)
come fu,
senza l’aiuto del treno. Se si vuole essere onesti, come di regola gli
storici
sabaudi non sono, per gran parte del secolo, persino nei decenni finali,
allorché
la rete ferroviaria era quasi ultimata, ad aggiungere nuovo valore
commerciale
fu solamente la marina mercantile.
A riguardo, i dati forniti dai contemporanei sono concordanti. Intorno al
1860
il patrimonio mercantile italiano (non peschereccio) era composto da poco
più
o poco meno di 20.000 unità, tra navi grandi, medie e piccole, per una
stazza
complessiva tra le 600.000 e le 775.048 tonnellate, e un equipaggiamento
compreso tra i 98.000 e 125.000 uomini (Demarco, pag.224 e sgg. e Petino,
pag. 275. e sgg.). In media, 6,2 tonnellate per marinaio, e 6,5 uomini per
nave.
Sappiamo anche che in tutti gli ex Stati l’aiuto pubblico aveva sia una
forma
diretta e immediata a favore del proprietario di nave, sia una forma
indiretta,
attraverso il privilegio alla bandiera e gli sconti daziari. A Napoli, il
regime di
favore fu a lungo mancante. Andava invece al naviglio battente bandiera
inglese e francese, per imposizione di quei civilissimi governi. La marina
duosiciliana fu parificata a quella dei due paesi non negatori di Dio,
nonché
liberi, liberali e liberisti, solo nel 1845. Nonostante tale sudditanza, a
partire
dal 1825, il Regno s’impegnò a riappropriarsi dei trasporti e dei
collegamenti
interni, da sempre zona di pascolo abusivo di genovesi e livornesi. Il
progetto
fu rapidamente realizzato, anzi andò oltre le più rosee speranze. La
marineria
duosiciliana conquistò l’indipendenza per le rotte mediterranee e
atlantiche,
per l’India, per l’Australia, qualche volta battendo in velocità i vascelli
inglesi.
Un paese circondato dal mare rendeva obbligatoria l’opzione navale. Il fatto
che con l’unità gli interessi commerciali meridionali verso gli altri paesi
del
Mediterraneo, specialmente del Mediterraneo Orientale, fossero evaporati
fino
a bruciare il fondo della pentola, non può portarci a essere così cretini da
asserire che le ferrovie e i trafori fossero una scelta trionfale e
trionfante anche
per l’infelice Sud italiano. Simili cazzate le incoroniamo di crisantemi e
le
portiamo il 2 Novembre sulla tomba dell’on. professor Luzzatto, e magari
anche su quella del nostro don Benedetto, on. senatore del regno. Il
trasporto
navale era meno costoso di quello ferroviario, cosicché sarebbe interessante
appurare se Ferdinando ristette nel costruire ferrovie dopo i grossi
benefici
apportati al Regno della marineria.
Ma se il movimento marittimo divenne intenso, i porti invece rimasero pochi.
E qui sarebbe da capire l’opposto di quanto sopra, e cioè se Ferdinando non
spese nelle infrastrutture portuali, pur avendo le risorse per farlo, in
quanto
stette a sfogliare la margherita tra navi e ferrovie. Comunque, tra il 1817
e il
1890, al Sud ogni rada funse da caricatoio per il commercio della città
costiera
e del suo retroterra, spesso non lontano dalla costa e servito da tracciati
collinari disposti a pettine rispetto al mare, e non come avvenne poi da vie
che
portavano a Bologna e Milano. La navigazione da punta a punta era la regola
e
venne scelta persino dagli insorti in occasione di sommosse e rivoluzioni.
Per
quel che mi è capitato di leggere, solo lo storico inglese Chorley (cit.) ha
capito
(o forse è stato tanto spregiudicato da parlarne) questo aspetto
dell’assetto
meridionale, non diverso da altri luoghi del Mediterraneo e dell’Italia
restante. I
noli realizzati dal cabotaggio napoletano, peraltro sempre contrastato dalla
vivace concorrenza dei velieri francesi, spagnoli, inglesi, genovesi e
livornesi
(cosa che smentisce le fandonie gladstoniane circa la negazione di Dio e dei
suoi santi) fecero da moltiplicatore dell’accumulazione commerciale
napoletana
e siciliana, in detto settore forse maggiore che quella derivante dalla
marineria
di lungo corso. I profitti armatoriali divennero così significativi da
sorprendere
positivamente uno studioso cauto negli entusiasmi, quale era Ludovico
Bianchini (cit. pag. 529).
Il commercio estero napoletano, sebbene sottovalutato nelle statistiche
degli
stessi Borbone (cfr. Graziani, pag. 208), che chiusero un occhio, e spesso
tutt’e due, sul contrabbando largamente praticato sui confini marittimi,
appare
consistente nel confronto con gli altri ex Stati. L’import/export ufficiale
toccava
i 60 milioni di ducati (255 milioni di lire sabaude), ma dovremmo parlare di
almeno di 120 milioni di ducati, se non di più. Come vedremo meglio in
appresso, a conclusione delle operazioni di conversione delle monete
preunitarie le monete borboniche rastrellate dal nuovo Stato furono il 65
per
cento del totale. Questo dato residuale ha portato gli studiosi a sostenere
che
nel Sud la circolazione monetaria pro capite fosse più alta che nel resto
d’Italia; un’autentica contraddizione per coloro che sostenevano (e
sostengono) che il mercato napoletano fosse meno sviluppato che negli altri
Stati preunitari. Nitti ha sostenuto che i meridionali mettevano le monete
sotto
il mattone. Di conseguenza la circolazione monetaria duosiciliana sarebbe
stata
soltanto una parte delle monete poi rastrellate. La spiegazione non sta in
piedi.
Il fatto vero è un altro. Per prima cosa le monete degli altri ex Stati, che
vennero rastrellate dall’amministrazione nazionale italiana, furono solo una
parte esigua della circolazione preesistente. La restante parte o era andata
all’estero clandestinamente, o in una fase di non facile credibilità dello
Stato,
era stata accantonata come riserva dai privati, o era stata incassata dalla
Banca Nazionale, e poi fusa e spesa fuori dei confini italiani. Per seconda
cosa,
mettiamo per un momento che il padronato meridionale non spendesse tutto
quello che incassava dall’estero (essendo una bilancia attiva la condizione
ineliminabile per disporre di metalli preziosi), e che la circolazione
monetaria
fosse lenta. Ma appena fatta l’ammissione, sbattiamo le corna contro
l’entità
degli sconti bancari. A Napoli, il credito era più elevato che altrove. Gli
sconti
del Banco delle Due Sicilie, tra il 1825 e la fine dell’indipendenza, si
mantennero su una media annua vicina ai 90 milioni (in lire sabaude), una
cifra mai raggiunta in nessun luogo dell’Italia restante, né da tutta
l’Italia
restante. E poi, accanto alle dodicimila navi, certamente non costruite e
pagate
a scopo di diporto, ci sono a Napoli forme di incetta dei piccoli e medi
risparmi,
che non collimano con l’idea di una popolazione di tesoreggiatori. La più
caratteristica mi sembra essere la cambiale di piazza; un negozio che
racconta
molte cose.
Si trattava di un pagherò non in valuta, ma in merci, con scadenza a tre
mesi o quattro mesi, emesso dai grossi mercanti, i quali se ne servivano per
raccogliere danaro. Il prenditore cambiario era creditore di una quantità
certa
di merci, per esempio dieci tomoli d’olio, tre cantaia di grano, ecc., di
cui era
incerto quale sarebbe stato il prezzo al momento della scadenza. Il
prenditore
era libero di trattenere il titolo o di disporne mediante girata, come di
una
qualunque cambiale. Alla scadenza, il mercante che aveva emesso il titolo,
di
regola, non pagava in olio o in grano. Non era quello che voleva il
portatore,
ma il corrispondente valore monetario della derrata, al prezzo corrente il
giorno della scadenza. Nel frattempo il mercante aveva usato il capitale,
mentre il creditore aveva speculato al rialzo o al ribasso sul titolo, che
aveva
una sua quotazione giornaliera in borsa. Insomma, la speculazione – che
insieme all’azionariato popolare nella città di Napoli era così diffusa da
incontrare forti critiche da parte degli esperti d’economia (De Matteo,
cit.) -
poteva fiorire intorno al commercio delle derrate: per chi ci sapeva fare,
con
buoni margini di profitto, e per gli ingenui, senza eccessivi rischi. Con
tale
sistema Napoli metteva in movimento decine di milioni di ducati all’anno.
Quest’assetto commerciale, fortemente oliato, funzionava molto meglio delle
girandole del Comm. Bombrini e di quelle del suo illustre Mentore, ed è
disonesto che ciò rimanga sotto la polvere di una storiografia ufficiale
sempre
felice di dimenticare qualunque cosa in cui il Regno napoletano possa
apparire
più moderno dell’Italia restante.
Tutto ciò per dire che il quadro economico italiano non è descritto dalla
conversione delle vecchie monete. Sarebbe illogico credere che le monete
portate alla conversione dai toscopadani fossero tutte le monete circolanti
nei
loro ex Stati. Egualmente illogico sarebbe immaginare che i meridionali
abbiano tirato fuori, da sotto il mattone dove le tenevano, le loro monete,
solo
dopo l’unità, per convertirle in una carta che ai loro occhi valeva meno che
niente.
Tornando all’argomento navigazione, non sarà inutile al lettore qualche
notizia sul (defunto) Cantiere di Castellammare. Scrive Gennaro Matacena
(cit.)
"Nel 1780 Ferdinando IV dispose che a Castellammare fosse realizzato "un
cantiere per la costruzione delle Reali navi e accomodato meglio il Porto;
nonché stabilito un Dipartimento della Real Marina".
Con quest’atto, si avviò un’impresa industriale notevolissima, che divenne
un
elemento centrale nello sviluppo economico e sociale del Regno delle Due
Sicilie e anche uno dei poli trainanti del settore cantieristico nazionale
postunitario.
Ferdinando scelse Castellammare per la sua antica tradizione di maestri
d’ascia, nota già all’epoca degli Svevi. Durante le dominazioni angioine ed
aragonesi, i suoi numerosi scali di costruzione e di alaggio impiegavano
quasi
la metà della popolazione maschile; nell’epoca vicereale, la velocissima
"tartana grande latina" stabiese era nota in tutto il Mediterraneo.
Questo patrimonio di esperienze fu dunque intelligentemente valorizzato dai
Borboni che resero Castellammare uno dei più attivi cantieri del
Mediterraneo,
seppure a fasi alterne connesse all’instabilità politica del Regno.
Nel 1818, a Vigliena, fu varato il "Ferdinando I", primo pirovascello
italiano.
Con Ferdinando Il, il cantiere stabiese venne ancora potenziato e le spese
per
la marina militare furono duplicate fino ad arrivare a 3.300.000 ducati.
Nella
sola Castellammare, fino all’Unità, furono costruite 50 navi di tonnellaggio
medio, oltre a naviglio minore e numerose trasformazioni e riparazioni di
navi
mercantili. Il 18 gennaio del 1859, Francesco II fu inconsapevole testimone
del
varo dell’ultima nave costruita per la Marina napoletana, la fregata
"Borbone".
Oltre al polo cantieristico, il Regno si dotò di un articolato sistema di
infrastrutture portuali e favorì lo sviluppo di un ragguardevole indotto
manifatturiero, in particolare quello metalmeccanico, al quale contribuirono
imprenditori inglesi, francesi e svizzeri. A Napoli, nel 1852, fu inaugurato
il
"bacino di raddobbo" — ancora oggi visitabile —; l’Arsenale fu poi
potenziato a
più riprese. Fu favorito l’incremento del traffico marittimo con la
ristrutturazione degli scali del Regno e con accordi commerciali che il
governo
stipulò con altre nazioni, anche del Nord Europa e Oriente. Questa politica
autonoma, come è noto, determinò la reazione, più o meno palese,
alternativamente, di Francia e d’Inghilterra, che ne ostacolarono
l’evolversi.
All’unificazione, lo Stato italiano, dinanzi alla consistente realtà
tecnologica
ed imprenditoriale raggiunta dal Mezzogiorno, anche se non uniformemente
diffusa sul territorio, scelse la strada del ridimensionamento.
Nel 1864 Bixio presentò alla Camera il progetto di chiusura del cantiere di
Castellammare e dell’Arsenale di Napoli, cui fecero seguito licenziamenti e
accesi scontri d’opinione. In quegli anni, la stessa sorte toccò alle
Officine
Ferroviarie di Pietrarsa, che furono declassate a "Officina Grandi
Riparazioni",
ed alla Fonderia e Fabbrica d’Armi di Mongiana, che fu ceduta all’ex
garibaldino
Achille Fazzari, e poi chiusa definitivamente nel 1872. Cominciò dunque una
"questione Castellammare" dentro la più vasta "questione meridionale" che
verteva sul "ruolo" industriale da assegnare al Mezzogiorno. Tra continue
proposte di cessione dei cantieri a privati, commissioni ministeriali,
petizioni
firmate da politici meridionali, dibattiti parlamentari, il destino di
Castellammare divenne incerto, mentre si potenziarono i cantieri liguri e
veneti
e se ne fondò, nel 1884, uno nuovo a Taranto.
Sebbene in regime di continua proroga, tra il 1861 ed il 1918, i cantieri di
Castellammare vararono ancora 83 navi militari, alcune delle quali furono le
più grandi unità della Marina Militare del Regno. Al loro fianco, i cantieri
privati
napoletani, soprattutto Armstrong a Pozzuoli e Pattison a Vigliena,
costruirono
navi di grosso tonnellaggio, anche per altre nazioni. Il naviglio
mercantile,
brigantini e golette, era soprattutto varato nei cantieri sorrentini e in
quelli di
Procida e Baia; gli armatori napoletani comperavano navi anche all’estero,
in
particolare a Marsiglia e in Inghilterra.
Dal 1918 agli inizi degli anni ‘80, a Castellammare furono costruite più di
170 nuove navi, alcune superiori alle 50.000 tonnellate di stazza, oltre i
micidiali M.A.S. e naviglio per attività specialistiche.
Ed ancora a Castellammare furono varate due imbarcazioni note al grande
pubblico: la nave scuola Amerigo Vespucci (1931) ed il batiscafo Trieste
(1953), con il quale lo svizzero Auguste Piccard raggiunse i 3.150 metri di
profondità nelle acque di Ponza".
2.4 Non conosco (certamente per colpa mia) la procedura con cui l’Istat ha
definito la cifra di un miliardo e 700 milioni relativamente al prodotto
annuale
del settore Commercio, Trasporti e Altre attività. Ora, un commercio senza
trasporti è uguale a zero valore aggiunto. Se ho prodotto dieci chili di
pomodori
e li vendo sull’aia del mio podere, realizzo il valore del prodotto. Se non
si
verifica un’aggiunta sociale al valore della merce, l’atto negoziale non
aggiunge
alcunché al mio lavoro di agricoltore. Nel nostro paese e altrove persino la
legislazione tributaria non sottopone gli agricoltori ai tributi che vengono
applicati al commerciante per l’identica operazione. Ovviamente, anche a
quel
tempo il commercio all’ingrosso si fondava sul trasporto. E il trasporto via
mare
era già da migliaia d’anni una branca professionalizzata e di tipo
capitalistico;
cosa che non sempre avveniva per il trasporto via terra, che avveniva con
carri
e carretti il più delle volte condotti dallo stesso produttore. Inoltre le
ferrovie,
anche dove erano state stese le rotaie, pare che non trasportassero (o che
non
ce la facessero a trasportare) granché. Il trasporto che, in termini di
economia
volgare, aggiungeva un consistente valore era quello navale. Una parte
rilevante dell’ipotizzato miliardo e settecento milioni attribuito al
commercio e
ai servizi spetta certamente al trasporto navale, in cui il Regno napoletano
aveva una posizione largamente dominante.
Tab. 2.4b Valore aggiunto dal trasporto navale per regione
| Navi | Percentuale su Italia |
Addetti Numero |
Prodotto del trasporto navale Milioni |
|
| Area padana | 4.864 | 31,5 | 39.375 | 219,7 |
| Toscana | 921 | 4,5 | 5.625 | 31,4 |
| Stato Pontificio | 1.969 | 9,0 | 11.250 | 62,8 |
| Due Sicile | 12.925 | 55,0 | 68.750 | 383,6 |
| Sardegna | - | |||
| Italia | 20.679 | 100,0 | 125.000 | 697,5 |
Fonte della prima e seconda colonna: Petino, cit.
2.5 L’attività dei professionisti e i servizi che essi rendono sono
presentati
sotto la voce Varie. E anche qui vi sarebbero problemi di valore connessi
con il
prodotto delle varie aree ex statali. Tra il Sud e l’Italia restante esiste
una
pesante disparità in molte cose. Una riguarda gli iscritti all’università.
Indubbiamente, tra il prodotto di un sacrestano e quello di un medico, anche
a
quel tempo ci sarà stata una bella differenza. Semmai, il problema
statistico
starebbe nel quantificarla. In verità si tratta d’investimenti che a quel
tempo
non avevano un ritorno immediato in termini di surplus economico. Gli
studenti
duosiciliani erano sia i cadetti della rendita feudale in disfacimento, sia
dei figli
di campagnoli. Nella grande proprietà la legge, scritta o non scritta che
sia,
domina il maggiorasco. Agli figli toccherebbe la povertà più o meno
dissimulata
dal possesso di un’abitazione signorile. Nel commercio, la strada è stretta
perché, nelle Due Sicilie, esso si fonda sul trasporto navale, che è
riservato a
chi conosce l’arte d’andare per mare e agli abitanti di luoghi in cui esiste
una
forte tradizione marinara e cantieristica (Gaeta, Sorrento, Amalfi, Messina,
Sciacca, Bagnara, Bari, Barletta, Otranto, Gallipoli, ecc.). Non restano,
come
per Dante, che le arti maggiori.
Stesso discorso per chi veniva dal basso. Quando un massaro poteva
permetterselo, spediva il figlio in una delle città universitarie perché
prendesse
una laurea. Evidentemente il reddito della terra non gli appariva
moltiplicabile,
o forse il suo sogno era di liberare il figlio dalla gleba e magari di
portarlo a un
livello signorile. L’incontro di persone così diverse per estrazione sociale
e per
ricchezza, nel caso di Napoli, per giunta in una città fortemente
interclassista,
fu la materia sociale su cui imperversò, fino a maramaldeggiare, la satira
napoletana, da Scarpetta ai De Filippo. Ma fu anche l’occasione di una
comunicazione interclassista, di una specie di democrazia sociale,
all’interno
delle classi istruite meridionali, ignota ad altre regioni.
Ma qual era il sogno sociale incorporato in quel gran numero di laureati? E’
la stessa storia dell’industria borbonica. Nessuno potrà mai saperlo. Al
sogno è
seguito un risveglio fatto di un blocco sociale corrotto – la grande
disgregazione – che pesa come un macigno sul passato, sul presente e
sull’avvenire del paese meridionale.
Riassumendo quanto prima tabulato, avremo:
Tab. 2.5b Valore aggiunto nel settore terziario per regione
| Regioni e macroregioni |
Prodottodel trasporto navale in Milioni |
I due settori del terziario |
Totale | % |
| Area padana | 219,7 | 452,1 | 671,8 | 39,5 |
| Stato Pontificio | 31,4 | 107,3 | 138,7 | 8,2 |
| Toscana | 62,8 | 80,2 | 143,0 | 8,4 |
| Due Sicilie | 383,6 | 335,8 | 719,4 | 42,3 |
| Sardegna | 27,1 | 27,1 | 1,6 | |
| Italia | 697,5 | 1.002,5 | 1.700,0 | 100,0 |
Detta in chiaro, l’area duosiciliana, nonostante l’evidente debolezza della
sua agricoltura, disponeva di un’armatura commerciale relativamente più
forte
dell’area padana (peraltro, in larga parte, soggiogata agli interessi
dell’Austria)
e anche della Toscana e dello Stato pontificio; un dato – ove occorresse una
riprova – ampiamente corroborato e avvalorato, come meglio vedremo,
dall’eccezionale liquidità e dalla notevole entità del settore bancario.
Messa in conto la cosiddetta arretratezza e contabilizzate le partite
attive,
avremo:
Tab. 2.5c Ampiezza del mercato
| Regioni e macroregioni | Agricoltura di mercato |
Settori extragricoli |
Area di mercato |
|
| Area padana | 757,6 | 1.272,6 | 2.030.200.000 | 42,8 |
| Stato Pontificio | 122,0 | 221,8 | 343.800.000 | 7,4 |
| Toscana | 162,2 | 347,7 | 509.900.000 | 10,8 |
| Due Sicilie | 482,6 | 1.316,6 | 1.799.200.000 | 38,0 |
| Sardegna | 28,1 | 27,1 | 55.200.000 | 1,0 |
| Italia | 1.552,5 | 3.200,0(3.185,8) | 4.738.300.000 | 100,0 |
| Italia | |
| Prodotto privato | 7.400.000.000 |
| Area di mercato | 4.738.300.000 |
| Percentuale | 64,0 |
Le estrapolazioni qui effettuate non bastano a descrivere l’estensione del
mercato duosiciliano. A Napoli e in Sicilia circolava più danaro che
altrove. La
domanda estera era così elevata che il governo doveva raffreddarla con
vincoli
e dazi all’esportazione. Il sistema bancario napoletano era "uno dei meglio
affinati al mondo" (Enciclopedia Bancaria cit. alla voce "Banco di Napoli").
Persino F.S. Nitti cadde nell’errore grossolano di immaginare che i
napoletani
risparmiassero una gran parte dell’argento coniato. Ma il suo pessimismo non
è
corroborato dai dati. Intanto nelle Due Sicilie i depositi bancari,
attraverso la
fede di credito, si trasformavano ipso facto in una diversa specie di
circolante
(del tipo vaglia della Banca d’Italia), che presentava requisiti di
comodità,
garanzia e sicurezza ben maggiori della banconota emessa a Genova e Torino.
Le fedi erano praticamente garantite dallo Stato. Come presso ogni banca,
poi,
il deposito presso il Banco raddoppiava il danaro stesso. Il danaro veniva
dato
in prestito sia ai privati sia al regio governo. Infatti la Cassa di Sconto
del
Banco duosiciliano rimetteva in circolazione intorno al 50 per cento del
numerario ricevuto in deposito. L’altra parte veniva utilizzata dal tesoro
sempre mediante fedi bancarie. In sostanza, il Banco impiegava (raddoppiava)
le somme depositate. In buona sostanza la circolazione duosiciliana era
maggiore della quantità del numerario in appresso contabilizzata dalle
ricevitorie dello Stato italiano. Indubbiamente a Napoli e in Sicilia c’era
il
mattone, sotto cui la povera gente nascondeva il suo pezzo d’argento, e
c’erano le casseforti segrete dei ricchi. Ma dove, nell’Italia del tempo,
non
c’erano mattoni e rispostigli segreti?
Quanto sopra non vuole assolutamente dire che le Due Sicilie fossero più
ricche dell’area padana. Erano soltanto meglio governate.
2.6 Sebbene io sia tutt’altro che un fautore del sistema liberista e
capitalista,
di capitalismo debbo parlare, perché la vicenda che qui tratto si svolge
nell’ambito di tale (selvaggia, irragionevole e disumana) categoria.
Adam Smith ha chiarito una volta per tutte che il capitale altro non è che
il
potere di comandare lavoro. Successivamente Marx ha reso più visibile il
concetto aggiungendo che nel processo produttivo sono presenti tanto il
lavoro
vivo (di coloro che lo stanno compiendo), quanto una forma di lavoro che
egli
ha chiamato lavoro morto. Esemplifico. Se una qualunque fabbrica è istallata
in
un capannone costruito in precedenza mediante un certo numero di giornate
lavorative, se dentro il capannone operano un certo numero di macchine
costruite in precedenza da altri fabbricanti, se nel capannone viene
consumata
energia elettrica prodotta in una centrale elettrica esterna, per cui il
proprietario pagherà una bolletta alla fine del bimestre, se nel fabbricato
vengono lavorate delle materie prime acquistate e pagate dal padrone: tutto
questo e molte altre cose ancora sono lavoro già compiuto, finito, definito
nel
suo valore, oggettivato, fatturato, pagato (o che comunque da pagare). Il
capannone potrebbe rimanere vuoto, le macchine ferme, le materie prime
inutilizzate, il contatore non girare, tuttavia il capitale è già speso o
impegnato.
Mettendo insieme le due voci, nel processo produttivo il capitale non è
altro
che (uno) lavoro morto, (due) danaro per pagare i salari. In buona sostanza
il
capitale è il potere di comandare lavoro.
E’ perfettamente chiaro che, negli anni di cui ci stiamo occupando, la
disponibilità di un capitale liquido (monetario) corrisponde al potere di
comandare lavoro. Ciò subito, o in un futuro meno prossimo. Un potere
comunque potenziale, nel senso che può essere esercitato o no, che può
essere ceduto volontariamente ad altri (o che si deve cedere ad altri, come
nel
caso dei tributi), o da altri scippato.
Partendo dalla categoria potere di comandare lavoro, siamo in condizione di
confrontare il potenziale capitalistico duosiciliano e quello padano prima
della
mala unità.
Tab 2.6 Potere di comandare lavoro nelle Due Sicilie e nella Padana prima
dell’unità italiana (1858)
| Circolazione metallica e di vaglia bancari |
Circolazione di carta fiduciaria |
Potere di comandare lavoro |
Indice | |
| Due Sicilie | 464.100.000 | 89.000.000 | 553.100.000 | 100 |
| Regno sardo | 202.100.000 | 57.000.000 | 259.100.000 | - |
| Lombardia | 112.300.000 | - | - | - |
| Veneto | 99.900.000 | - | - | - |
| Ducati | 38.800.000 | - | - | - |
| Totale Padana | 510.100.000 | 92 |
Oggi le situazioni sono sovvertite. Il Sud italiano è finito allo stesso
modo
del celebre Teatro San Carlo. Prima dell’unità era il primo teatro d’Italia,
oggi
neppure i musicisti meridionali gli danno un minimo di considerazione. Dico
di
più: oggi la gente è stata convinta (dalla servile Tv e dai servili
giornali) che La
Scala di Milano è sempre stata il più prestigioso teatro lirico d’Italia e
del
mondo.Non c’è patria che tenga. Le colonie sono colonie, anche se
s’infiocchettano con un nastro tricolore.
Dall’oro alla banconota inconvertibile:
3.1 Oggi l’Italia è una delle nazioni più ricche del mondo, ma esauritasi la migrazione a basso prezzo, il contributo che il paese meridionale dà alla creazione di tale immensa ricchezza consiste soltanto negli introiti in valuta derivanti dal lavaggio delle narcolire, che vengono accettate – come si dice a Napoli - indifferentemente sia a livello pubblico che privato. Fino a qualche decennio fa l’assurdo ruolo del Sud nello Stato nazionale veniva indicato onnicomprensivamente con l’espressione questione meridionale, la quale, come più volte qui detto e ripetuto, rispediva ai Borbone e a una immaginaria inettitudine dei meridionali ad avere successo come capitalisti - un’escamotage degna della più raffinata ipocrisia meneghina - le responsabilità storiche dello Stato italiano. Queste responsabilità erano tutt’altro che sintetiche. La stravagante organizzazione dello Stato e della società civile venuta fuori dall’unità portò un’infinità di novità negative. Ciò dette vita a una sottoclasse della storiografia nazionale ricca di vigore ed elevata come livello, la quale risulta essere tanto più nobile e calzante, quanto più miserabile e scientificamente posticcia ci appare la storiografia unitaria. Il lavoro al quale mi accingo s’accoda a tale vecchia ricerca; il che significa mettersi a rifriggere un tema già servito in tutte le salse, e farlo per giunta in un momento in cui la formazione nazionale "Repubblica Italiana" appare vicina alla fine della sua equivoca esistenza. Allora perché tornarci su? Perché mettere a dura prova il proprio stomaco e quello altrui con una frittella inacidita? Diversamente dagli individui, le formazioni sociali vivono millenni. A morire sono solo le istituzioni che esse si danno di volta in volta. Il mutamento è opera dell’uomo, di ogni uomo, che vi contribuisce con il suo lavoro e le sue idee. La formazione sociale chiamata Meridione o Mezzogiorno (sottinteso d’Italia) e la cultura degli uomini che l’abitano, viene da lontano; da un tempo in cui l’Italia non era ancora l’umile Italia di Virgilio e il continente Europa era ignoto a quegli uomini che già sapevano descrivere i luoghi e narrare le vicende umane. In antico il Sud fu chiamato con vari nomi: Esperia, Enotria, Ausonia, Italia, Magna Grecia. Finita la dominazione romana, il suo nome politico mutò spesso, in connessione con i dominatori terragni che lo avevano sottomesso. Forse in avvenire sarà battezzato con un nome ancora diverso, tutto da coniare. Comunque, essendo una formazione economico-sociale a sé stante, la sua identità si dissolverà soltanto quando si dissolveranno tutte le aziende-nazioni e il mondo presenterà un uniforme livello di sviluppo. Quindi, la giustificazione politica di questo libro (e della fatica che faccio a pensarlo e a scriverlo) è evidente: che nel prossimo futuro il Sud italiano non sia più quello che attualmente è, una colonia dissimulata di milanesi e fiorentini. Nel 1925 Gramsci lo vide come una grande disgregazione sociale. Eppure ai suoi tempi il mercato unico nazionale non era ancora riuscito a corrompere e a disgregare ogni cosa. Per esempio la produzione agrumaria siciliana e l’industria conserviera napoletana pesavano cento volte più dell’industria meccanica torinese nell’interscambio con l’estero, e le rimesse degli emigrati rappresentavano un sostegno primario dell’economia nazionale. Ma anche queste posizioni di retroguardia sono andate completamente perdute. L’Italia ha portato a compimento la sua opera nefasta. Rimane solo l’idea, il rispecchiamento in cielo, di un popolo antico, generoso, intelligente, laborioso. La nostalgia del regno napoletano, della dinastia borbonica, di Ferdinando II, di Maria Sofia, dell’eroica e nobile difesa di Gaeta, sono riemersi quali santini di un’indipendenza sognata. Certo, senza santi non si cantano messe, ma il problema di queste popolazioni ha un diverso spessore. Si tratta dell’ambiguità occidentale già presente nell’anima greca. Da una parte Ulisse, dall’altra Nausica; da una parte la sfida, dall’altra l’amore e la pietà. Vincenzo Cuoco (cit.), che impostò questa tematica sin dalle prime avvisaglie del processo unitario, parla di religiosità solare degli elleni (il mito di Apollo che guida il carro del sole) e di religiosità lunare di chi li aveva preceduti (la madre Proserpina, abitatrice degli inferi, ma anche madre delle messi). Potrei dire che ritengo il concetto più convincente dell’antropologia del peccato e della salvazione immaginata da Max Weber. Però, giunto a tale acquisizione, non saprei andare oltre. Perciò resto con i piedi nella storia, la quale suggerisce che il Sud vi sta dentro solo a condizione che vi stiano dentro anche le popolazioni del Mediterraneo Orientale. Il Sud italiano non combacia culturalmente con l’Europa allo stesso modo che il Mediterraneo Orientale non combacia con gli ebrei terragni che hanno occupato la Palestina. La rinascita del Sud è interconnessa con quella mediorientale. Al di là di Dante e della lingua comune, Italia è un nome che non dice molto a livello sociale e politico, ove si consideri che le varie sue parti hanno avuto origini civili e una storia notevolmente diverse. Una parte si è affacciata alla storia in seguito alla colonizzazioni punica e greca, l’altra parte – quella romana - è entrata nella storia proprio dopo aver distrutto le città elleniche. La conquista romana spinse indietro il Sud e cancellò la civiltà magnogreca. Ma poi, caduto l’Impero e divenuta l’Italia centrosettettrionale un regno barbarico, e quella merdionale un esercato dell’Impero Romano d’Oriente, l’antica frattura culturale pre-romana riemerse. Tra la cultura mediterranea del Meridione e la cultura terragna del Centronord barbarico emersero profonde diversità; probabilmente le stesse che esistevano prima della conquista romana. Queste diversità misero radici dopo che la Chiesa di Roma volle dividere la Penisola in due aree politiche contrapposte, favorendo nel Centronord il diffondersi e l’imporsi del Comune Libero e delle Signorie, in funzione anti – imperiale, e nel Sud la dominazione di re stranieri, avversi all’Imperatore germanico. Dalla sconfitta e morte di Manfredi (1266) all’arrivo a Napoli di Carlo Borbone Farnese (1734), il Sud fu bloccato, anzi sospinto costantemente a retrocedere verso la barbarie della gleba. L’insistenza di Mazzini, prima, poi di Cavour e della cosca tosco-padana, padrona del nuovo Stato, a voler Roma come capitale, sacrificando Torino, Milano e Firenze, che pur erano i centri propulsori del nuovo corso, non ha altra spiegazione che il tentativo di ripristinare lo zoppicante sodalizio dell’età romana. Secondo Mazzini e secondo la massoneria, il Sud italiano andava portato al Nord italiano, ed in sostanza all’Europa terragna. Ma il disegno è fallito. A questo punto è da chiedersi se la sezione mediterranea tornerà a essere indipendente. Solo la forza delle idee e la Discordia, che accende i popoli, daranno una risposta al quesito. L’Italia-una è un aborto. Peraltro, dove la vicenda sociale è antica quanto la storia stessa, le nazioni non sono tenute a essere vaste quanto il Brasile o ilCanada. Taranto, Siracusa, Sibari, piccole realtà territoriali, ebbero un ruolo politico, economico e culturale ben più grande dell’Italia odierna. Anche se la mia idea è chiara e netta nel giudicare oltre che inevitabile, anche positiva la separazione tra Sud e Centronord, non ho un giudizio negativo sull’idea risorgimentale di Mazzini. Forse uno Stato unitario, figlio della koinè linguistica e manifatturiera italiana avrebbe potuto gettare le basi per un’identità socio-giuridica comune fra le popolazioni italiane. Ma questa idea è fallita ancor prima dell’unità, allorché si volle far combaciare la nazione con la nuova borghesia intrallazzistica toscopadana. Quindi il problema storiografico e politico non sta nel ripetere fino alla noia che, nel 1860, tra Sud e Nord esisteva una diversità - e anche forte - ma nello spiegare perché il nuovo Stato, che pur aveva voluto Roma come capitale, non la superò, e invece di amalgamare i vari aggregati economico-sociali, fondò contemporaneamente un paese proiettato verso il nuovo e la sua colonia pagante. 3.2 Gli studi intorno alla cosiddetta questione meridionale hanno messo a fuoco gli atti politici e i processi economici e culturali attraverso cui il Sud, abulicamente annessosi allo Stato sabaudo, viene quotidianamente rapinato d’ogni risorsa. Certamente l’ISTAT avrebbe il dovere di contabilizzare e di rendere pubblica la consistenza dei flussi di ricchezza monetaria e reale che annualmente si spostano dal Sud per raggiungere il Nord, ma patriotticamente se ne scorda. Questi flussi sono una costante della vita nazionale italiana. Soltanto attraverso questo ininterrotto apporto di risorse, al netto d’ogni costo, l’area padana riesce a non perdere altra distanza nei confronti dell’Europa continentale. La perde invece sempre di più il Sud. Infatti la tangente unitaria configura un caso eclatante di colonizzazione dall’interno; in sostanza un aspetto specifico della formazione sociale Italia. Né l’Istat né la Banca d’Italia hanno mai granché amato la contabilità regionale, tuttavia anche con i dati disponibili è possibile ricostruire alcuni aspetti del secolare fenomeno. Il limite tra l’operare dei meccanismi di mercato e la sopraffazione politica non sempre è dissimulato dal generalismo della vita nazionale. Affrontare, però l’intera problematica dell’ilotismo meridionale in Italia è cosa superiore alle mie forze. Qui, a futura memoria, ricordo alcuni dei titoli dell’incredibile repertorio. 1) Il dualismo erariale; il solo tema svolto in modo esaustivo per merito di Francesco Saverio Nitti (opere cit). 2) Lo sbilanciamento nel prodotto interno regionale tra un’area che esportava merci e uomini, e un’area che ne incassava il ricavo valutario. 3) Il costo dell’industria padana, inefficiente, parassitaria, sfacciatamente e masochisticamente protetta dallo Stato, il quale venne sopportato da un’area esclusa dai benefici cumulativi dell’investimento capitalistico e del salario operaio. 4) L’addebito, a carico di un’area povera, di tutti i costi vitali per la formazione di un esercito industriale di riserva di sette milioni di persone, in connessione con il miracolo economico italiano; una perdita secca a tutti gli effetti (quindi assai diversa dall’emigrazione transoceanica dell’epoca precedente), in quanto i salari erogati furono interamente reincassati da chi li pagava; tema sviluppato da Paolo Cinanni (cit.) 5) La super rendita urbana degli affittacamere, in connessione con il dualismo della spesa statale per le università e gli altri servizi; una cifra enorme, anche se non facile da contabilizzare, tale comunque che si può ben dire incida pesantemente sulla condizione delle famiglie meridionali. 6) La buffonata dell’intervento speciale, che ha sconvolto alla radice l’assetto produttivo meridionale ad esclusivo beneficio della produzione padana di cemento e tondino di ferro. 7) La buffonata del protezionismo agricolo comunitario, sfacciatamente dualistico e purtroppo voluto dalla Fiat e dagli stessi governi italiani. 8) Il drenaggio delle risorse meridionali è stato beffardamente annebbiato con l’esibizione della (brillantissima per i furbi) ideologia liberista, secondo cui sarebbero stati i meccanismi di mercato – cioè gli svolgimenti naturali (e positivi) dell’agire umano – a portare l’armonia economica nell’area toscopadana e il disastro sociale al Sud. Purtroppo per i liberali, la forma danaro assunta dal flusso nell’ultimo ventennio ha reso visibile il drenaggio. A partire dagli anni ottanta, persino la Banca d’Italia – la più toscopadana ed equivoca delle istituzioni nazionali - è stata costretta ad ammetterlo. Dopo un secolo e più di razzie condotte in modo ovattato, l’ingordigia caratteristica dei padani ha fatto uscire allo scoperto il fosco sistema bancario nazionale, che non ha avuto (e non ha) scrupoli a incettare famelicamente i soldi della mafia. 3.3 In contrasto con la moda che attualmente ha più successo, il Medioevo va considerato una fase regressiva dell’antropologia economica e sociale. L’età di mezzo è contraddistinta da una produzione calante e da una riproduzione meno che stazionaria. Solo intorno al 1100 d. C. i barbari europei riescono a realizzare un qualche plus-prodotto e a liberare una minima percentuale di produttori dalla servitù della terra. La rinascita della vita urbana si deve a questi evasi. Dalla Sicilia araba e dal Sud bizantino l’antica tecnologia risale la Penisola. La disponibilità di un plus–prodotto alimentare e di manufatti artigianali riavvia gli scambi e l’esigenza di una moneta agile e sicura. La storia monetaria aderisce al tracciato negoziale. Di conseguenza, le ragioni della transizione monetaria dall’oro alla moneta cartacea si trovano nell’evoluzione della manifattura e della mercatura. Ciò in una doppia direzione: in alcuni luoghi il progresso dell’economia monetaria viene dopo lo sviluppo della produzione, in altri luoghi l’anticipa, essendo più facile per il potere imitare altri paesi nel campo monetario che nel campo delle tecnologie produttive. L’economia precapitalistica era lenta, condizionata dalla stazionarietà del valore prodotto e riprodotto. Un innalzamento della mortalità, una pestilenza, il passaggio di un invasore potevano abbattersi sull’agricoltura e generare una crisi alimentare. Nella fase in cui le sussistenze crescono poco e la produzione di manufatti è esigua, la moneta metallica rimane l’unico mezzo di scambio. L’universalità dell’oro agevola gli scambi fra i mercanti di regioni e paesi diversi. E’ l’epoca in cui le strutture fisse della produzione sono la terra e la professionalità dell’artigiano. Soltanto l’armatore navale e l’usuraio impiegano ciò che chiamiamo capitale, e pertanto corrono visibili rischi d’impresa. Anche allora poteva capitare che le cose andassero male all’artigiano, al contadino, al padrone di bottega. Ma essendo il mestiere il vero capitale, responsabili degli eventuali guai erano soltanto degli eventi non mercantili. La marcia verso la modernità è dapprima lenta, poi sempre più veloce. Se noi guardiamo all’indietro, il complesso meccanismo sociale, giuridico, morale, economico dell’età capitalistica ci appare nuovo. Si tratta però di un errore prospettico. Infatti, tranne il motore, nell’età greco-romana esisteva già tutto. Durante la lunga fase in cui l’Europa si adopera a uscire dalla barbarie, si produce una specie di recupero delle istituzioni romane. L’opera è comune a vari popoli, e senza di ciò sarebbe difficile spiegarsi il perché del fatto che tutti i paesi occidentali sono riusciti a imitare l’industria inglese nel volgere di appena un secolo, o poco più. In effetti, non appena la macchina a vapore viene introdotta nella produzione, avviando l’industria moderna, ogni rotella della razionalità sociale recuperata aderisce al nuovo corso. L’inserimento di nuove rotelle, con cui il meccanismo economico e sociale si aggiorna, avviene meccanicamente, per incastro. Chi ha anche una minima confidenza con il diritto privato sa che i rapporti giuridici vigenti in tutto l’Occidente (proprietà, successioni, contratti, ecc.) risalgono al diritto romano. Neanche la celebrata concorrenza è una rotella nuova, anzi è così vecchia da essere stata esaltata nientedimeno che dal poeta Esiodo, nell’VIII secolo prima di Cristo. Con la nascita delle merci di massa essa, essa, però, cambia aspetto. Prima era soltanto la Contesa, la Discordia fra individui ambiziosi di successo; nell’età delle macchine si fa strutturale, diventa il fattore demoniaco di una permanente spinta verso quelle tecnologie o quelle forme di organizzazione del lavoro in fabbrica che abbassano il costo di produzione e quindi il prezzo. A livello internazionale, la concorrenza, che premia le collettività più competitive e spartanamente emargina le meno valide, è divenuta la pietra filosofale del benessere sociale, del liberismo e liberalismo, e in buona sostanza l’unica regola (antigroziana) della politica internazionale. Sul finire del settecento, a meccanismo già rodato, gli economisti si assunsero il compito di offrire una sintassi del funzionamento del mercato concorrenziale. Nella fase cavouriana del risorgimento la più apprezzata appartiene a David Ricardo, un uomo d’affari ed economista inglese vissuto circa trenta anni prima (1772 - 1823). La più ascoltata delle sue lezioni riguarda la concorrenza mondiale, la condanna dei vincoli che le varie aziendenazioni, a cominciare dall’Inghilterra, frapponevano alla circolazione internazionale delle merci. Ricardo è il paladino, autorevole e ascoltato, del liberismo commerciale e del libero mercato; una nuova visione, questa, dei rapporti fra aziende-nazioni, che serviva agli industriali inglesi affinché le loro merci potessero penetrare sulle piazze estere e serviva ai paesi agricoli che volevano vendere le loro derrate ai paesi ricchi. Con o senza l’aiuto a capire se stessa, offerto dalla teoria economica, dopo la scoperta della macchina a vapore la Gran Bretagna diventa l’officina del mondo. Da principio le altre potenze non si mostrarono preoccupate, ma quando la produzione inglese di acciaio - con cui, fra l’altro, si fabbricano i fucili e i cannoni - raggiunse e superò i tre milioni di tonnellate annue, si spaventarono seriamente. La Francia, il Belgio, l’Olanda, la Svizzera, la Prussia, l’Austria, gli Stati Uniti d’America, alcuni Stati italiani si misero sulla strada dell’inseguimento. Un apparato commerciale e marittimo l’avevano già, un ceto di finanzieri e di possessori di danaro anche. I governi si dettero a spianare la strada agli innovatori, in modo che si spingessero avanti e che spingessero altri a trasformare gli impianti, a ingrandire le fabbriche, ad avviarne di nuove. La sintassi voleva che l'aiuto governativo si conformasse al celebre laisser-faire, con cui - si affermava – l’azione dei privati, finalmente libera da ostacoli politici e amministrativi, avrebbe cambiato il mondo. In effetti il liberismo era ed è tuttora il cavallo di Troia con cui la borghesia degli affari penetra nelle cittadelle politiche. Una volta ottenuto il potere e costretta la povera gente a finanziarla, passa all’azione, rivoluzionando selvaggiamente il mondo e ciascuna sua parte, senza badare alla messe di cadaveri fisici e sociali che si lascia dietro. A livello internazionale il liberismo fa ancora peggio. Le grandi potenze militari, quelle stesse che proclamano la sintassi liberista, si guardano bene dal rispettare le regole. Le quali però vengono imposte agli Stati militarmente deboli. In effetti il sistema industriale ottocentesco è appannaggio delle sole potenze militari, le quali possono non rispettare la sintassi. Le procedure che portano al decollo industriale sono diverse da luogo a luogo. Mentre la Gran Bretagna arriva all’industria partendo dalla scoperta del telaio meccanico e della macchina a vapore, cioè dal basso, la Francia, il Belgio e in appresso tutti gli altri paesi che, uno dopo l’altro, vi approdano, partono dalla testa. La procedura è nuova. In passato un’area economica copiava da un’altra un processo produttivo più moderno o una tecnologia ignorata a lungo, a volte, per millenni (l’allevamento del baco da seta, la vela triangolare, ad esempio). Ma avviata la produzione industriale, la pratica di una sana e lenta assimilazione si rivela perdente. La nazione che resta indietro diviene automaticamente lo sbocco industriale di una grande potenza, con il risultato che è costretta ad assistere impotente al sottosviluppo della propria economia. Nel giro di quarant’anni la grande potenza rivale dell’Inghilterra diviene la Francia. Il governo e la classe dirigente parigina non potevano restare insensibili di fronte allo scavalcamento anglosassone e alle insidie connesse. La differenza tra Gran Bretagna, da una parte, Francia e gli altri paesi inseguitori dall’altra, si estendeva anche alla formazione del capitale d’investimento. Mentre nelle Isole Britanniche esso si era formato nel corso del tempo, attraverso la crescita delle esportazioni e con l’imperialismo militare ed economico, altrove fu necessario ottenerlo preventivamente. Tale esigenza peserà notevolmente sulla storia dell’Italia-una. 3.4 Nell’italiano tardomedievale, allorché rinasce la funzione bancaria, il termine è maschile, il banco. Così a Venezia, che ne pretende la paternità, così a Genova che gliela contende, così a Firenze, che l’ammodernerà. Il banco è il tavolo del cambiavalute in regime di moneta metallica. Nell’Italia comunale e signorile, ogni autorità che potesse permetterselo aveva una sua zecca e imponeva suoi particolari coni. Ogni signoria batteva una moneta di diverso valore intrinseco. L’operazione di cambiare le monete forestiere, richiesta dall’incontro del mercante forestiero con il produttore locale, dovette fruttare più al banchiere onesto che al meno onesto. Così ai più corretti, la gente prese a prestare i suoi risparmi perché li impiegasse. Nel diritto romano il termine tecnico del contratto di prestito è mutuus, mentre usus nel linguaggio quotidiano è il trafficare del mercante. Per estensione usura fu il termine corrente del prestito di danaro per un interesse. Il Rinascimento, prima che un fenomeno artistico, fu un rivolgimento economico che ebbe alla sua base la produzione e l’esportazione di panni, specialmente di lana, e di altri manufatti. Secondo Marx siamo già al capitalismo, e fra i capitalisti dell’epoca sale ben presto al primo posto il banchiere. Tutti sappiamo dei Bardi, de’Medici, dei Peruzzi, i quali impiegano strumenti finanziari mai più tramontati, anche se a volte hanno mutato nome. La lettera di cambio è sicuramente il più antico. Un esempio può farne immaginare la funzione ai non addetti ai lavori. Nella bottega di mastro Giacinto, sorrentino, le scorte di mandorle sono esaurite, allo stesso tempo la domanda è parecchio sostenuta. Il mastro s’imbarca su una tartana diretta in Sicilia e raggiunge Siracusa. Non volendo correre il rischio di portare per mare una somma cospicua, ha versato a un banchiere della sua città cento ducati, e questi gli ha dato una lettera di cambio in tarì, che il suo corrispondente siracusano paga a vista. Il banchiere segna il credito nel suo libro, in attesa che gli capiti l’occasione di ordinare al banchiere corrispondente di pagare un certo numero di ducati a un Tizio che si reca a Sorrento. Con la lettera di cambio, il banchiere non solo rende più sicura (o meno insicura) la circolazione del danaro, ma raddoppia la moneta che gli è stata affidata. Infatti dietro la carta ci sono cento ducati tanto a Sorrento quanto a Siracusa. Ma, mentre il danaro che viene sborsato a Siracusa passa presto nelle tasche di un produttore di mandorle, quello rimasto a Sorrento sta fermo. Ora, il danaro da fermo non produce, anzi è un costo; quantomeno il costo di tenere aperto il banco. Questo costo, tuttavia, è presto compensato. Da persona esperta delle cose del mondo il banchiere sorrentino sa che ci vorranno una quindicina di giorni prima che il cliente arrivi a Siracusa e dell’altro tempo ancora prima che da Siracusa arrivi a Sorrento un ordine di pagamento tratto dal suo collega e corrispondente. In questo lasso di tempo i danari di Mastro Giacinto sono nella sua disponibilità. Il nostro banchiere li presta a Messer Catello. Con questo atto il banchiere ha raddoppiato i cento ducati. Ora sono sicuramente duecento: cento li ha in mano mastro Giacinto e cento li ha in mano messer Catello. Anche i crediti sono raddoppiati: cento li accredita il banchiere siracusano dal banchiere sorrentino e cento questi da messer Catello. In nessun caso è più calzante il detto: "prendere due piccioni con una sola fava". Certo il fuoco d’artificio brilla solo per qualche settimana, ma la clientela del banchiere non si restringe a due sole persone. Di clienti, solo lui ne avrà centinaia. Se poi mettiamo nel conto anche i suoi colleghi, è chiaro che la moltiplicazione dei pani e dei pesci assume dimensioni notevoli. Logicamente ci sono dei pericoli. Potrebbe accadere che messer Catello non restituisca i danari presi in prestito; può capitare che il banchiere sorrentino non paghi la tratta, nel qual caso a rimetterceli sarà il suo collega siracusano. Ma questi sono accidenti. La regola generale è che il debitore paga. Pagano, quasi sempre, anche il Re Cattolico e il Re Cristianissimo, che pure sono dotati di sovrane facce toste. Mentre gli economisti l’hanno scoperto soltanto nel secolo XX, i banchieri, da tremila anni, sanno che il denaro depositato presso di loro diventa il doppio di sé stesso. Infatti ce l’ha sempre il suo proprietario, ma c’è l’ha anche il banchiere. Il legame tra mercatura e istituzioni creditizie viene rafforzato dalla diffusione delle cambiale. Il lettore informato dovrà perdonarmi questo fare da maestrina con la penna rossa sul cappello, ma sarebbe una mia grande ambizione quella di spiegarmi perbenino. Nell’uso corrente chiamiamo cambiale quel foglietto bollato con cui, fino a non molti anni fa, compravamo a rate l’automobile e il frigorifero. Anche questa è una cambiale, per la precisione un pagherò cambiario, ma la sua entrata nell’uso è posteriore alla cambiale in senso proprio (oggi solitamente chiamata cambiale tratta o più succintamente tratta), che è l’ordine indirizzato a persona determinata di pagare la somma iscritta. Ovviamente, dietro la tratta esiste un rapporto sostanziale. In pratica la cambiale è un perfezionamento della lettera di cambio, che viene resa più essenziale, in modo che possa passare da una mano all’altra senza che si tenga conto della causa che ne ha originato l’emissione e origina le successive girate. Tratta viene dal latino traere, che in questo caso significa trasmettere, consegnare, affidare. Insomma lo stesso atto che rende operativa la lettera di cambio. Negli affari, il medium cartolare ha del magico. Ben presto la cambiale, in entrambe le versioni, più che ad asseverare un credito, serve a dilazionare il pagamento di una fattura. L’elemento che conferisce alla cambiale e al pagherò cambiario un carattere mercantile è la girata. Il prenditore cambiario può ordinare che la cambiale venga pagata a una terza persona; a sua volta, questa può indicare una quarta; e così via, teoricamente senza alcun limite. Nuovo ricorso a un esempio a favore dei non informati. Poniamo che un privato a nome Gennaro compri delle stoffe, con cui fare il corredo a sua figlia, presso il mercante Ciro. In pagamento gli dà un pagherò cambiario di cento ducati a tre mesi. Ciro, volendo utilizzare la somma inscritta nella cambiale, la porta allo sconto da messer Catello, il quale l’accetta e gli presta 100 ducati. A sua volta il banchiere cede la cambiale (assieme a un pacchetto di altre cambiali) a un secondo banchiere, più importante di lui, onde avere l’importo in contanti (meno gli interessi). Il secondo banchiere può ancora riscontarla, e così un terzo e un quarto. Oggi è cosa assolutamente normale che una banca popolare risconti i titoli in portafoglio presso una banca nazionale e che questa li risconti ulteriormente presso la banca centrale. E può accadere anche che la banca centrale risconti i titoli in suo possesso presso la banca centrale di una nazione più ricca. Il tipo di banca fin qui esemplificato è l’antenata della classica banca di deposito e di sconto, nata e affinatasi nel corso del Rinascimento, la stessa presso cui oggi andiamo a lasciare in deposito i nostri risparmi o a contrarre un prestito. Tra Settecento e Ottocento la cambiale tratta si diffuse nel Regno Unito, e poi dovunque. La cambiale tratta, sinteticamente detta tratta, divenne uno strumento creditizio molto usato dalle grosse aziende che avevano una clientela di aziende minori, alle quali concedevano una dilazione di pagamento. Esempio: il pastificio Bella Napoli, di Torre Annunziata, spedisce 100 quintali di pasta alla ditta Antonio Prospero di Simeri di Calabria, sua cliente, alla quale ha concesso 30 giorni data fattura .per pagare. Si sa in partenza che né il titolare del pastificio farà un viaggio in Calabria per riscuotere, e che neppure il signor Prospero ha tempo e voglia d’andare a Torre a pagare. Molto praticamente, insieme alla fattura, il ragioniere del pastificio compila una tratta pari all’ammontare della fattura, la fa sottoscrivere al titolare dell’azienda e la porta in banca, magari insieme ad altre tratte, relative ad altre forniture. Qui, o dà un mandato per l’incasso - che la banca provvederà a fare attraverso il suo sportello di Simeri, e mancando questo, attraverso lo sportello di un’altra banca; ovvero versa la tratta per lo sconto, il cui controvalore verrà accreditato dalla banca sul conto corrente del pastificio. 3.5 La moneta che noi adoperiamo è un foglietto di carta emesso dalla banca centrale di ciascuno Stato. Questo biglietto ha un valore intrinseco praticamente nullo, tuttavia rappresenta un efficiente mezzo di scambio. Sentirci ricchi, se nei nostri conti bancari e se nelle nostre carte di credito disponiamo di un importante ammontare di questa carta, oggi è la cosa più normale del mondo. Ma appena un secolo e mezzo fa le cose stavano diversamente: la moneta aveva un valore intrinseco, corrispondente al valore dell’oro o dell’argento con cui era coniata, mentre le banconote erano accettate dal pubblico solo se pienamente convertibili in oro o argento. Il fenomeno che noi indichiamo con la parola inflazione, alla sua origine, altro non fu che la disuguaglianza di capacità d’acquisto tra un dollaro coniato e una banconota da un dollaro. Siamo intorno al 1860, al tempo della Guerra di Secessione americana. Il cambiamento, quindi, è stato piuttosto recente. Anzi, fino al 1944, negli Stati occidentali tutte le banconote erano teoricamente convertibili in oro, anche se poi praticamente l’oro veniva impiegato soltanto nelle transazioni internazionali, e sempre che la compensazione tra il dare e l’avere reciproco delle nazioni non avvenisse nella valuta di uno Stato terzo, accettata dal creditore; per esempio in sterline o in dollari. Finita la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti d’America, che avevano risucchiato le riserve auree delle altre potenze mondiali, sono divenuti la banca centrale del mondo. Da quel momento, nei loro reciproci rapporti, gli Stati non hanno usato più l’oro, ma il dollaro. Si era convenuto fra i vincitori del conflitto che ci fosse una parità fissa tra il dollaro e l’oro (un’oncia d’oro per 35 dollari), ma la conversione rimase un fatto teorico, in quanto, né il comune cittadino, né gli Stati videro più l’oro rinchiuso nei sotterranei di Fort Nox. Poi, nel 1972, anche la teorica convertibilità del dollaro ebbe fine. Ma pare che l’economia mondiale non ne soffra. L’idea di una circolazione aurea è scomparsa dalla testa degli uomini. Ogni nazione ha un sistema monetario cartaceo, la cui efficienza non dipende più dalla consistenza della riserva aurea, ma essenzialmente da due o tre cose, come l’indebitamento dello Stato verso i cittadini, la sua bilancia internazionale e, relativamente agli USA, il numero delle portaerei. Per non lasciare l’informazione a metà, è doveroso aggiungere che la moneta cartacea è un fatto democratico, in quanto raggiunge i ricchi e i poveri, mentre la moneta in metalli nobili non lo era affatto. Difatti, il metallo prezioso, in special modo l’oro, racchiude un grande valore in poco peso. Intorno al 1700, una sola sterlina comprava parecchi quintali di grano, ma a quella data il povero raramente aveva tanto da poter consumare due quintali di grano in tutto un anno. La gente nasceva e moriva senza aver mai preso in mano o nascosto sotto il mattone un pezzo d’oro. Chi ricorda le avventure di Pinocchio ha un’idea abbastanza chiara di quale tredici al Totocalcio fosse per un poveraccio il regalo di cinque zecchini d’oro. Per questo motivo l’unità monetaria si suddivideva in monete divisionarie (i nostri spiccioli) coniate in rame o in bronzo. Nel caso napoletano il ducato (unità monetaria non coniata) si divideva in dieci carlini, un carlino in dieci grana, una grana in dieci cavalli o calli (per cui è un’autentica fandonia quella che si trova scritta in molti libri, secondo cui il sistema monetario napoletano non era decimale). Dovunque si avevano due circolazioni contigue e raramente intercambiabili, in quanto l’oro (o l’argento) aveva corso legale, mentre lo spezzato rimase per lunghi secoli inconvertibile. Tra il XVII sec. e la fine del XIX gli Stati emisero fior di decreti per rendere obbligatoria, sia pure in limiti ristretti, l’accettazione delle monetine come mezzo di pagamento (nell’Italia del 1870, fino a 20 lire). Ma anche oggi è chiaro che chi accreditava quattro ducati pretendeva dal debitore un bel pezzo d’argento e non certamente 40 pezzi di rame. I Borbone, sempre accorti e saggi, dettero un taglio al problema coniando in argento la moneta da dieci carlini, come dire l’unità monetaria (il ducato) realizzata con la moneta divisionale per la comodità del popolo basso. 3.6 Per la storia della moneta cartacea l’esperienza inglese rappresenta la genesi. Quando, nel 1769, Watt fece funzionare la prima macchina a vapore, in Gran Bretagna la cartamoneta era già nota, anche se veniva impiegata in circuiti delimitati: sicuramente dai grossi mercanti di Londra, ma anche a livello locale, nelle aree di precoce industrializzazione. Oggi si è quasi azzerato il vorticoso giro di cambiali, che faceva dire ai giornalisti italiani essere l’Italia "un paese fondato sulle cambiali". Chi entra in banca non vede più lunghe file di commercianti e privati che attendono il loro turno con l’avviso di una cambiale in mano. In verità chi lamentava il pesante giro di cambiali ignorava che nei secoli trascorsi, prima che venisse fuori e si affermasse nell’uso la banconota, il giro delle cambiali, più che a un vortice, poteva essere paragonato a un tornado. In Gran Bretagna, non venne stimolato soltanto dall’esigenza di dilazionare i pagamenti, ma anche dal fabbisogno di più circolante. D’altra parte gli affari procedevano più speditamente quando i capitalisti riuscivano a superare l’ostacolo del pagamento in contanti. E’ il caso di ribadire che il giro cambiario sposta a un termine successivo (ad quem) il pagamento di una fornitura. Durante una lunga fase, di cui ai ricercatori riesce difficile definire i termini di partenza e d’arrivo, la fiducia reciproca fra gli imprenditori, il credito che l’uno praticava all’altro, fece le veci dell’oro. Il giro di cambiali e di pagherò cambiari era un fenomeno corrente, e non un fatto eccezionale. Ci fu in sostanza il ricorso a un espediente che a noi posteri appare come una anticipazione della banconota. C’è da aggiungere che nel ‘700 aumentò il prezzo dell’argento, il quale veniva impiegato per coniare le monete di minor valore. In un sistema monetario bimetallico, se il rapporto di cambio tra l’oro e l’argento non è tendenzialmente stabile nel tempo, il metallo il cui valore è aumentato finisce estromesso dalla circolazione e tesaurizzato. Così avvenne per l’argento. La zecca di Londra smise d’acquistarlo e coniarlo. La carenza delle pezzature argentee, più confacenti alle spese correnti della gente, apportò un gran disagio nei pagamenti Tuttavia l’origine prima del biglietto convertibile non pare sia merito dei banchieri. Gli storici raccontano che già nel secolo XVII i gioiellieri londinesi, volendo andare incontro ai loro clienti, che avevano il problema del peso delle monete nonché quello del furto delle loro borse, cominciarono a frazionare in biglietti di taglio fisso i certificati di deposito dei metalli preziosi loro affidati. Questi biglietti, vergati a mano, presero a passare dalle tasche di un ricco a quelle d’un altro ricco, al posto del metallo di cui rappresentavano il valore. Osservata la cosa, i banchieri, che già impiegavano le loro cambiali nominative come se fossero moneta circolante, copiarono i gioiellieri, fornendo ai clienti (depositanti e mutuatari) carta di taglio fisso, pagabile al portatore. Date queste informazioni, bisogna chiarire che la banca di emissione è tutt’altra cosa. Emette carta non per comodità di un pubblico di possessori di oro e/o argento. Insomma non la emette al posto dell’oro che ha chiuso negli scrigni, ma crea moneta inventandone il valore. Al tempo dei Fenici, una moneta priva di valore intrinseco poteva essere oggettivata su una tavoletta d’argilla, al tempo di "Dio salvi il re" l’oggetto più comodo era la carta, la quale venne impiegata con grande dovizia, in quanto il dare carta per prendere oro allettava qualunque banchiere, persino gli azzimati abitatori di Lombard Street. Ovviamente il passaggio dall’oro alla carta non si realizzò in un giorno. Occorsero secoli perché la carta scacciasse definitivamente l’oro. La creazione della banconota ha corrisposto a un’esigenza sociale di vasta portata, consistente nel superamento dei metalli, la cui limitata disponibilità fisica bloccava l’operare dello Stato e della società civile, che andava crescendo. Per fermarci al paese dominante, "tra l’inizio e la metà del diciottesimo secolo il volume complessivo del commercio estero inglese (importazioni, esportazioni e riesportazioni) approssimativamente raddoppiò. A metà degli anni 1780 esso era maggiore di quasi il 50 per cento che nel 1750, e nei successivi quindici anni raddoppiò di nuovo. A metà del 1840 si era più che triplicato rispetto all’inizio del diaciannovesimo secolo. Tale rapida crescita fu intimamente connessa tanto con lo sviluppo del sistema finanziario quanto con il progresso dell’industrializzazione" (Cameron, 28). 3.7 Come già annotato, la moneta aurea e quella argentea avevano un valore - la prima parecchio, la seconda alquanto – che stava al di sopra del guadagno giornaliero della povera gente, la quale, perciò, impiegava soltanto, o prevalentemente, la moneta divisionaria. Essendo notevole l’avarizia del governo britannico, e quindi scarsa la circolazione di moneta divisionaria, nelle regioni minerarie e di precoce industrializzazione, industriali, proprietari di miniere e mercanti furono indotti a mettere in circolazione dei biglietti privati aventi un giro locale, che la gente accettava in base al fatto che il ricco ispira fiducia. Il banchiere, che operava accanto all’imprenditore, prestandogli soldi a interesse, si rese conto che il giro fiduciario gli consentiva di dare in prestito il suo buon nome, incorporandolo in biglietti al portatore. A Londra e nelle province inglesi e scozzesi le banche d’emissione fiorirono a centinaia. La moneta fiduciaria crebbe allo stesso ritmo del commercio, e forse di più. Inoltre, nella fase storica caratterizzata dalla fabbrica proto-industriale, il valore del capitale e il monte salari si dilatarono. Fisicamente non ci sarebbe stato oro a sufficienza per lo svolgimento degli affari. Se non si fosse trovata una via d’uscita presto si sarebbe profilata all’orizzonte una rivalutazione della moneta aurea, e di rimbalzo una caduta generalizzata dei prezzi delle merci,. In effetti, il sistema di fabbrica impose ai primi capitalisti l’adozione (o meglio, l’ invenzione) della moneta non metallica. Fuori dal Regno Unito la storia della banconota (prima convertibile e poi inconvertibile) ha uno svolgimento assolutamente diverso. Essa non nasce tanto da un’esigenza dei produttori quanto dal drenaggio statale dei metalli preziosi. In quasi tutti i paesi, e specialmente nell’Italia una e indivisibile, fu la speculazione sul debito pubblico a fare da paraninfo tra la speculazione e i ministri del tesoro. In Italia, anzi, fu la stessa filosofia politica della Destra storica a promuovere e ad avallare l’opera degli speculatori, nefasta allo sviluppo economico e all’unità nazionale. Nei paesi non ancora industrializzati si credette che la crescita del ceto dei banchieri potesse far crescere la produzione. La moneta fiduciaria li avrebbe collocati al centro delle attività commerciali, come si legge nel celebrato passaggio di un discorso pronunziato da Pellegrino Rossi, intorno al 1845, al senato francese. "I vantaggi di questa circolazione [fiduciaria] sono più notevoli di quelli che risultano dall’emissione di biglietti garantiti dal deposito di valori metallici equivalenti. I produttori possono realizzare immediatamente il valore dei loro prodotti e ricominciare senza indugio una nuova produzione. Aiutati dal credito della banca [d’emissione] essi fanno un nuovo e pronto impiego dei loro capitali, moltiplicano i loro profitti e accrescono più rapidamente la ricchezza nazionale. Non vi è in tutto ciò né prodigio né mistero. Emettendo i biglietti la banca ha reso un servizio, ma niente ha aggiunto al capitale materiale; un biglietto non è che un pezzo di carta; una promessa non è una cosa; lo strumento della produzione non è affatto accresciuto. Che cosa è dunque avvenuto? Un solo fatto: a un debitore poco conosciuto s’è sostituito un debitore che tutti conoscono e che tutti accettano. E’ tutto qui il vantaggio" (Enciclopedia Treccani, alla voce Banca d’emissione ) 3.8 I banchieri avevano utilizzato il danaro altrui per il proprio profitto molto prima che la cartamoneta entrasse nell'uso corrente. Il passaggio dalla banca di deposito e prestito alla banca che emette carta fiduciaria, garantendola con una modesta riserva, o senza alcuna riserva, si svolse in cinque secoli. Tuttavia il processo di conversione (meglio, di sostituzione) fu punteggiato da errori e insuccessi costosi. Il momento di svolta si ebbe con le guerre napoleoniche e il Blocco Continentale. La Gran Bretagna dovette finanziare i suoi alleati con oro sonante, in Francia le difficoltà delle finanze statali erano già secolari. La prima fu costretta ad adottare il corso forzoso, la seconda a tentare di mettere qualche ordine al caos monetario in cui versava. La banca unica d’emissione fu indubbiamente una soluzione capitalisticamente valida, in quanto il potere monetario venne consegnato nelle mani dei grandi possessori di danaro, e questi, prima d’impegnarsi ad assorbire, e a far assorbire dalla nazione, il debito pubblico, ne contrattavano l’entità e i termini. La pluralità delle banche d’emissione non venne superata ufficialmente, ma in entrambi i paesi si passò a una forma di dittatura bancaria e a un solo tipo di banconota, fittiziamente ancora privata, in sostanza un biglietto di Stato. Finito il conflitto, si tornò alla convertibilità, che fu rigorosamente pretesa dalla legge, non osando gli Stati procedere al saccheggio dell’oro prima che la gente benestante avesse preso fiducia nella carta. Infatti, in un assetto a circolazione aurea, l’adozione del corso forzoso dei biglietti configurava una tacita imposta sui patrimoni liquidi dei nobili terrieri e della borghesia provinciale. Anche nel caso della convertibilità dei biglietti, una qualche tosatura il risparmiatore la subiva. Solo i mercanti vedevano positivamente la banca d’emissione, perché la rarefazione dell’oro avrebbe provocato la caduta dei prezzi e un loro conseguente danno (vero o presunto). Più in generale, il problema che lo Stato si pone all’inizio è quello di mobilizzare la moneta metallica nascosta sotto il mattone. L’oro e l’argento gli servono a livello internazionale. Per le banche l’istanza è diversa. Il biglietto serve loro per fare credito senza doversi procurare i costosi metalli. Più in generale, nei paesi che inseguivano la Gran Bretagna sulla via dell’industrializzazione era vitale rastrellare l’oro in circolazione, piegando la gente a una moneta senza valore, se si voleva acquistare in Gran Bretagna macchine e impianti. Nella prima fase della riorganizzazione capitalistica, tranne che in alcuni paesi, l’emissione di carta convertibile a vista fu lasciata alle banche private, in buona sostanza agli speculatori. Nella fase di convertibilità dei biglietti bancari e prima che fosse instaurata la dittatura della banca centrale, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America a emettere cartamoneta furono miriadi di banche. La saggezza e la grande accortezza della Banca d’Inghilterra evitarono guai al paese. Invece negli USA si scatenò il caos. Fu, quella, una lezione per tutti gli altri paesi. Gli Stati s’irrigidirono. L’opinione pubblica rimase all’erta. Solamente in Italia avvenne il contrario. Il sacco avvenne alla luce del sole. Non ci fu bisogno di far ricorso all’ipocrisia e alle cortine fumogene. Bastò il patriottismo a favore dello Stato appena unificato a giustificare ogni nefandezza: le speculazioni sui metalli, sui titoli, sulle emissioni, sui buoni del tesoro, la guerra di perfidie della Banca sabauda contro il Banco di Napoli. La riorganizzazione dei vari sistemi nazionali avvenne sulla base delle esperienze inglese e francese durante le guerre napoleoniche. A emettere i biglietti e a negoziare i titoli del debito pubblico venne deputata una banca centrale, presso cui le banche commerciali dovevano attingere il circolante cartaceo. Ad essa venne demandato il compito d’ emettere i biglietti necessari alla circolazione corrente, di fornirli al tesoro statale e alle banche commerciali; di controllare queste ultime e tutte le altre istituzioni creditizie; di predisporre il collocamento del debito pubblico. Nella mitologia che le classi dirigenti propalarono, le banche centrali sono i santuari della moneta (che sarebbe di tutti). In realtà si tratta di enti giuridicamente fumosi, che non sono privati e neppure pubblici, i quali vengono governati da una specie di loggia segreta delle classi ricche e solo occasionalmente condizionate dallo Stato, ma sempre in grado di condizionare lo Stato. 3.9 Il re assoluto considerava la nazione una cosa di sua proprietà. Quando gli servivano dei soldi, se li faceva prestare da un banchiere (di solito toscopadano), a cui concedeva una garanzia reale, tipo un feudo o il gettito di un’imposta (di solito nel Regno di Napoli). Con la crescita della classe borghese e della sua ricchezza, i re ebbero la possibilità d’indebitarsi con i propri sudditi. Il debito pubblico nacque nel corso della transizione dallo Stato del dinasta allo Stato patrimoniale – amministrativo, con il carattere che tuttora conserva, quella di un prelievo più o meno volontario, rimborsabile negli anni o nei decenni. Il concetto è noto a chiunque segua i notiziari televisivi: lo Stato incassa una somma dai cittadini e la impiega. A pagare saranno le future generazioni. L’immagine della banca centrale come di un’istituzione creata in funzione dell’ordinato svolgimento degli affari privati è solo propaganda delle classi dominanti. A ciò si arriverà solo in appresso, con la crescita economica delle classi subalterne, il cui reddito bilancerà, a livello di prodotto interno lordo (PIL), il peso delle classi abbienti. Al tempo dello Stato patrimoniale il monte delle entrate pubbliche (in oro) non era tale da sovrastare la ricchezza dei banchieri. Cosicché quando il re aveva bisogno d’oro non aveva altri a chi rivolgersi, se non a loro. Ma in fatto di soldi, se i piccoli re stavano alle regole, i grandi re non disdegnavano le brutte figure. Di conseguenza le risorse dei banchieri si assottigliavano. Per non esporsi troppo, essi decisero di spartire il rischio e i profitti con la classe dei minori redditieri e con la provincia tesaurizzatrice. Nasce il debito pubblico, che è una raccolta di ricchezza monetaria presso la borghesia nazionale. Lo Stato scarica i titoli del debito pubblico nelle casse della banca centrale e/o delle banche private, concedendo loro un forte sconto sul prezzo d’emissione. Anche in questo caso l’Inghilterra fece da battistrada alle altre nazioni. Londra grondava oro. I corsari regi avevano saccheggiato decine e decine di galeoni spagnoli carichi di metalli preziosi, i mercanti e gli armatori realizzavano grossi profitti con il commercio coloniale dello zucchero, del tè, del tabacco, del caffè, con l’esportazione di manufatti, con i noli e le assicurazioni navali. Nei loro riguardi la funzione bellica dello Stato era pagante. Bisognava aiutarlo. D’altra parte, anche l’aiuto poteva trasformarsi in un buon affare. Nacque così nel 1679, sotto la forma di società anonima, la Banca d’Inghilterra, la cui attività, se fu notevole nel campo del commercio e delle conquiste coloniali, ancor più elevata e proficua fu nel campo dei prestiti pubblici. In teoria la Banca d’Inghilterra era come le altre banche, in pratica era la mediatrice dei capitalisti londinesi presso il governo di Sua Maestà Britannica, a cui prestava tutto l’oro che la detta maestà e il suo governo richiedevano e che regolarmente essi non restituivano. Era il sottoscrittore a pagare la banca. All’erario statale, nell’immediato, spettava soltanto di procacciarsi i mezzi per pagare gli interessi. L’importo del capitale l’avrebbe restituito con comodo. Lo Stato riversa negli stipi della banca qualche vagone di scatole contenenti le cartelle del debito pubblico. E’ compito della banca collocarle presso il pubblico. Un caso meritevole d’attenzione si ha quando circolano contemporaneamente monete metalliche e banconote fiduciarie. Se lo Stato ottiene oro, la banca lucra soltanto lo sconto convenuto per il cosiddetto servizio. Se invece lo Stato ottiene carta, mentre la banca incassa oro dai sottoscrittori, allora il lucro della banca è pari al valore dell’emissione. E nessuno s’illuda che, nella storia contemporanea, il caso di governi generosi con la banca fosse infrequente. In conclusione, la nascita delle banche centrali d’emissione è legata al fabbisogno dei governi, eternamente avidi d’oro, e non a un preciso bisogno del capitalismo in evoluzione, che storicamente non aveva avvertito il bisogno di fare ricorso a una banca centrale per impiegare disinvoltamente la moneta fiduciaria. Non tutte le banche nazionali hanno la stessa storia. Nei paesi in cui l’oro venne speso all’estero dallo Stato, la banconota divenne presto (ufficialmente o non) inconvertibile. In detti contesti la banca centrale, più che un quieto e metodico regolatore della circolazione cartacea, assume la funzione di un manipolatore della fiducia popolare. Tuttavia sarebbe troppo riduttivo definirla un instrumentum regni. In effetti tra il secolo XVIII e il secolo XIX le emissioni della banca centrale non fecero seguito soltanto ai bisogni regi. Ottenuto il monopolio delle emissioni, di regola le banche centrali seppero fronteggiare il maggior livello quantitativo della produzione, dovunque crescente. In detta fase la funzione statale si andava dilatando fino comprendere relazioni e compiti che erano delle famiglie, delle chiese, dei corpi morali, delle collettività locali. Conseguentemente i consumi pubblici e la spesa pubblica si gonfiavano considerevolmente. Nei paesi ricchi il compito di tenere un giusto equilibrio tra produzione e consumi nazionali diventò la specialità della banca centrale. Gli studi sulla connessione tra credito e sviluppo sono parecchio giovani. "Agli inizi degli anni settanta [a livello mondiale] il settore versava in preoccupanti condizioni di arretratezza relativa…" , osserva Pierluigi Ciocca (cit. pag. IX). Figuriamoci in Italia! Senza dubbio esiste la famosa analisi di Gerschenkron (cit.), relativa al (mezzo) decollo industriale dell’età giolittiana, sostenuta dal credito (secondo lui, in verità dalle rimesse degli emigranti). Ma essa studia il fenomeno a partire dagli ultimi due decenni dell’Ottocento, quando i buoi avevano già cambiato stalla. Da dove cominciare, allora? Una regola interpretativa dell’economia ottocentesca è che la moneta cartacea è nient’altro che credito. La banca di emissione fu senza dubbio una modernizzazione positiva, sia altrove, sia in Italia. Quel che di veramente originale, di artistico, che la storia della nostra banca mostra è la sua grande capacità di essere (ed essere stata) centrale per il paese toscopadano e decentrata per il paese meridionale. I meriti d’italianità sono infiniti, ma nessuno eguaglia quello di aver arricchito il Nord drenando ricchezza che viene (e veniva) risparmiata al Sud. 3.10 La società umana è fatta di produttori che, consapevolmente o inconsapevolmente, pacificamente o non, collaborano fra loro. Nella massima percentuale dei casi, ciò avviene tra produttori che non sanno neppure l’uno l’esistenza dell’altro, nonché tra persone che stanno a decine di migliaia di chilometri di distanza. Nel corso della produzione e dello scambio capita alla collettività dei produttori di realizzare, con atti progressivi, delle autentiche invenzioni, che per il fatto d’essere state fatte inavvertitamente nel tempo, non vengono considerate delle invenzioni, ma un efficiente intervento della mano di Dio nelle cose del mondo. Queste invenzioni collettive modificano continuamente la vita di relazione. La banconota appartiene a questo tipo di invenzioni. Si deve ritenere che, nel secolo XVIII, i produttori britannici siano stati sospinti dalla quantità del prodotto e dalla quantità dei salariati, in entrambi i casi maggiore (relativamente allo spazio statale) che nell’Impero Romano, a creare l’interfaccia cartacea del potere di comandare lavoro prima incorporato nell’oro, la cui quantità in circolazione evidentemente non bastava più. Difatti una miriade di piccoli e medi banchieri e industriali infranse la barriera psicologica della moneta aurea e creò la moneta fiduciaria. Mutatis mutandis, settanta anni dopo la Francia arrivò allo stesso traguardo. Alcuni decenni dopo anche gli altri paesi occidentali ebbero una loro banca centrale. Appena create, le banche nazionali divennero le uniche banche legittimate all’emissione fiduciaria; comunque l’istituzione preposta a controllare l’emissione di cartamoneta. Le banche private di emissione, benché nate prima, dovettero rinunziare a emettere proprie banconote: o si esaurirono o diventarono caudatarie della banca nazionale. In Gran Bretagna e Francia il processo di centralizzazione si realizzò progressivamente. Le centinaia o migliaia di banche minori (e private) furono vinte dalla difficoltà oggettiva di restare presenti su un mercato sempre meno locale o regionale, e sempre più integrato a livello nazionale. In Italia ciò non avvenne. Al contrario, l’assunzione illegittima della Banca Nazionale a banca centrale d’Italia si collegò (uno) al disegno, largamente preunitario, di "fabbricare i fabbricanti", ma soltanto nel futuro Triangolo industriale, e (due) di saccheggiare bancariamente il Sud, dove la borghesia (vedremo in appresso se intelligentemente o stupidamente) si arroccò in difesa e usò come sua banca centrale - sia pure subalterna e coloniale - il Banco di Napoli. Quindi, in Italia, diversamente che in Gran Bretagna e in Francia, la banca centrale (di fatto, ma non di diritto) non fu il prodotto dell’integrazione dei mercati regionali del credito, e neppure il risultato del cedimento di banche regionali più deboli a una banca di raggio nazionale e più forte, ma il risultato di intrallazzi politici noti, anche se si insiste a tenerli il più possibile nascosti, come di regola si fa con ogni intrallazzo. Il collegamento tra l’espansione del capitalismo e la banca d’emissione è stato proposto e analizzato solo di recente. Le analisi pubblicate sono di grande importanza per il mio discorso. L’argomento non è tuttavia l’oggetto precipuo della mia ricerca, la quale riguarda invece il deliberato - e tenacemente perseguito - bifrontismo legislativo italiano, funzionale alla volontà politica di aiutare la formazione di una moderna borghesia toscopadana con i soldi dei meridionali. Non si tratta ancora del capitalismo industriale, ma di affarismo bancario e commerciale (Sereni**, pag. 99 e sgg.). Nell’Italia unita l’industria moderna vedrà la luce dopo, tra il finire dell’Ottocento e i primi sei decenni del Novecento. Come il capitalismo bancario e speculativo, anche il capitalismo industriale nascerà, in Italia, con il danaro degli altri, e precisamente, alla partenza con le rimesse degli emigrati, e nei suoi successivi sviluppi caricando, attraverso un feroce protezionismo, sui consumatori l’inettitudine e l’ingordigia del padronato toscopadano. 3.11 Leggo sui giornali economici dell’autunno 2002 che alcune grandi aziende vinicole toscopadane stanno acquistando delle consorelle siciliane. A partire dagli anni cinquanta, e per un buon trentennio, i toscopdani hanno acquistato le nostre braccia. Adesso si comprano la terra. Spogliati già delle risorse necessarie alla riproduzione ciclica, vola via anche il nostro capitale naturale. Fra non molto ci sfratteranno da casa, e la useranno per le loro meritate vacanze. Il processo d’espropriazione economica è la legge basilare dell’imperialismo. Da noi cominciò a funzionare a unità non ancora proclamata, con l’utilizzazione del nostro argento monetato come riserva per espandere il credito nell’area del quadrilatero Firenze-Genova-Torino-Milano. Due decenni dopo i padani si papparano le rimesse degli emigranti per avviare la grande industria padana. Negli anni venti Mussolini salvò la Banca d’Italia confiscando le riserve del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. L’ultimo miliardo d’oro su cui i signori milanesi non erano riusciti ancora ad allungare le mani passò nelle tasche del senatore Agnelli. Ai giorni nostri sono volati via anche i banchi, garbatamente inghiottiti da qualcuna delle bancarelle baciate in fronte dallo Stellone d’Italia. Sui 100 o 150 mila miliardi che la mafia somministra annualmente alle banche e alla borsa, è meglio sorvolare. C’è rimasta la proprietà della nostra stessa persona fisica, ma non tutta. Solo dal collo in giù, in quanto il cervello l’abbiamo portato, chi prima e chi poi, tutti all’ammasso toscopadano. Non è vero che Noi eravamo. Noi fummo, anzi fummo stati. Di ciò è rimasta qualche notizia. In verità, più di qualcuna. Del nostro passato antico abbiamo conservato ricordi positivi. E ciò accresce l’amarezza del presente e la tristezza per aver pagato, sofferto, versato il nostro sangue per dei supposti fratelli, rivelatisi gente ingrata, indegna e disonorevole. Per esempio, sappiamo parecchio sulla storia monetaria dei regni di Napoli e di Sicilia, e conosciamo abbastanza bene la storia delle nostrane banche, del nostrano credito e degli strumenti cartolari. Un breve excursus potrà essere utile a più d’uno. Nel Napoletano, la scena si apre con i banchi del cambiavalute e va avanti con le banche private, prevalentemente in mano agli ebrei. Non erano costoro i soli usurai presenti a Napoli, c’era anche una schiera di usurai locali e poi moltissimi genovesi. Come altrove, i cambiavalute avevano allargato la loro attività fino a comprendere (uno) il deposito, (due) il giro dei fondi e (tre) il prestito usurario. I cambiavalute, sospinti dalla spontanea inclinazione di chi ha in mano del capitale liquido a volerlo far crescere, si avventurarono in operazioni arrischiate e parecchi banchi fallirono. Ovviamente, quando una di queste private attività subiva un crac, i depositanti perdevano i danari depositati. Fu il viceré spagnolo, duca di Medina, a emanare i primi provvedimenti a garanzia dei creditori, imponendo ai banchieri di dare in cauzione una somma liquida di 40.000 ducati, il cui importo crebbe in appresso per autonoma loro decisione. Fra i numerosi monti, i depositanti accordarono la loro preferenza al Monte di Pietà, il quale, non avendo scopo di lucro, non metteva a rischio i risparmi. I monti di pietà erano istituzioni ecclesiastiche che si prefiggono di combattere l’usura. Raccoglievano donativi e vere donazioni, onde effettuare prestiti su pegno, riscattare, con i profitti, i cristiani caduti in schiavitù dei turchi e per costituire una dote alle fanciulle povere che andavano spose o prendevano i voti. Trattandosi della più importante e popolare di tali istituzioni, il Monte andò costituendosi un capitale di riserva attraverso i lasciti e le cospicue donazioni dei fedeli. Quando un genovese a nome Saluzzo propose la costituzione di un unico banco di deposito per tutto il Regno, i napoletani, presso cui i banchieri genovesi godevano di pessima fama, si opposero fermamente. Seguendo la volontà popolare, il vicerè Medina dichiarò il Monte di Pietà banco pubblico. Siamo nel 1584. Con il trascorrere dei secoli i banchi pubblici divennero sette, poi si restrinsero a quattro e nel 1794 vennero fusi ad opera del primo Ferdinando, che ne depredò i capitali per sostenere la guerra contro gli invasori francesi. I due Napoleonidi che arrivarono sul trono di Napoli, fecero entrambi un tentativo di rifinanziare l’istituzione monopolistica, con scarso successo però. Alla nascita di un Banco delle Due Sicilie, quale realtà modernamente funzionante, si pervenne soltanto intorno al 1825, ad opera del ministro delle finanze de’ Medici. Secondo una ricerca di un gruppo di studio diretto dal professor Luigi De Rosa a Napoli si ebbe, prima che altrove, un tentativo d’emissione di cartamoneta di taglio fisso a corso forzoso. Ma dobbiamo considerare il fatto un tentativo senza seguito. La storia bancaria del Regno napoletano diverge in più di un punto dalla storia bancaria dell’Europa restante, la quale ripercorse sempre e costantemente i tracciati aperti e battuti in Gran Bretagna. Un merito che non fu tutto dell’ambiente napoletano, presso il quale la fiducia costituiva l’ago magnetico del commercio, ma anche, o forse soprattutto, dei viceré spagnoli, che tradussero la morale corrente in regole di affidabilità. Le particolarità furono essenzialmente quattro: la banca pubblica, cosa di cui ho fatto cenno, la fede di credito, la polizza notata fede, il polizzino. Siccome le speculazioni e le falsificazioni degli storici unitari non trovano limiti, riporto testualmente e quasi interamente le voci Fede di credito e Polizza notata fede dell’Enciclopedia Bancaria (cit.). FEDE DI CREDITO 1. La fede di credito è uno dei più antichi titoli bancari e dobbiamo risalire infatti al Medioevo per rintracciarne le origini. In tale epoca, con il maggiore fiorire del traffico, si ebbe un contemporaneo rifiorire del diritto commerciale e gli strumenti del credito si perfezionarono per meglio adattarsi alle esigenze della pratica. In ognuna delle più importanti città italiane fu adottato un caratteristico titolo di credito: a Venezia il contado di banco, a Messina e a Palermo le polizze, a Bologna la polizza bancaria, a Genova i biglietti cartulari del Banco di S. Giorgio, a Milano le cedule di cartulario del Banco di S. Ambrogio. Anche all’estero si ebbero vari titoli di credito con funzioni quasi identiche; e così le quietanze dei Sovrani di Germania, i Kassiers Briefye di Amsterdam, i Brewfinge di Anversa, i mandati del Bancogiro di Amburgo, i viennesi Girozettel e gl’inglesi biglietti d’orefice. Napoli ebbe la fede di credito emessa dai banchi napoletani, il primo dei quali - il Monte di Pietà - sorse nel 1539 allo scopo di sottrarre il popolo all’usura. 2. L’attività del Monte rimase per poco tempo limitata al servizio dei pegni, ma ben presto esso assunse la figura di una vera e propria banca. Da principio i rapporti tra il Banco ed i depositanti erano assai semplici, fondati sulla reciproca fiducia: per i depositi ed i prelevamenti di somme, sia il Banco che il depositante non rilasciava né richiedeva alcun titolo o documento, essendo sufficiente l’annotazione nei libri del Banco. Successivamente, per l’incremento delle operazioni, il Banco cominciò a rilasciare un titolo rappresentativo del danaro e cioè la fede di credito. La fede di credito e le altre operazioni e titoli bancari ad essa connessi (madrefede polizza notata in lede) rispondevano in modo completo alle esigenze degli affari, precorrendo le odierne forme bancarie. Peraltro la fede di credito resta ancora oggi uno dei più caratteristici titoli. 3. La fede di credito ebbe nelle regioni meridionali grandissima diffusione e godette di una illimitata fiducia, sino al punto da essere preferita alla moneta stessa. Esaminando le antiche polizze e fedi conservate negli archivi e specialmente nell’Archivio storico del Banco di Napoli, può facilmente rilevarsi come esse furono usate in tutte le private contrattazioni ed i più svariati negozi giuridici. La fede di credito fu anche molto usata in relazione a vertenze giudiziarie per provare l’eseguito versamento della somma ed ottenere la liberazione di un’obbligazione, con la dimostrazione di avere adempiuto alle condizioni e sotto i vincoli cui eventualmente l’obbligo di pagare era sottoposto. E sia pure molto tempo dopo, il R. D. 1 maggio 1866, n. 2873, disponeva che le fedi di credito e le polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia dovessero essere date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuati rispettivamente nelle Provincie napoletane e siciliane tanto tra l‘Erario ed i privati quanto fra i privati, nonostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale. Ma successivamente con la legge 30 aprile 1874, n. 1920, regolante la circolazione durante il corso forzoso, tale prerogativa fu abrogata, pur continuando i detti titoli ad avere però larga diffusione, essendo adatti a libera circolazione come strumenti di scambio. 4. Sulla natura della fede di credito, prima dell’attuale regolamentazione legislativa contenuta nel R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, diverse opinioni si disputavano il campo, perché alcuni ritenevano che l’emissione di tale titolo avesse il suo fondamento in un’operazione di deposito, altri in un’operazione di mutuo, altri ancora ritenevano che si trattasse di un contratto sui generis. Nessuna di queste opinioni era accettabile: infatti non poteva ammettersi la esistenza di un deposito, perchè la proprietà del danaro passava al Banco e l’intestatario della fede non aveva che un diritto di credito. Neanche sotto il profilo del deposito irregolare, la teorica era ammissibile, perché il Banco non s’impegnava alla custodia del danaro, ma accettava le somme per destinarle agl’impieghi che rientravano nei suoi scopi. E neanche il concetto del mutuo poteva condividersi, perché, come sostenne l’Aiello, mancava l’elemento essenziale della prefissione di un termine per la restituzione della somma, che poteva invece essere richiesta in un qualunque momento. Ed allora molti ricorrevano alla facile definizione di contratto sui generis. Ma già prima del R. D. 21 dicembre 1933. n. 1736, il De Simone sosteneva che il rapporto tra il Banco ed il portatore della fede di credito dovesse ritenersi come quello corrente tra l’emittente ed il portatore di un titolo all’ordine, escludendo che si trattasse di un titolo nominativo o di un titolo al portatore. Ora il citato decreto ha con esatta definizione dichiarato legislativamente che la fede di credito è un titolo all’ordine trasmissibile per girata semplice o condizionata, e pertanto ogni precedente discussione può dirsi chiusa. Non è qui il caso di esaminare la natura del rapporto dipendente dal titolo all’ordine in genere, ma è certo che il diritto di credito s’incorpora nel titolo ed è da esso inseparabile e cioè inesistente senza il titolo. 5. La funzione della fede di credito è intimamente dipendente dalla sua natura: vale quindi in tutti i casi in cui si debba fare uso di un titolo di credito al pari del vaglia cambiario o dell’assegno circolare. Accanto a tale uso semplice, vi è però quello ben più importante che deriva dalla possibilità, della girata condizionata o causale. Pertanto in tutti i casi nei quali si debba effettuare un pagamento sottoposto a condizione, la fede di credito è indispensabile ed insostituibile. Così nei negozi di vendita o di mutuo, in cui il pagamento del prezzo o la somministrazione è normalmente subordinata ad esecuzione di formalità ipotecarie o ad accertamenti similari; così allorché il danaro debba avere una determinata destinazione ovvero - nei pagamenti a distanza - s’intenda fare risultare l’adesione di colui che incassa a preordinate dichiarazioni. POLIZZA NOTATA IN FEDE Si tratta di un’operazione che il Banco di Napoli ha compiuto fino all’entrata in vigore dell’attuale suo statuto approvato con decreto del Duce del 30 aprile 1938 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio successivo). Anteriormente, la polizza notata si poteva emettere solo presso la sede di Napoli del detto Banco e l’operazione era congegnata nel modo seguente. Una fede di credito, già regolarmente emessa, ma non girata, poteva essere presentata per aprire su di essa un conto corrente senza interesse. La fede di credito in tal modo era convertita in madrefede, la quale era consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l’annullamento della prima fedé di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madrefedi. Per disporre delle somme portate dalla madrefede, l’intestatario di essa poteva trarre sul Banco uno o più ordini di pagamento, presentandoli insieme alla madrefede. L’ordine di pagamento sottoscritto dall’intestatario, con specifico riferimento al danaro esistente sulla madrefede, poteva indicare le condizioni con le quali si intendeva che la somma dell’ordine fosse pagata. L’ordine di pagamento era inoltre avvalorato con le parole notata in madrefede.... per lire..., ed in tal modo l’ordine assumeva il nome di polizza notata in lede trasmissibile per girata ed era restituito all’esibitore insieme alla madrefede. Come si rileva a prima vista, questa antica operazione del Banco precorreva le moderne forme di conto corrente, in quanto la conversione della fede di credito in madrefede sostituiva a tutti gli effetti l’odierno versamento in c/c, e la emissione della polizza notata in fede aveva la funzione vera e propria di un assegno bancario avvalorato. E’ da aggiungere però che questo titolo, ricollegandosi alla peculiare caratteristica della fede di credito da cui aveva origine, era trasmissibile per girata non solo semplice, ma anche condizionata […]. Per completezza, dobbiamo far notare inoltre che sulla madrefede poteva trarsi anche - con o senza clausole o condizioni - un mandato complessivo cioè un ordine di pagamento a favore di più persone. Il mandato era avvalorato come la polizza notata ma non era rilasciato alla parte; era invece ritenuto dal Banco, il quale apriva un conto a ciascuna delle persone a favore delle quali la somma doveva essere pagata. In relazione al mandato complessivo, il Banco avvalorava poi i mandati, che erano gli ordini di pagamento a favore di ciascuna delle persone indicate nel mandato. I mandatini non erano però trasmissibili per girata: servivano di quietanza al Banco, quando venivano pagati.
Nicola Zitara